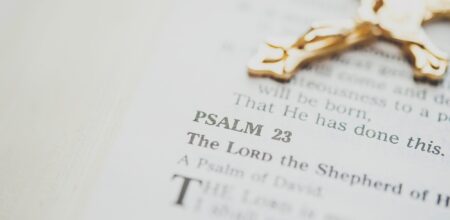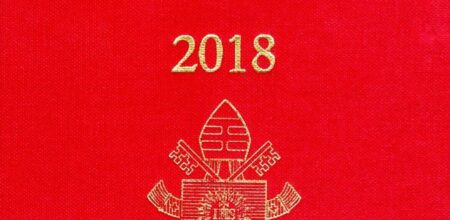|
|
Il lavoro è un tema centrale nel pontificato di Francesco, il quale, nell’Evangelii gaudium (EG)lo qualifica con quattro termini: «libero, creativo, partecipativo e solidale» (EG 192)1. Si tratta di un’esplicitazione programmatica e fondativa, che Bergoglio aveva già utilizzato a Buenos Aires, nel giugno 2003, per commentare l’enciclica di san Giovanni Paolo II sul lavoro, la Laborem exercens (14 settembre 1981).
Per approfondire il tema del lavoro in una prospettiva universale ci siamo rivolti al card. Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale. Il suo ruolo nella Chiesa e la sua esperienza ne certificano l’autorevolezza: nato a Wassaw-Nsuta l’11 ottobre 1948, egli è il primo cardinale oriundo del Ghana; ordinato arcivescovo metropolita di Cape Coast nel 1993, è stato presidente della Conferenza episcopale dei vescovi del Ghana (1997-2004), relatore al Sinodo dei vescovi per l’Africa (2009) e presidente del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace (2009-2016).
Eminenza, per la Scrittura il lavoro è la partecipazione dell’uomo all’«atto creatore» di Dio. Come è definita la dignità del lavoro e del lavoratore nella dottrina sociale della Chiesa?
L’Antico Testamento presenta Dio come Creatore onnipotente, che plasma l’uomo a sua immagine e lo invita a lavorare la terra e a custodire il giardino dell’Eden, in cui lo ha posto. Dio invita l’uomo a coltivare e custodire i beni da lui creati e che l’uomo ha ricevuto come dono prezioso posto dal Creatore sotto la sua responsabilità. Il lavoro appartiene alla condizione originaria dell’uomo e precede la sua caduta; non è perciò né una maledizione né una punizione. Esso diventa fatica e pena a causa del peccato di Adamo ed Eva, che spezzano il loro rapporto fiducioso e armonioso con Dio. Il lavoro, quindi, fa parte del disegno di Dio per l’uomo sin dalla creazione ed è parte integrante della dignità umana.
Quando si parla di dignità del lavoro, si deve fare un passo indietro e considerare la dignità del lavoratore, che è l’artefice del lavoro stesso. La dottrina sociale della Chiesa riconosce nel lavoro una componente oggettiva, data dall’attività lavorativa posta in essere, e una componente soggettiva, definita dalla persona umana del lavoratore. La dimensione soggettiva del lavoro deve avere la preminenza su quella oggettiva, perché chi la pone in essere è l’uomo stesso. Il soggetto dell’attività lavorativa è, infatti, la persona umana – creata a immagine e somiglianza di Dio, come unità di corpo e anima, unica e irripetibile – e, nella misura in cui la dignità della persona lavoratrice è rispettata nel contesto lavorativo, si può parlare di un lavoro «degno e umano» o, al contrario, «indegno e disumano». Nella Caritas in veritate (CV) Benedetto XVI definiva il lavoro «decente» come «un lavoro che, in ogni società, sia l’espressione della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni donna: un lavoro scelto liberamente, che associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne, allo sviluppo della loro comunità» (CV 63).
Oggi, quali sono gli ostacoli sociali e politici che, secondo la Chiesa, impediscono al lavoro di essere «degno»?
Come è stato ricordato da papa Francesco nel suo videomessaggio alla 48a Settimana sociale dei cattolici italiani2, «non tutti i lavori sono degni». Ci sono, infatti, lavori che umiliano la dignità delle persone: quelli che nutrono le guerre con la costruzione di armi, che svendono il valore del corpo con il traffico della prostituzione e che sfruttano i minori. Offendono la dignità del lavoro anche il lavoro in nero, quello gestito dal caporalato, i lavori che discriminano la donna e non includono i portatori di disabilità. Di recente, ho partecipato, a Taiwan, al XIV Congresso mondiale dell’apostolato del mare, dove è emerso il fatto che su un grande numero di navi ci sono persone che lavorano in condizioni quasi di schiavitù: lavorano per lunghi periodi a bordo senza avere la possibilità di scendere a terra; vengono pagate non adeguatamente e vivono in precarie condizioni di salute. Per questo abbiamo invitato i governi a fare maggiori controlli sulle navi quando giungono nei porti dei diversi Paesi, per assicurare, in tal modo, che ai lavoratori siano effettivamente garantite condizioni dignitose.
La dottrina sociale della Chiesa è diventata magistero a partire dall’enciclica «Rerum novarum» (1891) di Leone XIII per opporsi allo sfruttamento dei lavoratori, ai bassi stipendi e per combattere il lavoro minorile. Dopo la recente crisi economica che ha compromesso la vita di molti lavoratori, verso quale direzione occorre impegnarsi?
La concezione dell’uomo dominante nella visione economica degli ultimi decenni – che è culminata nella crisi finanziaria ed economica del 2007-2008, dalla quale ci stiamo lentamente e con molta fatica risollevando – ha invertito l’equilibrio tra la dimensione oggettiva e soggettiva del lavoro. Prioritario nel mondo della finanza era il raggiungimento dell’efficienza, del risultato, del profitto nel più breve tempo possibile; secondari gli orari di lavoro, la pressione, le responsabilità, anche penali, che finivano per gravare sugli operatori finanziari e sui lavoratori. Il lavoratore veniva considerato uno strumento, un mezzo per il raggiungimento del fine ultimo del profitto. All’origine della crisi finanziaria che abbiamo attraversato c’è dunque una profonda crisi antropologica: c’è la negazione del primato dell’essere umano, come ci ha ricordato papa Francesco nell’Evangelii gaudium (n. 55).
Le conseguenze della grave crisi economica e finanziaria sono state molto pesanti sul mondo del lavoro, con un aumento generale – in particolare in Italia – del tasso di disoccupazione giovanile e degli over 50. Di fronte a questa situazione, che si potrebbe definire di «emergenza occupazionale», le scelte politiche dovrebbero essere finalizzate a riportare al centro del mondo lavorativo la dignità della persona umana, a favorire l’innovazione imprenditoriale, soprattutto quella giovanile, l’alternanza scuola-lavoro, gli investimenti infrastrutturali e un sistema finanziario chiamato a sostenere l’economia reale e non a intraprendere operazioni finanziarie rischiose e fini a se stesse. Per rilanciare la crescita economica e i consumi occorre sostenere il lavoro con politiche adeguate.
Per essere coerenti tra i princìpi che professiamo e la testimonianza che viviamo, come promuovere il lavoro degno anche come Chiesa e nella Chiesa?
Certamente la Chiesa ha un ruolo importante nella promozione del lavoro degno, e può esercitare questa funzione a vari livelli. In primo luogo, diffondendo la concezione del lavoro propria della sua dottrina sociale, che ritiene il lavoro un actus personae, un’espressione essenziale dell’essere persona. O meglio, con il lavoro la persona, che nella concezione cristiana è aperta al trascendente, si sente partecipe del processo creativo di Dio. Ciò che dà dignità al lavoro è l’atto del creare e il contributo che il lavoratore può offrire al processo creativo. Dio ha creato gli alberi, ma non i mobili: questo è un compito che spetta all’uomo e al suo ingegno.
Primo Levi raccontava di un muratore italiano – che ad Auschwitz gli aveva salvato la vita –, il quale, pur nella prigionia e nella schiavitù, quando doveva tirar su muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza, ma per dignità professionale. È connaturata nell’uomo e nella sua vocazione di lavoratore l’esigenza di fare bene il proprio lavoro; è il lavoro in sé che deve essere fatto bene, perché attraverso il lavoro l’uomo costruisce se stesso, la sua identità e la sua dignità sociale.
Nel 1981, nella Laborem exercens (LE), Giovanni Paolo II ha affermato che «mediante il lavoro l’uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, ma anche realizza se stesso come uomo, anzi, in un certo senso, “diventa più uomo”» (LE 9). L’uomo, dunque, non può vivere senza lavoro, perché il lavoro è ciò che gli consente di realizzare la pienezza della propria dignità umana, ed è per questo che nel magistero sociale dei Papi il lavoro è trattato come parte integrante della dignità dell’uomo.
In secondo luogo, la Chiesa deve svolgere una funzione di denuncia dei contesti lavorativi in cui non ci sono condizioni di lavoro che possano definirsi «degne»; di denuncia di tutto ciò che umilia il lavoro e lo nega; di denuncia della cultura dello scarto, per usare le parole di Francesco. Il Compendio della dottrina sociale della Chiesa (CDS) afferma che la dottrina sociale comporta anche un compito di denuncia. Tale denuncia diventa giudizio e difesa dei diritti disconosciuti e violati, specialmente dei diritti dei poveri, dei piccoli, dei deboli (cfr CDS 81). Al tempo stesso, la Chiesa deve farsi promotrice di buone iniziative in tal senso. Sono degne di nota tutte quelle che a livello nazionale, diocesano e parrocchiale la Chiesa italiana pone in essere per favorire l’occupazione giovanile e sostenere l’innovazione.
Infine, il lavoro degno va promosso anche nella Chiesa, che è un’importante datrice di lavoro in Italia così come nel resto del mondo (in Australia, per esempio, la Chiesa cattolica è la seconda datrice di lavoro dopo lo Stato). Quindi, è importante assicurare una giusta remunerazione a tutti coloro che lavorano nelle diocesi, nelle parrocchie e, più in generale, nelle strutture della Chiesa cattolica. Dal 1° gennaio 2017 sono alla guida di un nuovo Dicastero della Curia romana che accorpa in sé quattro ex Pontifici Consigli con tutti i loro dipendenti. Il processo di ristrutturazione e di riorganizzazione del nuovo ufficio si sta rivelando particolarmente laborioso e lento, proprio per il desiderio di dare priorità alle persone che in esso lavorano, affidando a ciascuno gli incarichi più consoni e cercando di evitare di ferire la dignità dei lavoratori.
Quale rapporto c’è tra lavoro e giustizia? Ci sono lavori che vengono mal pagati. E ancora: come è possibile contrastare la corruzione che inquina il mondo del lavoro?
La remunerazione è sicuramente un importante strumento per realizzare la giustizia nei rapporti di lavoro: il giusto salario è lo strumento che permette al lavoratore e ai suoi familiari di vivere una vita dignitosa, di accedere ai beni materiali, sociali, culturali e spirituali. Ogni lavoratore dovrebbe godere di una remunerazione che, oltre al proprio sostentamento, consenta anche di poter investire sul suo sviluppo umano integrale.
Inoltre, nel caso in cui il lavoratore si configuri come un padre o una madre di famiglia, il salario giusto dovrebbe conferirgli anche i mezzi economici per promuovere lo sviluppo integrale dei figli, garantendo loro, in particolare, la possibilità di studiare e di formarsi come persone e come lavoratori. Nella descrizione del lavoro dignitoso che Benedetto XVI ci offriva nella Caritas in veritate si parla di «un lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle famiglie e di scolarizzare i figli, senza che questi siano costretti essi stessi a lavorare […]; un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello personale, familiare e spirituale; un lavoro che assicuri ai lavoratori giunti alla pensione una condizione dignitosa» (CV 63).
Senza dubbio lasciano perplessi e sollevano interrogativi morali gli enormi stipendi che vengono offerti ai manager, ai calciatori, ai conduttori televisivi ecc., soprattutto se confrontati con gli stipendi bassi di operai e, in generale, della manodopera meno qualificata.
Come possiamo definire la meritocrazia? Può essere sufficiente – come antidoto alla corruzione nel mondo del lavoro – definire criteri chiari di crescita professionale e uguali opportunità di accesso, in particolare per le donne?
La corruzione nel mondo del lavoro si può, a mio avviso, contrastare con la meritocrazia, dando maggiore valore, nell’ambito della crescita lavorativa, ai meriti e alla qualità del lavoro svolto dal lavoratore. Tuttavia, anche il criterio della meritocrazia non va accentuato, come ad esempio in Giappone, dove la ricerca di meriti porta le persone, a volte, a togliersi la vita, perché non si sentono in grado di raggiungere gli standard e i requisiti richiesti dalla società e dal mondo scolastico e lavorativo. In questo caso, il merito diventa qualcosa di negativo nella vita della persona. Inoltre, per contrastare la corruzione nel mondo del lavoro può rivelarsi utile stabilire criteri chiari di crescita professionale, di carriera (anzianità di servizio, responsabilità del lavoratore, spirito di iniziativa, capacità di lavorare in gruppo, di formare e guidare altri lavoratori ecc.).
Alcuni studi, tra cui uno della World Bank, sostengono che la presenza femminile nel mondo del lavoro assicura livelli inferiori di corruzione nell’ambito lavorativo. Anche per ridurre il livello di corruzione, sembra dunque auspicabile garantire alle donne uguali diritti e opportunità di accesso al mondo del lavoro. Sicuramente un ambiente lavorativo più equilibrato, per quanto concerne la presenza di donne e uomini, potrebbe, a mio avviso, abbassare il livello di competitività, come pure la propensione alla corruzione. Inoltre, l’accesso della donna al mondo del lavoro può rivelarsi, nel caso dell’Italia, anche un importante fattore per contrastare il forte calo demografico. Durante la III Conferenza nazionale sulla famiglia, organizzata alla fine del mese di settembre 2017 in Campidoglio, a Roma, si è affermato che la partecipazione attiva delle donne al mondo del lavoro – insieme ad adeguate politiche di maternità, paternità e sostegno alle famiglie – costituisce un fattore di sicurezza determinante per l’apertura alla vita da parte delle giovani coppie.
Il mondo economico e finanziario si è fatto provocare dal pensiero della Chiesa in tema di lavoro? Di cosa ha fatto tesoro?
Nell’enciclica Laudato si’ (LS) il Papa esorta il mondo finanziario ed economico a guardare oltre l’utile economico e il profitto, e a cercare forme di orientamento al bene comune. Come prefetto di un Dicastero della Curia romana, ho la viva percezione di un progressivo aumento di iniziative a livello imprenditoriale e finanziario volte a promuovere lo sviluppo sociale e ambientale, di una progressiva apertura a forme di attività economica caratterizzate da quote di gratuità e di comunione, così come è auspicato da Benedetto XVI nella Caritas in veritate.
La crisi finanziaria e poi economica, iniziata nel 2008, ha favorito la consapevolezza dell’esigenza di una più ampia «responsabilità sociale» dell’impresa: «Si va sempre più diffondendo il convincimento in base al quale la gestione dell’impresa non può tenere conto degli interessi dei soli proprietari della stessa, ma deve anche farsi carico di tutte le altre categorie di soggetti che contribuiscono alla vita dell’impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori dei vari fattori di produzione, la comunità di riferimento» (CV 40).
Al tempo stesso, la crisi ha accelerato un ripensamento dei modelli di sviluppo del mercato in favore di forme nuove di impresa, di forme intermedie tra il pubblico e il privato, delle imprese sociali che non escludono il profitto ma lo considerano uno strumento per realizzare finalità umane e sociali, quali ad esempio l’inserimento di persone svantaggiate nel mercato del lavoro. L’ex Pontificio Consiglio della giustizia e della pace ha in passato riflettuto con due Convegni internazionali sull’impact investing, sulla cosiddetta «finanza sociale» che investe nelle imprese a forte impatto sociale anche a costo di una minore remunerazione del capitale.
Nella «Laudato si’» il lavoro è diventato una questione ambientale.
Qualsiasi forma di lavoro presuppone un’idea sulla relazione che l’essere umano può o deve stabilire con l’altro da sé. Il lavoro deve, dunque, tenere in debita considerazione la sua interazione con la società e con l’ambiente circostante. Per esempio, non di rado l’ambiente non viene considerato dall’impresa e dal lavoro umano un fattore da tutelare e da perfezionare, ma piuttosto un ambito da sfruttare, con distruzione delle risorse a danno dei più deboli e bisognosi. Nell’enciclica Laudato si’ papa Francesco afferma che proprio il lavoro è l’espressione massima di quell’agire che dovrebbe essere sempre mosso dal principio della cura e mai dello sfruttamento. L’uomo deve aver cura dell’ambiente nel quale colloca le proprie attività produttive; tra l’uomo e l’ambiente si dovrebbe, in un certo senso, instaurare un rapporto di scambio reciproco: la terra si prende cura dei bisogni dell’uomo, e l’uomo deve prendersi cura del benessere del creato e della terra. L’obiettivo è che l’uomo mantenga il «giardino» così come il Signore glielo ha donato, senza renderlo un deserto.
Lo studio dell’impatto ambientale deve precedere l’elaborazione di ogni progetto produttivo e tenere in debita considerazione le condizioni di lavoro e i possibili effetti sulla salute fisica e mentale delle persone, sull’economia locale, sull’ambiente, sulla sicurezza e così via. «La protezione dell’ambiente dovrà costituire parte integrante del processo di sviluppo e non potrà considerarsi in maniera isolata» (LS 141).
L’ industria 4.0 sta cambiando il paradigma antropologico del lavoro, che è sempre più interconnesso da una parte all’altra del mondo e delocalizzato. Nel tempo delle macchine e dei robot, quale significato assumerà il lavoro per la vita degli uomini?
Nel contesto della quarta rivoluzione industriale, di quella che è definita Industry 4.0 – che riguarda gli sviluppi dell’intelligenza artificiale, le nanotecnologie, le biotecnologie e il digitale e le loro applicazioni nel mondo del lavoro –, occorre riportare l’attenzione sulla visione antropologica cristiana in base alla quale l’uomo è chiamato a rimanere il soggetto della tecnologia, e non l’oggetto3. Il dispositivo tecnologico è e resta frutto della sua intelligenza. Come è stato affermato da Paolo VI nella Populorum Progressio (PP), «economia e tecnica non hanno senso che in rapporto all’uomo ch’esse devono servire» (PP 34).
La tecnica in sé non è né buona né cattiva: tutto dipende dall’utilizzo che se ne fa. Tutto dipende dal fatto che essa venga posta al servizio dello sviluppo umano integrale, dello sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. In caso contrario, come ci ha ricordato Benedetto XVI nella Caritas in veritate, la tecnica rischia di trasformarsi in uno strumento di distruzione dell’uomo. Di qui la necessità della priorità dell’etica sulla tecnica, del primato della persona sulle cose, della superiorità dello spirito sulla materia.
Di fronte all’utilizzo delle macchine, dei robot e delle nuove tecnologie, diventa fondamentale discernere fra il bene e il male, comprendere se l’uso di tali dispositivi vada o meno a vantaggio dell’uomo e del suo sviluppo umano integrale. In caso affermativo, fra sviluppo umano e tecnologia si stabilisce un circolo virtuoso che funziona nei due sensi: se l’innovazione tecnologica favorisce lo sviluppo umano e lo sviluppo economico, accrescendo la produttività degli operai e l’efficienza dei fornitori di servizi e delle piccole aziende, lo sviluppo umano, a sua volta, è un importante strumento per lo sviluppo della tecnologia, che è espressione del potenziale umano, della creatività umana.
Il ruolo della Chiesa è sicuramente quello di aiutare la comunità degli uomini nell’opera di discernimento, mettendoli in guardia anche davanti alle possibili derive del paradigma tecnologico, quali, in particolare, l’asservimento dell’uomo alla tecnica e l’utilizzo delle nuove tecnologie a danno dell’uomo stesso.
Gli studi sull’impatto delle nuove tecnologie digitali e delle macchine intelligenti sul mondo del lavoro e sull’occupazione sono contrastanti: accanto alle previsioni «catastrofiche» del World Economic Forum (contro i 2 milioni di posti di lavoro creati grazie alle nuove tecnologie, se ne perderebbero circa 7), ci sono quelle più possibiliste dell’Ocse e dell’Unctad. Comunque sia, resta il problema di un prevedibile ulteriore aumento delle disuguaglianze, nei redditi e anche a causa delle tendenze del lavoro in generale. Questo, infatti, sembra assumere la forma di una clessidra: si riduce la classe media per la diminuzione di alcuni tipici lavori di ufficio che ora possono essere svolti dalle macchine; restano a monte i creativi, in grado di innovare e di padroneggiare le tecnologie, mentre rimangono a valle una serie di basse qualifiche.
Davanti a questa situazione, si rivelano necessari provvedimenti su più fronti: da una parte, quello di politiche fiscali redistributive, che riescano a tassare la nuova ricchezza (di cui una parte crescente è appannaggio dei proprietari delle macchine) anche a livello internazionale, e quello di una governance dell’innovazione tecnologica attraverso organismi e istituzioni adeguate; dall’altra, quello di un cambiamento culturale che tenga conto della necessità di trasformazione e sostituzione, più rapida che nel passato, di vecchie occupazioni con nuove. Di qui la necessità di incoraggiare la capacità di adattarsi al cambiamento, e di creare, dov’è possibile, un’alleanza con la tecnologia, considerandola per quello che veramente è: un supporto, e non un sostituto dell’uomo. In futuro dovremo probabilmente imparare a convivere con i robot, assegnando a queste nuove macchine attività che richiedono un’elevata velocità e meccanicità, lasciando invece alla persona umana le attività che richiedono l’uso della ragione, del discernimento e dell’intelletto, caratteristiche proprie dell’uomo.
L’ Occidente vive di una paura: crede che i flussi migratori possano rubare il lavoro ai cittadini europei o che il lavoro venga pagato sempre meno. Cosa può dirci su questo punto?
Si tratta di affermazioni che vanno ridimensionate. Non si può dire in modo semplicistico che gli immigrati rubino il lavoro ai cittadini europei. È più corretto dire che svolgono mansioni che spesso e volentieri i cittadini europei non sono più disposti a svolgere.
Il fatto è che l’entrata nel mercato del lavoro degli immigrati – disposti ad accettare stipendi più bassi – ha portato a una svalutazione del costo del lavoro e, dunque, al fatto che certe funzioni vengano effettivamente pagate meno. Ancora prima dell’emergenza migratoria degli ultimi anni, le imprese, al fine di massimizzare il profitto, sono andate esse stesse alla ricerca del lavoro a basso costo nei Paesi più poveri e hanno delocalizzato lì le loro attività, o parte di esse, per sfruttare il vantaggio comparato della forza lavoro meno costosa, con evidenti ripercussioni sull’occupazione nei Paesi europei, in particolar modo per i lavoratori meno qualificati.
La soluzione – che è anche un imperativo morale – alla svalutazione del costo del lavoro è quella di migliorare le condizioni di vita degli ultimi, dei lavoratori a basso costo nei Paesi in via di sviluppo e degli immigrati nei nostri Paesi, con una remunerazione più adeguata, un giusto salario. Solo così si potrà assicurare a tutti i lavoratori un lavoro rispettoso della dignità umana.
Podcast | MORTI SUL LAVORO. «LA PIÙ GRANDE TRAGEDIA CIVILE DEL PAESE»
Ogni anno, in Italia, più di mille persone muoiono sul proprio posto di lavoro. Circa tre lavoratori ogni giorno. Un «bollettino di guerra», così come lo ha definito papa Francesco nel 2023, i cui numeri risultano ancora più elevati rispetto a quelli delle vittime del crimine organizzato o dei femminicidi. Ne parliamo con Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione, e Alberto Verzulli dell’Anmil.
Quali parole di speranza si sente di lasciare, specialmente ai giovani che non trovano lavoro?
La mia vicinanza va a tutti i giovani disoccupati, a coloro che non studiano e non cercano lavoro perché hanno perso la fiducia nella possibilità di trovarne uno. A questi giovani io posso dire di non arrendersi, di continuare a impegnarsi, di studiare, di sacrificarsi, di stimolare il loro spirito di iniziativa e di collaborazione, affinché si sviluppino nuove idee e nuovi progetti di lavoro. La sfiducia, la mancanza di speranza, secondo me, non devono appartenere alle giovani generazioni, contraddistinte dall’energia, dalla vitalità e dalla fantasia tipica di questa età. La sfiducia e la mancanza di speranza sono sentimenti che le generazioni adulte, avendo incontrato ostacoli e delusioni nel loro inserimento nel mondo lavorativo, possono avere trasmesso ad esse. Quello che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni, invece, è un valore del quale si parla ancora troppo poco: il valore della resilienza, la capacità di far fronte a condizioni avverse senza perdere la speranza, o meglio la virtù cardinale della fortezza. Ecco: giovani, siate forti e siate perseveranti nella ricerca del lavoro e non lasciatevi scoraggiare!
In secondo luogo, occorre richiamare l’attenzione sul fatto che, sebbene il lavoro sia un diritto umano fondamentale, esso è anche un dovere dell’uomo. L’uomo deve lavorare sia perché il Creatore gliel’ha ordinato, sia per rispondere alle esigenze di mantenimento e di sviluppo della sua stessa umanità. Il lavoro si presenta come obbligo morale in relazione al prossimo, che è in primo luogo la famiglia, ma anche la società, alla quale si appartiene, la nazione, della quale si è figli e figlie, l’intera famiglia umana, di cui si è membri. Forse dovremmo insistere nel trasmettere ai giovani – già a partire dall’infanzia, dalla loro formazione in famiglia e nelle scuole – il valore del lavoro, insegnando loro che il lavoro è sì un diritto, ma anche un dovere. Ritengo, dunque, fondamentale l’educazione al «dovere del lavoro», che deve rientrare in una formazione più ampia dei giovani come cittadini. Occorre rafforzare nei giovani il senso di appartenenza alla loro comunità, alla società, alla nazione. Questo sentimento di appartenenza è, infatti, affievolito nei giovani dalla globalizzazione e dagli strumenti tecnologici – quali gli smartphone, i tablet, i computer ecc. –, che li «isolano» dalla realtà circostante e li connettono a un mondo virtuale che esiste solo nella rete.
Di fronte alla sfida contemporanea dell’inserimento nel mondo lavorativo, i giovani non vanno lasciati soli: devono essere accompagnati dalle famiglie, dalla scuola, dalle parrocchie e dalla società. Essi vanno accompagnati a discernere la propria vocazione al lavoro, a scoprire la dimensione spirituale del lavoro e a guardare al lavoro come a una missione, alla propria missione nella vita. Al tempo stesso, tuttavia, è responsabilità degli adulti indirizzare i giovani, compatibilmente con le loro aspirazioni e capacità, verso quelle professioni per le quali esiste una domanda di lavoro sul mercato. Di qui l’importanza dell’alternanza scuola-lavoro, affinché la scuola sia effettivamente un investimento per il mondo del lavoro e un trampolino di lancio per l’inserimento in esso. I giovani vanno accompagnati anche nei momenti di passaggio verso la scuola superiore: finite le scuole medie, vanno orientati verso le diverse possibilità formative successive, e indirizzati secondo le potenzialità di ciascuno. In effetti, l’elevato tasso di disoccupazione giovanile in Italia mette in discussione anche il sistema educativo del Paese. Per rispondere all’emergenza occupazionale sarebbe opportuna una riforma del sistema educativo, affinché esso sia maggiormente orientato a rispondere alla domanda di lavoro presente nel territorio italiano e nel resto del mondo.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2018
Riproduzione riservata
***
1. Sui temi dell’intervista, cfr anche F. Occhetta, Il lavoro promesso. Libero, creativo, partecipativo e solidale, Milano – Roma, Àncora – La Civiltà Cattolica, 2017.
2. Cfr Id., «La 48a Settimana sociale dei cattolici italiani», in Civ. Catt. 2017 IV 370-377.
3. Cfr Id., «Il lavoro 4.0», in Civ. Catt. 2017 I 481-491.