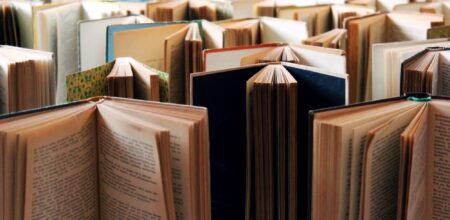|
|
Il 14 maggio di quest’anno ricorreva l’anniversario della fondazione dello Stato di Israele, avvenuta nel 1948 in ottemperanza alla risoluzione delle Nazioni Unite del 29 novembre 1947, che stabiliva la nascita, nel territorio della Palestina, ex mandato inglese, di due Stati indipendenti e sovrani: quello ebraico e quello palestinese. Questa risoluzione, a causa dell’opposizione dei Paesi arabi alla cosiddetta «spartizione», non è stata mai attuata. Nella ricorrenza di tale anniversario, il presidente Donald Trump ha voluto che avvenisse il trasferimento dell’ambasciata degli Stati Uniti – come aveva unilateralmente dichiarato il 6 dicembre 2017[1] – da Tel Aviv a Gerusalemme. Questa decisione, oltre ad avere un forte significato simbolico, ha anche una grande rilevanza politica, in quanto si oppone all’indirizzo finora seguito su questa delicata materia dalla gran parte della comunità internazionale in ottemperanza alle varie risoluzioni delle Nazioni Unite, che per Gerusalemme Est intende mantenere per il momento lo status quo, in attesa di decisioni concordate.
Occorre anche notare che il giorno successivo, il 15 maggio, il mondo arabo ha ricordato il settantesimo anniversario della cosiddetta Nakba (catastrofe): in questa occasione si fa memoria dell’espulsione – in seguito alla guerra arabo-israeliana del 1948-49 – di circa 500.000 (secondo altri, più di 700.000) palestinesi dalle loro case e dalla loro terra, costretti a cercare asilo in Paesi limitrofi[2]. Questo evento è stato ricordato, come tutti gli anni, nella Striscia di Gaza con diverse manifestazioni, che sono iniziate il 30 marzo e si sono tenute nei pressi della frontiera con Israele[3]. Ciò ha dato origine a scontri tra le due parti: l’esercito israeliano in diverse occasioni ha risposto aprendo il fuoco contro i manifestanti che tentavano di oltrepassare il reticolato di confine, e questo ha provocato la morte di 49 persone, tra cui due giornalisti, e il ferimento di almeno altre 1.500 persone.
Questi avvenimenti cadono in un momento molto delicato per il Governo israeliano, impegnato a impedire che la Siria diventi una «terra di conquista» dei pasdaran iraniani e degli Hezbollah sciiti, da dove poter minacciare la sicurezza di Israele. Secondo gli analisti, ciò spiega i frequenti bombardamenti di obiettivi militari iraniani in Siria – di solito non rivendicati – operati negli ultimi mesi dall’artiglieria e dall’aviazione israeliane.
In ogni caso, il recente trasferimento dell’ambasciata Usa a Gerusalemme ha certamente una rilevanza storica. Le vicende degli ultimi decenni dimostrano come il problema della «Città santa» e quello riguardante la soluzione del conflitto israelo-palestinese siano strettamente legati e interdipendenti, e questo fatto non può essere ignorato, né tantomeno sottovalutato.
La decisione di Trump di trasferire l’ambasciata, inoltre, ha avuto come risultato non voluto quello di sottoporre nuovamente all’interesse della comunità internazionale e dell’opinione pubblica il problema di Gerusalemme, dopo che negli ultimi anni, a causa della lotta contro l’Isis e il terrorismo islamico, non se ne parlava quasi più[4]. Anche i «nuovi jihadisti», infatti, a differenza di al-Qaeda, nella loro propaganda politica hanno in qualche modo «derubricato» la questione palestinese (che per decenni aveva agitato il mondo arabo), ritenendola non più fondamentale per l’unità del mondo musulmano.
Gerusalemme città sacra delle tre religioni monoteiste
Gerusalemme (in arabo al-Quds) è città sacra per le tre grandi religioni abramitiche – l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam –, alle quali fanno riferimento circa tre miliardi di persone nel mondo. Per gli ebrei, è il luogo dove si trova il loro tempio, la dimora di Dio. Anche se esso fu completamente distrutto dai romani nel I secolo d.C., e l’intero popolo ebraico fu costretto alla diaspora. Ogni volta che gli ebrei venivano cacciati dalla loro patria, il loro sogno era di ritornare a Gerusalemme; da qui l’augurio che gli ebrei della diaspora si scambiavano da secoli per la festa di Pesach: «L’anno prossimo a Gerusalemme», riaffermando la centralità di questa città nella loro vita.
Gerusalemme è città santa anche per i cristiani di tutte le confessioni. Infatti, in essa si sono svolti i fatti decisivi della vita di Gesù Cristo. In questa città si trovano alcuni fra i più importanti luoghi di culto della cristianità, come ad esempio la basilica costantiniana del Santo Sepolcro, oggi divisa tra ortodossi, cattolici, armeni, copti e altre confessioni cristiane. Dopo la dolorosa e controversa esperienza delle crociate, nel XIV secolo fu istituita – e riconosciuta dal Sultano – la «Custodia di Terra Santa», alla quale era affidata la tutela dei Luoghi Santi, e non soltanto di Gerusalemme. Essa è ancora affidata ai frati francescani e ha un certo riconoscimento in ambito internazionale.
Per i musulmani di tutto il mondo, sia sunniti sia sciiti, Gerusalemme è la terza città santa, dopo Mecca e Medina. È la città da dove (precisamente dal luogo dove oggi si trova la moschea di Omar o Cupola della Roccia) il profeta Maometto – secondo una tradizione medievale – è asceso al cielo per parlare con Dio. In questo stesso luogo si trova una delle più antiche e venerate moschee dell’islam, «quella più lontana», cioè al-Aqsa.
Tutti questi luoghi, carichi di grande significato religioso per le tre fedi abramitiche – cosa unica al mondo –, si trovano in un raggio spaziale non superiore al chilometro quadrato. Due di questi – cioè il luogo santo degli ebrei e le moschee dell’islam – sono ubicati nello stesso spazio fisico, cioè la grande Spianata del Tempio. Per gli ebrei osservanti è vietato calpestare il luogo dove era ubicato il Santuario, lo spazio più interno del Tempio, il Sancta Sanctorum; e poiché non se ne conosce l’esatta ubicazione, la proibizione vale per l’intera Spianata.
Dal canto loro, i musulmani nei secoli passati hanno esteso a tutta la Spianata lo spazio del recinto sacro, definendolo al-Haram al-sharif («il nobile santuario»). L’unica parte rimasta alla venerazione degli ebrei è il cosiddetto «Muro del Pianto» o muro occidentale (che era un muro di sostegno, risalente all’epoca del Secondo Tempio), davanti al quale, in occasione della «Guerra dei sei giorni» del 1976 (quando gli israeliani occuparono buona parte di Gerusalemme Est), fu realizzata una grande piazza, per rendere più agevole il culto, eliminando un fatiscente quartiere arabo. Non lontano da questi luoghi si trova la «Via dolorosa», che porta alla basilica del Santo Sepolcro.
A motivo dell’importanza che Gerusalemme ha per le tre grandi confessioni religiose, quello che avviene in questa città ha ripercussioni internazionali. Il più piccolo errore nella gestione dei luoghi di culto può provocare gravi conflitti, come di fatto è accaduto nel passato recente tra arabi e israeliani. Gerusalemme è come una polveriera che può esplodere in ogni momento, mandando in frantumi uno status quo accolto e contestato allo stesso tempo dalle comunità che la abitano. In ogni caso, il conflitto israelo-palestinese non sarà mai risolto fino a quando non si troverà una soluzione condivisa su Gerusalemme.
Eppure il sionismo, che dalla fine del XIX secolo ha dato avvio al movimento di ritorno degli ebrei della diaspora in Palestina con l’obiettivo di costruirvi uno Stato «autenticamente ebraico», aveva posto ai margini della sua propaganda politica e ideologica la sacralità della città di Gerusalemme. Esso era un movimento filo-europeo e laico, che sposava le idealità della sinistra e considerava Gerusalemme un relitto del passato, una città «bigotta, superstiziosa e improduttiva», lontana dalle vie commerciali del Medio Oriente e circondata da un territorio arido e povero di risorse materiali.
Va però anche ricordato che i nuovi arrivati dall’Europa, oltre alle idee di progresso e di civiltà – dichiarandosi ora socialisti ora liberali –, portarono nel nuovo Paese anche il fanatismo religioso e settario (che di solito considera il ghetto come una fortezza), il nazionalismo militarista e tutte le sue rivendicazioni pseudo-imperialiste. «Mentre – secondo lo scrittore israeliano Amos Oz – sono stati proprio gli immigrati d’Oriente (ebrei sefarditi e altri) a portare qui con sé un antico patrimonio di moderazione, di relativa tolleranza religiosa e di abitudine a vivere in un regime di buon vicinato anche con chi non ti assomiglia»[5].
Gerusalemme e la fondazione dello Stato di Israele
Quando, il 29 novembre 1947, l’Onu approvò, con la risoluzione n. 181, il progetto di spartizione della Palestina (che fino ad allora era stata sotto il mandato britannico) in due Stati autonomi e indipendenti – uno arabo e l’altro ebraico –, i capi sionisti del tempo si affrettarono ad accettare il piano delle Nazioni Unite, e il 14 maggio 1948, in una sala del museo di Tel Aviv – che divenne la capitale del nuovo Stato nazionale – David Ben Gurion dichiarò l’indipendenza dello «Stato ebraico». In questo testo solenne, Gerusalemme – la città da sempre invocata dai pii ebrei della diaspora – non veniva citata neppure una volta. Lo Stato di Israele dunque nacque a prescindere da Gerusalemme.
A differenza degli ebrei, gli Stati arabi non accettarono il «piano di spartizione», ritenendolo una violazione dei diritti inalienabili e indisponibili dei palestinesi, che da secoli avevano abitato quella terra. Per quanto riguardava Gerusalemme, considerate le difficoltà che presentava una sua eventuale divisione, il piano di spartizione del 1947 affermava che essa doveva essere istituita come un corpus separatum sotto un regime internazionale speciale e doveva essere amministrata dalle Nazioni Unite[6]. Il suo territorio doveva, inoltre, includere altri piccoli villaggi limitrofi, come Betlemme.
Il primo ministro David Ben Gurion, al fine di non inimicarsi gli ebrei osservanti, affermò che la perdita di Gerusalemme (città da lui non amata) era il prezzo che si doveva pagare per la fondazione di uno Stato ebraico. Presto però essa sarebbe stata in parte occupata, manu militari, dagli eserciti israeliani. Ciò avvenne quando, nel maggio del 1948, gli Stati arabi confinanti con Israele (Egitto, Libano, Siria, Giordania e persino l’Iraq) gli dichiararono guerra. Guerra che fu vinta dal nuovo Stato, il quale ne approfittò per «estendere» i confini indicati dal piano di spartizione a proprio vantaggio, inglobando una parte di Gerusalemme, e per «liberare» alcune aree del Paese dalla presenza dei residenti palestinesi (da cui l’insolubile problema dei profughi).
Gli Accordi di armistizio del 1949 tra Israele e gli Stati arabi divisero in due parti, con la cosiddetta «Linea Verde», la città di Gerusalemme: la parte occidentale (Gerusalemme Ovest) fu assegnata agli israeliani, mentre la parte orientale (Gerusalemme Est), dove si trovava la Città Vecchia, e quindi il Monte del Tempio e i luoghi sacri dei cristiani, fu attribuita ai giordani.
L’Onu non riconobbe questi accordi e si attenne ai confini fissati dal piano di spartizione. Negli anni successivi, però, sia la Giordania sia Israele preferirono lasciare divisa Gerusalemme. Come per tutte le città spaccate in due da un conflitto – ad esempio, Berlino e Belfast –, anche per Gerusalemme la divisione è stata percepita da tutti come dilaniante: una città che fino ad allora era stata vissuta come una realtà unitaria, complessa ma complementare, veniva da un giorno all’altro smembrata, sia sul piano materiale sia su quello culturale e spirituale: «Gerusalemme – scrive un religioso residente a un suo confratello – lascia una sensazione di tristezza nella mia memoria. La città è surreale come se la divisione fosse una sorta di congegno malvagio piazzato nel cuore della notte da un demone, come se fosse una beffa oscena. Ma non è uno scherzo, e la crudeltà è rimarcata dai muri, le barriere, i fili spinati, i fucili e i soldati»[7].
Pio XII, con due encicliche – In multiplicibus, del 1948, e Redemptoris nostri, del 1949 –, chiese l’instaurazione di un «regime internazionale» nella Città santa, al fine di «garantire la tutela dei santuari», assicurare libertà di accesso ai luoghi di culto e rispettare i costumi e le tradizioni religiose del luogo. Questo appello non fu accolto dalle parti, anzi fu ostacolato perfino dalle altre confessioni cristiane presenti in Terra Santa, perché temevano che il Vaticano volesse in qualche modo garantirsi una condizione di vantaggio su di esse[8].
È a partire da questo momento che Gerusalemme entra a pieno titolo nella storia dello Stato di Israele, divenendone, per motivazioni sia politiche sia religiose, un elemento costitutivo. Il primo ministro Ben Gurion già nel 1950, in seguito alla proposta dell’Onu di internazionalizzazione della città, decise con determinazione di spostare la Knesset (cioè il Parlamento israeliano) e diversi ministeri a Gerusalemme, in modo da renderne definitiva l’annessione.
Poi, soltanto nel 1980, dopo l’unificazione della città in seguito alla «Guerra dei sei giorni», il Parlamento israeliano votò una «legge fondamentale», cioè di livello costituzionale, che dichiarava Gerusalemme «capitale unica e indivisibile dello Stato ebraico». L’Onu, con la risoluzione n. 478, definì la legge «nulla e priva di validità», in quanto violava il diritto internazionale e ostacolava il raggiungimento della pace tra israeliani e palestinesi. La comunità internazionale continuò pertanto a tenere le proprie ambasciate a Tel Aviv e a non riconoscere a Gerusalemme il rango di capitale di Israele[9].
Gerusalemme e la «Guerra dei sei giorni»
Per quanto riguarda la recente storia dello Stato di Israele e della città di Gerusalemme, la «Guerra dei sei giorni» ha un’importanza fondamentale[10]. Fu questa guerra infatti – combattuta in meno di una settimana (5-10 giugno 1967) tra il potente e motivato esercito israeliano e quelli degli Stati arabi confinanti, numericamente più cospicui, ma peggio equipaggiati – che ridefinì i confini fissati dall’Onu, successivamente dilatati a favore di Israele dalla guerra del 1948. In seguito Israele occupò militarmente la Cisgiordania (dove sarebbe dovuto nascere lo Stato palestinese) e Gerusalemme Est, togliendole alla Giordania, strappò all’Egitto la penisola del Sinai e la Striscia di Gaza e alla Siria le alture del Golan. Questa «vittoria maledetta», come recita il titolo di un recente libro di Ahron Bregman[11], fu all’origine di infinite questioni, dispute, accordi falliti, sanguinose intifade e sofferenze indicibili per i due popoli – quello palestinese e quello israeliano –, che vivevano uno accanto all’altro, uno contro l’altro.
Le truppe israeliane occuparono la Città Vecchia e la Spianata del Tempio il 7 giugno 1967. In quell’occasione il rabbino capo dell’esercito, il generale Shlomo Goren, fu uno dei primi ad accorrere sul luogo per portarvi il rotolo della Legge e per suonare lo shofar; egli propose anche al generale Uzi Narkiss – secondo la testimonianza di questi – di far esplodere con la dinamite la moschea di Omar.
Fu Moshe Dayan, ministro della Difesa, a riportare ordine nel luogo sacro e a impedire il peggio, innanzitutto ordinando di rimuovere le bandiere israeliane fatte sventolare in cima alla Cupola della Roccia e alla moschea di al-Aqsa, e intimando ai paracadutisti di sgomberare la Spianata[12]. Poi riconsegnò alle milizie musulmane la custodia del luogo: di fatto, otto delle nove porte che davano accesso alla Spianata furono consegnate al waqf (custode dei luoghi santi dell’islam); gli israeliani presero possesso soltanto della nona entrata, la cosiddetta «Porta dei maghrebini», dove fu istituito un comando di polizia[13].
Questa decisione fu avversata dagli ebrei tradizionalisti e ultraortodossi, che avrebbero desiderato impossessarsi della Spianata in vista di una possibile ricostruzione del Terzo Tempio. Al fine di scoraggiare tentativi di questo tipo, pochi giorni dopo il rabbinato di Israele proibì l’ingresso nella Spianata – in virtù della legge ebraica, che vieta di calpestare il luogo (sconosciuto) del Sancta Sanctorum – a tutti gli ebrei. Da quel momento sulla Spianata, oltre ai musulmani, salgono soltanto turisti ed ebrei non religiosi.
Nel novembre di quell’anno il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite votò la risoluzione n. 242, in cui si stabiliva che Israele doveva prontamente restituire tutti i territori occupati in cambio di una pace duratura. Questo avrebbe dovuto vincolare Israele a mantenere lo status quo nei territori, cosa che però Israele non attuò: anzi, nei fatti palesò la volontà di estendere la sua sovranità sulla Cisgiordania e soprattutto su Gerusalemme Est, espellendone, per quanto possibile, la popolazione araba[14].
Gli eventi del 1967 provocarono anche un importante cambiamento nella politica della Santa Sede nei confronti della Terra Santa. Paolo VI abbandonò l’ipotesi dell’internazionalizzazione di Gerusalemme, considerata non più realistica, e propose, in alcune allocuzioni, uno «statuto internazionalmente garantito», finalizzato alla tutela della libertà di culto e alla conservazione dei Luoghi Santi, «con particolare riguardo alla fisionomia storica e religiosa di Gerusalemme»[15].
A partire dal giugno 1967 Israele occupò gran parte di Gerusalemme Est: in tal modo, la cosiddetta «Linea Verde» perse molto del suo significato. I nuovi confini amministrativi della città vennero così estesi alla parte orientale, e la sua superficie passò da 38 a 108 kmq[16]. Da questo tracciato furono lasciati fuori i quartieri più densamente popolati di palestinesi, perché considerati difficili da amministrare e da gestire anche sul piano del welfare. Furono invece incorporate diverse aree, a quel tempo disabitate, che cingevano la Città Vecchia e che furono destinate al verde pubblico. Su queste terre negli ultimi decenni sono sorti diversi insediamenti israeliani, vere e proprie «colonie-città» (alcune con più di 50.000 abitanti), dove vive una parte considerevole dei gerosolimitani.
I primi permessi per la costruzione di nuovi e moderni quartieri ebraici a Gerusalemme furono concessi dall’amministrazione comunale già dal 1968. Il più convinto sostenitore della strategia di «ebraicizzare» Gerusalemme – contravvenendo alle risoluzioni dell’Onu – attraverso l’edilizia residenziale fu il sindaco di allora Teddy Kollek. In questo modo la città sarebbe rimasta per sempre in mano a Israele, e non sarebbe passata a un eventuale Stato palestinese. Tale indirizzo nei decenni successivi fu seguìto – e non soltanto a Gerusalemme – sia dai governi di destra sia da quelli di sinistra.
Questa politica di annessione condotta da Israele nei confronti di Gerusalemme Est venne fortemente condannata, oltre che dall’Onu, anche dall’Ue, che la considerava di ostacolo al processo di pace. «Attraverso nuovi insediamenti – denunciava una sua dichiarazione –, costruzione della barriera, politiche edilizie discriminatorie, demolizione delle case, restrizione dei permessi e ripetute chiusure delle istituzioni palestinesi si rafforza la presenza ebraica a Gerusalemme Est, s’indebolisce la comunità araba, si impedisce lo sviluppo urbano palestinese e si separa Gerusalemme Est dal resto della Cisgiordania»[17].
Oggi non è per nulla facile per gli ebrei acquistare terreni per costruire case o altro nella parte Est di Gerusalemme. Tuttavia questo può essere fatto o costringendo (in vario modo) i possidenti arabi ad abbandonare le loro proprietà, oppure attraverso l’emanazione di ordinanze di demolizione di edifici vecchi, pericolanti o abusivi da parte del Comune. La vendita di case o di terreni agli israeliani è vietata da una fatwa (editto religioso) del 1925, ribadita poi nel 1997. Il colpevole che si macchia di questo «delitto» viene di fatto espulso dalla comunità, e quindi non può beneficiare di funerali religiosi, né può essere sepolto insieme agli altri credenti. Arafat stesso aveva ordinato ai suoi collaboratori di usare il pugno di ferro per vietare la vendita di proprietà agli ebrei, e il ministero di Giustizia palestinese propose la pena di morte contro questo crimine.
A Gerusalemme oggi ci sono circa 880.000 residenti, di cui il 63% sono israeliani e il 37% palestinesi. Nella parte orientale della città, cioè quella annessa dopo la guerra del 1967, abitano circa 300 palestinesi. Questi, avendo rifiutato nel 1967 la cittadinanza israeliana, al fine di non legittimare la politica dei «fatti compiuti» dell’unificazione, sono considerati «residenti permanenti». Pagano le tasse e godono dei diritti riservati agli israeliani, ma non hanno il diritto di voto nelle elezioni legislative.
Secondo molti osservatori, il problema principale con il quale Gerusalemme si dovrà confrontare in futuro sarà quello demografico (cioè, il mantenimento dell’ebraicità dello Stato). A questo proposito, in alcuni ambienti si parla di «bomba demografica», con la quale alla fine i palestinesi sconfiggeranno i loro nemici[18]: di fatto, il tasso di crescita dei palestinesi è da diversi anni molto superiore a quello degli ebrei. Questi ultimi, negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, hanno beneficiato dell’arrivo di molti ebrei aschenaziti, per lo più osservanti, con numerosa prole al seguito, che provenivano dalla Russia o da Paesi ex comunisti. Questa immigrazione ora però è cessata.
Gerusalemme tra gli Accordi di Oslo e il Vertice di Camp David
La «questione di Gerusalemme» – la sua divisione e le sue contraddizioni – ha contribuito in questi decenni a fomentare il contrasto tra palestinesi e israeliani. La storia recente insegna che non è possibile raggiungere un accordo di pace tra i due popoli senza prima definire lo status della Città santa. I vari tentativi fatti dalla comunità internazionale, sotto la regia degli Stati Uniti, per risolvere il problema arabo-palestinese hanno cercato di mettere provvisoriamente tra parentesi il problema di Gerusalemme, pur sapendo che la tenuta del processo di pacificazione sarebbe poi dipesa dall’equa risoluzione di tale questione, su cui attentamente vigilavano i gruppi religiosi di ambedue la parti, ora ricattando i vari Governi, ora aizzando le masse popolari.
Il tentativo più serio per risolvere l’intricata questione israelo-palestinese, da cui dipendeva la pace in Medio Oriente, fu certamente quello dei cosiddetti «Accordi di Oslo», dell’estate del 1993, il cui mediatore fu il presidente Clinton, mentre gli attori principali furono Yitzhak Rabin e Yasser Arafat. Non va dimenticato che tali Accordi, pur criticati da entrambe le parti, fissarono dei punti fondamentali per avviare un «processo» di pace e rendere possibile la convivenza tra i due popoli. Ad esempio, nei protocolli si fissava il ritiro israeliano da alcune aree densamente popolate da palestinesi, come la Striscia di Gaza, e da alcune zone della Cisgiordania (indicate nel protocollo come «zona A», mentre per le altre, indicate come zona B e C, erano fissate regole diverse). Inoltre, si affermava il diritto dei palestinesi all’autogoverno in tali aree, attraverso la creazione dell’Autorità nazionale palestinese (Anp).
Dopo cinque anni dal ritiro israeliano si prevedeva che sarebbe stato negoziato un accordo definitivo, che avrebbe affrontato anche problemi molto delicati, come la questione di Gerusalemme, quella dei coloni ebrei in Cisgiordania e il rientro dei profughi palestinesi. Tutti problemi scottanti e di non facile soluzione[19]. Le due parti, inoltre, firmarono lettere di mutuo riconoscimento tra le due autorità, e questo è certamente uno degli aspetti più positivi degli Accordi. Il governo israeliano si impegnava a riconoscere l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) come legittima rappresentante del popolo palestinese, mentre questa a sua volta riconosceva il diritto dello Stato di Israele di esistere e rinunciava alla violenza e al terrorismo come strumenti di lotta politica.
Secondo l’attivista palestinese Noura Erakat, gli Accordi non si basavano sul diritto internazionale – anche se si ripromettevano di rispettare le risoluzioni dell’Onu in materia (come la n. 242) –, ma semplicemente su accordi negoziali, ai quali si dava valore di legge. A suo avviso, le conseguenze di tali Accordi per i palestinesi sono state disastrose. «Gli Accordi di Oslo – scrive – sono diventati una struttura permanente, che ha portato alla situazione attuale: una barriera attraverso cui Israele ha confiscato il 13% delle terre della Cisgiordania. Un’aggressiva politica di pulizia etnica a Gerusalemme, con l’obiettivo di ridurre la popolazione palestinese, per mantenere una maggioranza ebraica»[20].
Va anche ricordato che, sulla base degli Accordi di Oslo, Israele ha il controllo militare e amministrativo sull’intera zona C, che corrisponde al 59% del territorio della Cisgiordania. Sta di fatto che in definitiva il «processo» di Oslo si è dimostrato favorevole più agli israeliani che ai palestinesi: il suo gradualismo ha giocato certamente a sfavore di questi ultimi e permesso ai primi di approfittare della situazione.
Successivamente, l’unico colloquio di pace – peraltro fallito – che si occupò direttamente della situazione di Gerusalemme fu quello di Camp David, svoltosi fra l’11 e il 24 luglio del 2000. Anche in questo caso, le trattative furono volute e condotte con la mediazione del presidente statunitense Clinton. Per la prima volta gli israeliani accettarono di discutere – nonostante le pressioni in senso contrario esercitate dai partiti religiosi – della divisione di Gerusalemme con i coabitanti arabi, abbandonando la posizione caparbiamente tenuta fino a quel momento, e di concedere ai palestinesi una certa autonomia amministrativa sulla parte di Gerusalemme Est.
I negoziati cominciarono a complicarsi nel momento in cui si iniziò a trattare della Città Vecchia, e in particolare del Monte del Tempio. Una delle proposte avanzate fu quella di dividere in due parti la Città Vecchia, affidando agli israeliani il quartiere ebraico e quello armeno, e ai palestinesi quello musulmano e quello cristiano. Soluzione che, oltre a non soddisfare nessuna delle due parti, suscitò un certo allarme tra le Chiese e confessioni cristiane presenti nei Luoghi Santi. Esse sottoscrissero e inviarono a Camp David una lettera in cui si protestava contro la divisione della Città Vecchia e si chiedeva per essa uno «statuto speciale, garantito internazionalmente».
Mentre gli israeliani e gli statunitensi optavano per trattare un problema alla volta, al fine di trovare soluzioni concrete per le singole questioni che si dovevano affrontare, i palestinesi chiesero di iniziare la trattativa partendo dalla definizione dei princìpi generali. In particolare, Arafat disse che la trattativa sarebbe andata avanti soltanto se la parte israeliana (rappresentata dal primo ministro Barak) avesse riconosciuto la sovranità palestinese su Gerusalemme Est. E fu proprio sul rapporto tra il principio di «sovranità» e quello di «autorità funzionale» che si giocò l’esito del Vertice di Camp David. Gli israeliani, infatti, proposero di affidare la gestione autonoma dei quartieri a maggioranza araba di Gerusalemme Est ai palestinesi, e di portare la loro capitale nel popoloso quartiere di Abu Dis. In cambio, i confini municipali della città sarebbero stati allargati secondo il modello della Greater Jerusalem[21].
Circa la Spianata delle moschee, si propose di affidarne la «custodia» (con diritto di piantarvi la bandiera) all’Anp. Arafat disse che era disposto a trattare della delicata questione (sulla quale vigilava l’intero mondo arabo) solo a condizione che venisse trasferita ai palestinesi la «sovranità» dell’intera Spianata, ad eccezione del Muro del Pianto. Barak a sua volta propose che una parte del Monte del Tempio venisse riservata agli ebrei per il culto. Ma Arafat respinse la proposta. Gli americani proposero allora una «divisione verticale della sovranità», per cui i palestinesi avrebbero avuto la superficie della Spianata dove si trovavano le moschee, e gli israeliani il sottosuolo. Ma anche questa soluzione fu respinta dagli arabi. Gli israeliani, in ogni caso, non si fecero intimorire dalla posizione intransigente degli arabi, e anche negli anni successivi continuarono i loro scavi archeologici sotto e a lato della Spianata.
Al ritorno da Camp David, Arafat venne accolto a Ramallah come un vincitore, per aver resistito alle pressioni congiunte degli israeliani e degli statunitensi e per aver salvato l’onore dei palestinesi. Prima di partire dalla tenuta presidenziale, egli disse a Clinton: «Non è ancora nato illeader arabo che cederà Gerusalemme». In realtà, ancora una volta il processo di pace si era bloccato, e questa volta, almeno sul tema di Gerusalemme, in modo definitivo.
I risultati del fallimento del Vertice di Camp David furono rovinosi. Alla fine di settembre dello stesso anno scoppiò la seconda intifada, detta «di al-Aqsa» (la prima era scoppiata nei campi profughi nel 1987 e aveva portato agli Accordi di Oslo), quando il leader del Likud (un partito di destra), Ariel Sharon, spavaldamente decise di fare una «semplice passeggiata», insieme ad alcuni suoi sostenitori, sulla Spianata e di andare a visitare gli scavi israeliani nelle cosiddette «Stalle di Salomone», che si trovano sotto la moschea. Questo fatto fu considerato dai palestinesi come una provocazione e come una profanazione del loro luogo sacro. L’intifada, come è noto, durò circa cinque anni e provocò più di 5.000 vittime tra i palestinesi e circa un migliaio tra gli israeliani.
Altro importante risultato del fallimento del Vertice di Camp David, di cui ancora oggi si pagano le conseguenze, fu che a partire da allora i leader politici israeliani decisero di applicare a Gerusalemme il principio, già da tempo sperimentato in Cisgiordania e in parte anche a Gaza, di «occupare il massimo di territorio con il minimo di presenze palestinesi». Dopo Camp David, si decise di rimodellare la città in modo da includervi la gran parte degli insediamenti israeliani, tenendone fuori i quartieri a maggioranza palestinese. Questa misura di sicurezza fu poi rafforzata a partire dal 2002 – cioè negli anni bui dell’intifada – dalla costruzione di una «barriera divisoria» tra Israele e Territori occupati, che intorno a Gerusalemme segue un tracciato tortuoso di circa 150 km e a volte taglia a metà alcuni villaggi arabi, modificando lo stato giuridico di migliaia di persone. Decine di migliaia di palestinesi si sono così trovati nella parte della Cisgiordania, pur avendo la carta di identità israeliana.
Conclusione
Negli ultimi anni, sia a Gerusalemme sia nei Territori la convivenza tra israeliani e palestinesi è diventata difficile e a volte impossibile. Più di 400.000 israeliani (i cosiddetti «coloni»), spesso con motivazioni politico-religiose, si sono trasferiti in Cisgiordania, dove doveva sorgere lo Stato palestinese. Oggi sono molti gli osservatori politici e gli intellettuali, anche progressisti e di sinistra, che considerano la soluzione del bi-statualismo ormai superata e impraticabile. Essi propongono la soluzione del mono-statualismo – uno Stato per due popoli –, dove tutti i cittadini, ebrei e palestinesi, godano degli stessi diritti civili e politici. Ritengono che il vecchio progetto del bi-statualismo oggi sia finalizzato solo a tenere in vita una classe politica corrotta, cioè l’Anp, che ha fallito i suoi obiettivi e che non avrebbe più l’appoggio della maggioranza dei palestinesi. La comunità internazionale – in particolare l’Onu, che non ha mai riconosciuto l’annessione di Gerusalemme Est e dei Territori – ribadisce l’importanza della soluzione dei due Stati, che vivano uno accanto all’altro in pace e sicurezza entro confini riconosciuti. In questa direzione si è espresso anche papa Francesco nel recente discorso al Corpo diplomatico.
Ora, a prescindere dalle questioni legate al bi-statualismo o mono-statualismo, che non rientrano in questo studio[22], per quanto riguarda Gerusalemme, alcuni settori del mondo politico e intellettuale sia israeliano sia palestinese guardano ad essa (oltre la gabbia di Oslo) come a una città aperta, unita, senza confini interni, capitale dei due popoli che la abitano. Cioè, una città «una e condivisa», dove «tutto il mosaico di quartieri, insediamenti, colonie, sobborghi storici, Città Vecchia, luoghi sacri dovrebbe rappresentare un corpo urbano unico, in cui vi sia totale libertà di movimento»[23]. Una città di questo tipo dovrebbe, però, avere uno statuto speciale, con un sindaco eletto da tutti gli abitanti e un Consiglio municipale che rappresenti in modo paritetico le due comunità. «Gerusalemme – scrive Paola Caridi – deve rimanere aperta oltre le diverse cinte di mura che la racchiudono e la feriscono»[24]. Per tutti gli uomini essa dovrebbe essere una «città aperta»[25] e rappresentare il luogo della comunione e della pace, e non della discordia e della divisione.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2018
Riproduzione riservata
[1]. Cfr G. Sale, «La questione di Gerusalemme capitale», in Civ. Catt. 2018 I 331-342; G. Pani, «La Giordania e Gerusalemme», ivi 2018 II 257-264.
[2]. La nostra rivista si è interessata più volte di questo tema: cfr G. Sale, «La fondazione dello Stato di Israele e il problema dei profughi palestinesi», in Civ. Catt. 2011 I 107-120.
[3]. La cosiddetta «Marcia del ritorno» è una manifestazione, iniziata il 30 marzo 2018, per reclamare il diritto dei palestinesi a ritornare nei loro territori, da cui furono cacciati dall’esercito israeliano nel 1948, e anche per denunciare il blocco imposto da Israele nel 2007 sulla Striscia di Gaza. Cfr A. Ayman, «La resistenza che unisce gli abitanti di Gaza», in Internazionale, 4 maggio 2018, 22.
[4]. Cfr T. Marshall, Le 10 mappe che spiegano il mondo, Milano, Garzanti, 2017, 181.
[5]. A. Oz, Cari fanatici, Milano, Feltrinelli, 2017, 19.
[6]. Cfr D. Neuhaus, «La Chiesa cattolica e la Città Santa», in Civ. Catt. 2018 I 10-22.
[7]. P. Caridi, Gerusalemme senza Dio. Ritratto di una città crudele, Milano, Feltrinelli, 2017, 189. Sulle vicende di Gerusalemme dopo la guerra del 1948, cfr V. Lemire (ed.), Gerusalemme. Storia di una città-mondo, Torino, Einaudi, 2017, 90 s.
[8]. Cfr P. Pieraccini – E. Dusi, «Gerusalemme: un accordo impossibile?», in Limes, 1/2001, 98. Sui rapporti tra Santa Sede e Gerusalemme, cfr D. Neuhaus, «La Chiesa cattolica e la Città Santa», cit.
[9] . Cfr E. Dusi – P. Pieraccini, «La battaglia per Gerusalemme», in Limes (www.limesonline.com/cartaceo/la-battaglia-per-Gerusalemme), 13 luglio 2010.
[10]. Cfr G. Sale, «A cinquant’anni dalla guerra dei sei giorni», in Civ. Catt. 2017 II 262-275.
[11]. Cfr A. Bregman, La vittoria maledetta. Storia di Israele e dei Territori occupati, Torino, Einaudi, 2017.
[12]. Cfr B. Morris, Vittime. Storia del conflitto arabo-sionista 1881-2001,Milano, Rizzoli, 2001, 405 s.
[13]. Dopo la «Guerra dei sei giorni» la Giordania dovette abbandonare Gerusalemme. Essa conservò però il diritto di nominate il gran muftì, cioè il capo religioso dei musulmani gerosolimitani e il custode della Spianata delle moschee. Questo potere nel 1994 passò dalla Giordania all’Autorità nazionale palestinese, in seguito a un conflitto che sorse tra queste due autorità. Nel trattato di pace firmato quell’anno tra Israele e Giordania si affermava: «Israele rispetta il ruolo speciale della Giordania nei luoghi santi di Gerusalemme. Durante i negoziati verso lo status finale, Israele darà alta priorità al ruolo storico della Giordania su questi santuari». Questo passo suscitò le ire di Arafat che, appena morì il gran muftì di Gerusalemme, si affrettò a nominarne uno palestinese e a installarlo nella carica, consegnandogli anche le chiavi della Spianata. Lo stesso fece la Giordania, ma quest’ultimo gran muftì rimase in carica per poco tempo, senza un potere effettivo. Sul ruolo della Giordania, cfr G. Pani, «La Giordania e Gerusalemme», cit.
[14]. Israele annesse la parte orientale di Gerusalemme dopo la sua occupazione militare, cioè alla fine di giugno 1967. In seguito l’Onu approvò due importanti risoluzioni (nn. 2253 e 2254), in cui condannava l’annessione e chiedeva allo Stato di Israele di astenersi da ogni azione che potesse alterare lo status quo della città. Mentre il Regno Unito votò a favore di entrambe le risoluzioni, gli Stati Uniti, come avevano fatto altre volte, si astennero, dichiarando però che si opponevano all’espansione territoriale di Israele. Nessuno dei due Paesi però trasferì la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Cfr N. Erakat, «La pace si ferma a Gerusalemme», in Internazionale,15-21 dicembre 2017, 20.
[15]. Cfr D. Neuhaus, «La Chiesa cattolica e la Città Santa», cit., 16 s.
[16]. Gli abitanti di Gerusalemme salirono così a 263.000, di cui 197.000 ebrei, 55.000 musulmani e 11.000 cristiani. Cfr P. Pieraccini – E. Dusi, «Gerusalemme: un accordo impossibile?»,cit., 99.
[17]. E. Dusi – P. Pieraccini, «La battaglia per Gerusalemme», cit.
[18]. Cfr S. Della Pergola, Israele e Palestina: la forza dei numeri. Il conflitto mediorientale fra demografia e politica, Bologna, il Mulino, 2007, 206.
[19]. Cfr V. de Giovannangeli, «Il negoziato impossibile», in Limes,13 luglio 2010.
[20]. N. Erakat, «La pace si ferma a Gerusalemme», cit., 19.
[21]. Cfr P. Pieraccini – E. Dusi, «Gerusalemme: un accordo impossibile?», cit., 109.
[22]. Sul dibattito in corso, cfr C. De Martino, Il nuovo ordine israeliano. Oltre il paradigma dei due Stati,Roma, Castelvecchi, 2017, 19 s; N. Chomsky – I. Pappé, Palestina e Israele che fare?, Roma, Fazi, 2015. In favore del bi-statualismo si dichiara A. Oz, Cari fanatici,cit., 87 s. «Sì, un compromesso tra Israele e Palestina. Sì, due Stati. Spartizione di questa terra, che deve diventare una casa bifamiliare» (ivi, 96).
[23]. P. Caridi, Gerusalemme senza Dio…, cit., 191.
[24]. Ivi, 189.
[25]. Così ha detto in un’intervista il Segretario di Stato, card. Pietro Parolin: «Gerusalemme dovrebbe avere uno statuto speciale che ne faccia una città aperta» (G. G. Vecchi, «Gerusalemme città di pace, ma solo con il dialogo diretto», in Corriere della Sera, 21 dicembre 2017).