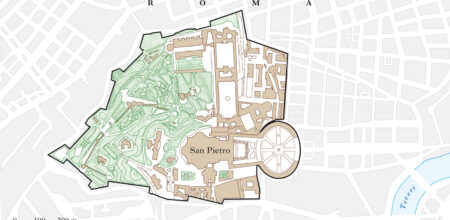|
|
In quest’opera Massimo Borghesi presenta il dibattito che illustri filosofi e teologi cattolici del Novecento hanno tenuto sul riconoscimento di alcune implicazioni teoretiche della modernità nell’ateismo. Il tema non è di facile risoluzione in quanto il nucleo teoretico della modernità, riconducibile principalmente al cogito cartesiano, non conosce una sola direzione d’indagine, ma apre a variegate interpretazioni del suo valore e impiego. Dal cogito si giunge, infatti, all’immanentismo come anche a un pensiero ontologista aperto alla trascendenza. Per questo, tra i meriti dell’autore vi è quello di essere riuscito a ricostruire il dibattito, mostrando non soltanto le diverse posizioni degli intellettuali richiamati nell’opera, ma anche le loro personali annotazioni elaborate nel tempo, che provano la complessità teoretica del tema.
Borghesi presenta le opinioni sull’ateismo di Henri de Lubac, Jacques Maritain, Augusto Del Noce, Cornelio Fabro ed Étienne Gilson, per poi soffermarsi in modo particolare sul confronto di Del Noce con Fabro e con Gilson. Questi intellettuali cattolici si sono sentiti interpellati dal tema dell’ateismo in forza delle circostanze storico-sociali del loro tempo. Infatti, il neopaganesimo nazista e il marxismo sovietico avevano avuto un’incidenza sociale tale da richiedere una riflessione accurata da parte del mondo cattolico. Da questa esigenza sono nate opere di grande spessore teoretico, come Il dramma dell’umanesimo ateo (1944) di de Lubac, Il significato dell’ateismo moderno (1949) di Maritain, Le metamorfosi della città di Dio (1952) di Gilson, Introduzione all’ateismo moderno (1964) di Fabro e Il problema dell’ateismo (1964) di Del Noce.
Nell’intervento introduttivo all’opera, l’autore presenta un’inedita ricostruzione delle condizioni storiche che avrebbero favorito l’elaborazione di riflessioni a sostegno delle posizioni atee. Borghesi rintraccia l’origine storica dell’ateismo nelle guerre di religione avvenute dopo la Riforma. Egli afferma che «all’origine dell’ateismo moderno, che si affaccia sulla scena con il libertinismo, vi è il conflitto teologico-politico che divide l’Europa “cristiana”» (p. 27).
Per l’autore, ciò significa che la mancata distinzione dell’ambito religioso da quello politico ha determinato una rottura all’interno della cristianità, dando vita a un anticlericalismo radicale. Quest’ultimo ha recuperato lo scetticismo classico e ha saputo trovare forza teoretica in quello metodico di Cartesio; questo però a discapito dell’intento autentico di Cartesio, il quale voleva superare lo scetticismo dei libertini attraverso la certezza del cogito, visto che tale certezza era il frutto dello stesso scetticismo, che si vedeva così oltrepassato da essa.
Il cogito cartesiano diviene pertanto l’oggetto di riflessione degli intellettuali indicati da Borghesi. Le loro interpretazioni di questa prima certezza della coscienza non indicano necessariamente una risoluzione atea, bensì riconoscono ad essa anche la capacità di suggerire al soggetto elementi di riflessione sulla conoscenza di Dio. Persino nelle posizioni più critiche al cogito, come quelle di Fabro e di Gilson, l’autore sa rintracciare segni di avvicinamento che ammorbidiscono alcuni giudizi iniziali. Un esempio è dato dalla lettura, da parte di Gilson, della prova ontologica cartesiana.
Dall’analisi condotta sull’opera postuma del filosofo francese, L’ ateismo difficile, Borghesi individua nella nozione premetafisica di Dio, che Gilson considera prodotto spontaneo dell’intelletto umano, una via di rivalutazione della prova ontologica di Cartesio, in quanto «l’idea di Dio [che] precede le prove della sua esistenza, in qualche modo, le rende plausibili» (p. 224). Questa preconoscenza di Dio è anteriore alle prove e le interpreta, perché consente di riconoscere che il Primo Motore, il Primo Necessario o il Fine Ultimo sono l’essere che tutti chiamano «Dio». Pertanto le prove presuppongono una previa definizione nominale di Dio, ovvero un concetto provvisorio, necessario e sufficiente per indicare ciò che si sta cercando.
Da questa prospettiva, secondo Gilson, è possibile vedere, nella quinta Meditazione metafisica di Cartesio, l’affermazione perfetta dell’inseparabilità delle due nozioni di «Dio» e di «esistenza». In questa maniera l’argomento ontologico avrebbe il merito di spiegare l’esistenza dell’idea di Dio. Come evidenzia l’autore: «Al di là delle future obiezioni di Locke e dell’empirismo in genere [Cartesio] ha dimostrato […] come l’idea di Dio in noi non sia una nozione fittizia» (p. 225).
Borghesi mette in dialogo i suoi autori anche sul tema della libertà, su quel volo cartesiano che anticipa il cogito e che pone l’accento sull’io, sull’esistenza e sul problema di Dio.
MASSIMO BORGHESI
Ateismo e modernità. Il dibattito nel pensiero cattolico italo-francese
Milano, Jaca Book, 2019, 256, € 22,00.