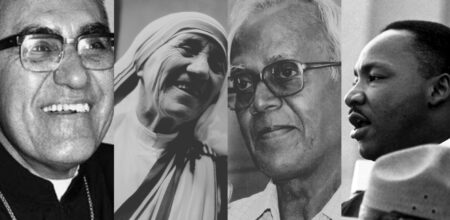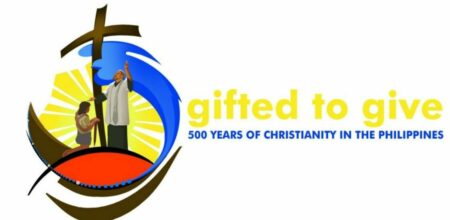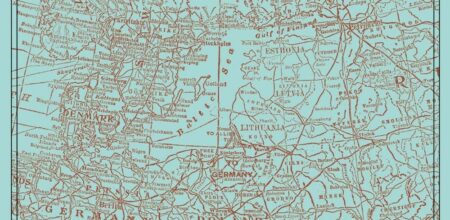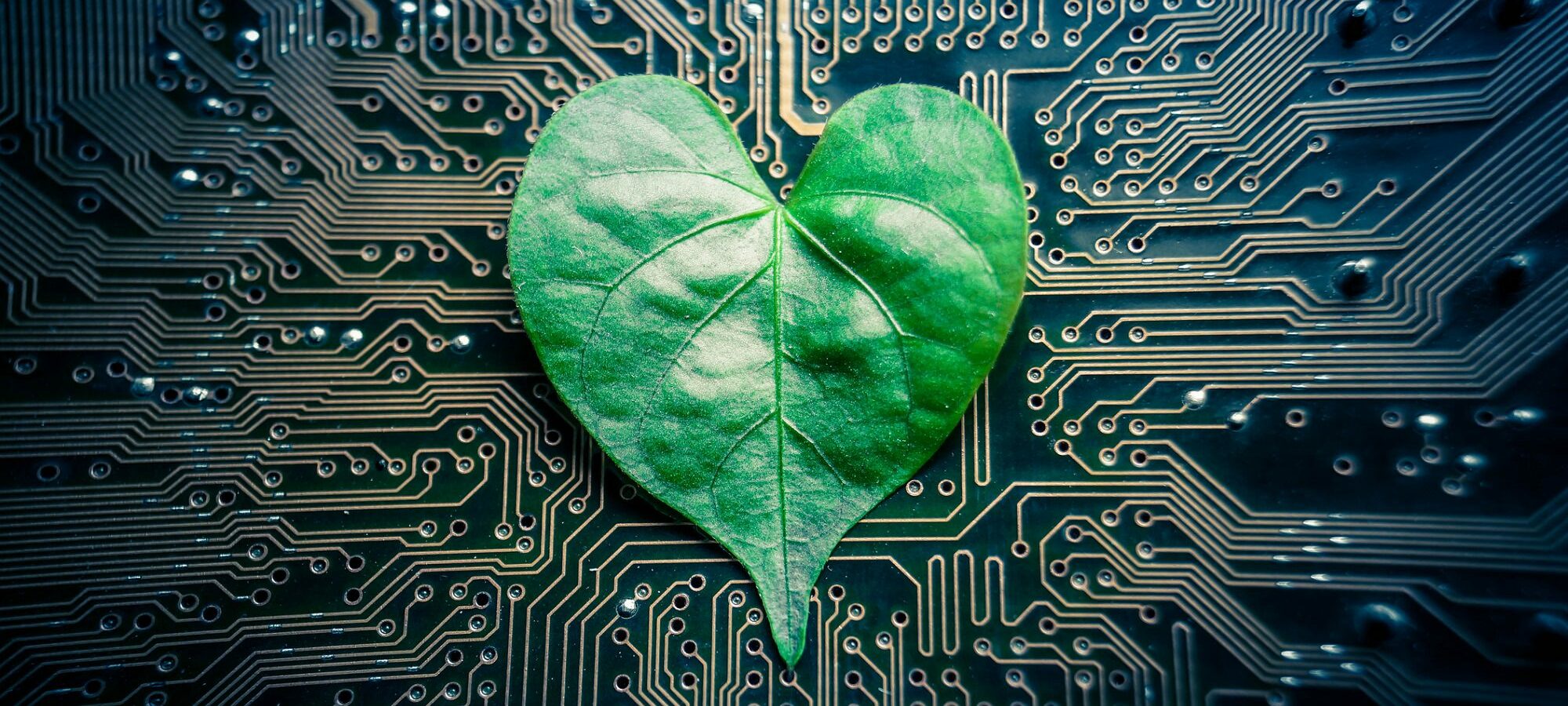
|
|
Da tempo la riflessione epistemologica incrocia l’etica, e viceversa, rimettendo in discussione la loro presunta incompatibilità. Si pensi all’analisi del linguaggio morale in sede di filosofia analitica, o alla verificabilità degli asserti valoriali compiuta dal neopositivismo, o al riconoscimento dei valori e delle credenze presenti nella ricerca da parte dell’epistemologia contemporanea: problematiche che, pur giungendo da ambiti differenti, si mostrano sempre più intrecciate nel dibattito odierno. Alcune ricerche condotte in proposito entrano in merito a questa specifica tematica, presente, anche se in maniera implicita, nei procedimenti propri dell’indagine scientifica.
L’osservazione
L’osservazione è l’atteggiamento fondamentale di ogni indagine, un atteggiamento essenzialmente selettivo e affettivo. San Tommaso notava che ubi amor, ibi oculus («Dove c’è amore, lì si posa l’occhio», 3 Sent., d. 35, 1, 2, I): l’atto di vedere, mettendo a fuoco qualcosa e lasciando il resto sullo sfondo, manifesta il desiderio che abita il cuore, il vero motore dell’attenzione. A sua volta, l’osservazione influisce sulle abitudini e sulla personalità di chi la compie, ne plasma la mentalità e il modus operandi.
Ritenere che l’approccio scientifico alla realtà sia del tutto asettico e distaccato è stato uno degli assunti più condivisi della filosofia moderna. Si è cercato di giustificarlo, con Locke, ricorrendo alla distinzione tra qualità primarie (legate alla forma e alla quantità), ritenute oggettive e indipendenti dal soggetto, e qualità secondarie (colore, odore e gusto), influenzate dall’osservatore e quindi soggettive. Secondo il filosofo inglese, solo le prime possono essere oggetto di indagine scientifica. Tuttavia, esaminando più a fondo la questione, tale distinzione si rivela insostenibile: il punto di vista dell’osservatore è imprescindibile anche nella maniera con la quale si percepisce la forma; inoltre, risulta problematica la nozione stessa di «mondo» che l’epistemologia contemporanea riconosce essere una costruzione mentale dell’essere umano[1]. In tal modo risulta aporetica non solo la nozione di qualità primaria, ma anche il più generale approccio materialistico alla realtà.
L’apporto del soggetto è ancora più esplicito se si considera la dimensione linguistica dell’osservazione, indispensabile per la chiarificazione, che precede ogni possibile osservazione. Essa rivela sempre la presenza imprescindibile della credenza, frutto di una condivisione comunitaria, di cui il linguaggio è appunto una delle principali caratteristiche. In questo senso, il significato di oggettività andrebbe inteso non come distacco dal soggetto, ma come intersoggettività, punto di arrivo di una serie di scambi e interazioni. È la comunità a riconoscere e convalidare le osservazioni compiute: «Nella maggior parte dei casi vediamo gli stessi oggetti, nel senso che li vediamo in comune, per il fatto stesso che i concetti di cui disponiamo sono sempre condivisi. Persone diverse mostrano attività intellettive simili, e ciò è dovuto al fatto che esse utilizzano concetti simili, dal momento che gli individui hanno bisogno di parole il cui significato è determinato dal loro utilizzo comune all’interno di una comunità»[2].
Da qui le implicazioni etiche dell’osservazione: quanto notato presenta delle ricadute, a volte rilevanti, sulla vita dell’osservatore, mostrando la necessità di prendere decisioni ponderate, basate sulla ragionevolezza dei dati e sulla loro capacità di comprendere la problematica. Disattendere tali criteri ha conseguenze anche drammatiche: «confusione, divisione, frammentazione, auto-annientamento progressivo, morte»[3].
Il metodo
Anche il metodo impiegato, oltre a essere un aspetto essenziale dell’indagine scientifica, fornisce criteri accurati per distinguere possibili vizi e virtù presenti nella ricerca. Riprendendo l’etimologia greca, il metodo è un percorso (meta [«oltre»] e hodos [«cammino»]), un procedimento che porta a realizzare un’opera di vario genere (cfr Platone, Sofista, 218d; Aristotele, Etica Nicomachea, 1129a 6). Questo percorso mostra un ipotetico filo rosso che congiunge i vari passi, consentendo di applicarlo alle indagini successive. La replicabilità è infatti una caratteristica peculiare dell’indagine scientifica.
La storia del pensiero filosofico ha individuato soprattutto due procedimenti per operare tale congiunzione: il percorso dall’universale al particolare e quello dal particolare all’universale. Il primo ha trovato una classica formulazione nella struttura per eccellenza del ragionamento dimostrativo, il sillogismo: da due premesse, una universale e l’altra particolare, si giunge a una conclusione incontrovertibile. Il secondo percorso, l’induzione, anch’esso presente sin dall’antichità, parte dall’osservazione per riscontrare una regolarità formulabile in una legge generale (cfr Platone, Repubblica, VI, 509d; Aristotele, Topici, 100a).
L’epoca moderna, soprattutto con Hume, ha messo in discussione l’effettiva validità di tali procedimenti, ritenendo la deduzione tautologica, e l’induzione inaffidabile. L’osservazione, per quanto ripetuta, di cigni di colore bianco non è mai in grado di escludere l’eventualità di trovare un cigno nero. Ma anche questa obiezione presuppone la presenza costante di caratteristiche che a loro volta andrebbero giustificate: «Su che basi è possibile affermare che il cigno nero proveniente dall’Australia è effettivamente un cigno, e non un animale appartenente ad una specie diversa? Anche se ammettiamo che le nostre future osservazioni di cigni saranno simili a quelle passate, dobbiamo comunque decidere quali aspetti di questi uccelli debbano essere considerati essenziali per manifestare tale somiglianza. Stabilire la relazione di somiglianza in funzione del colore del cigno, piuttosto che del suo peso, per esempio, sembrerebbe piuttosto arbitrario»[4]. Portando l’obiezione alle sue estreme conseguenze, non sarebbe più possibile riconoscere le costanti che consentono lo svolgimento della vita quotidiana.
La storia delle scoperte scientifiche ha anche mostrato che entrambi i modi di procedere – la logica e la raccolta di informazioni – non sono sufficienti a rendere conto della realtà e a progredire nella conoscenza: la teoria e la pratica necessitano soprattutto di immaginazione e di metafore. Si pensi ad esempio all’invenzione dell’aeroplano. I fratelli Wilbur e Orville Wright, che progettarono e realizzarono il primo apparecchio in grado di volare, non erano ingegneri, anzi non erano neppure laureati, avevano soltanto il diploma di scuola superiore. Come poterono riuscire nell’impresa, superando concorrenti maggiormente dotati di denaro, di cognizioni teoriche, e con prototipi più potenti a disposizione? I due fratelli avevano un’immaginazione potente[5]. Alla base del successo dell’impresa ci fu una metafora che si rivelò decisiva: essi cercarono di immaginare quale mezzo di trasporto, tra quelli conosciuti, potesse avvicinarsi maggiormente a un ipotetico aeroplano. Esclusero la nave, così come l’automobile e il treno, perché, nonostante l’indubbia potenza di cui erano dotati, mancavano di qualcosa di essenziale per il volo: l’instabilità. Giunsero perciò alla conclusione che il mezzo più simile a un ipotetico aeroplano era la bicicletta: essa rimane in equilibrio grazie all’abilità del conducente. In tal modo, ragionando a partire dalla struttura della bicicletta, i fratelli Wright intuirono che il problema essenziale per il volo non era la potenza (come invece ritenevano i loro concorrenti, schiantandosi miseramente al suolo), ma l’affidabilità, la capacità di controllo.
La storia delle invenzioni, analogamente a quanto notato a proposito dell’osservazione, mostra quanto sia decisiva la personalità del ricercatore. La critica di Hume (e dei concorrenti dei fratelli Wright) rivela una mentalità logica e rigorosa, ma troppo astratta e riduttiva.
Anche la vita ordinaria mostra il continuo intrecciarsi di induzione, immaginazione e deduzione nel modo di argomentare, ed è in questa sede che si pone il vero punto di riferimento per l’indagine scientifica. Ogni giorno riconosciamo regolarità che non siamo noi a stabilire, ma che siamo piuttosto chiamati ad accogliere, lasciando che esse stimolino la nostra capacità elaborativa: «Quando procediamo dall’osservazione di un numero finito di cigni ad una qualche conclusione generale su di essi, non stiamo inventando un legame tra le diverse osservazioni, ma piuttosto stiamo facendo un’ipotesi ragionata su regolarità che esistono indipendentemente dalle nostre osservazioni e che pertengono alla natura dei suoi oggetti […]. Il punto essenziale è che l’induzione rappresenta una modalità euristica del pensiero che è orientata all’identificazione di regolarità già esistenti»[6].
Ed è proprio la regolarità a mostrare l’aspetto etico del metodo: la fiducia nell’ordine, all’origine dell’esperienza del senso, è indispensabile per vivere e per la rielaborazione temporale, frutto dell’equilibrio tra memoria e progettazione. Lo psichiatra statunitense Irvin D. Yalom nota la stretta relazione tra strutture conoscitive, rilevazione di senso e indicazioni per l’agire; esse a loro volta sono la condizione basilare per individuare i valori, i segnali indicatori indispensabili per una vita umana sana dal punto di vista psicologico[7].
Tutto ciò non può essere arbitrariamente stabilito dalla persona. Anzi, per Yalom è proprio la mancata esperienza di senso la causa principale del disagio psichico. Non soltanto la fiducia, ma anche la speranza che tali regolarità si ripresentino nel tempo successivo sono alla base di ogni possibile progetto e iniziativa.
La spiegazione
La spiegazione è il punto di arrivo del metodo, la capacità di rendere intelligibile ciò che si osserva. L’intelligibilità, come si notava a proposito delle invenzioni, è presente nella vita ordinaria ed è la sua condizione di possibilità. Senza di essa non si dà vita umana, ma caos.
Anche la spiegazione non è una questione meramente intellettuale, ma richiede virtù indispensabili, come l’umiltà, la cautela, l’ascolto e la disponibilità a rivedere i propri assunti. La presunta completezza di una teoria è inversamente proporzionale al suo rigore; e il rigore, qualora venga assolutizzato, può comportare unilateralità. Nel 1931, il matematico austriaco Kurt Gödel formula un celebre principio in cui riconosce che un sistema formale può essere o rigoroso o completo, ma non può possedere entrambe le caratteristiche, tali da porlo al riparo da aporie e contraddizioni[8]. Questo principio mostra la sua evidenza, ancora una volta, nel contesto dell’agire ordinario. Sarebbe per lo meno bizzarro se una persona, interrogata circa il motivo per cui ha deciso di recarsi in un determinato posto, rispondesse indicando i muscoli e i nervi coinvolti nel movimento; un effetto analogo susciterebbe chi descrivesse un quadro enumerando gli atomi presenti in esso: «Sul piano epistemico l’atteggiamento di voler tendere sempre verso la teoria più raffinata rappresenta una perdita più che un guadagno. È così perché esistono livelli diversi di realtà […]. La verità riguardo un dato fenomeno viene stabilita attraverso una corrispondenza tra diversi livelli cognitivi»[9]. L’ideale di una spiegazione non è di essere la più completa possibile, ma di risultare idonea alla domanda posta.
Un altro problema legato alla spiegazione è stabilire quando l’ambito della ricerca debba considerarsi concluso. Esso ci pone nuovamente di fronte alla responsabilità decisionale del soggetto, ai suoi interessi, al suo approccio alla realtà e, soprattutto, al valore simbolico e affettivo che la teoria proposta acquista ai suoi occhi. Atteggiamenti ancora una volta agli antipodi di uno sguardo asettico e distaccato, di mera registrazione dei fatti.
L’interpretazione
Ogni spiegazione è sempre una interpretazione, e per la sua possibile attribuzione di significato si richiede, oltre al dato, la conoscenza del contesto, dell’orizzonte di riferimento: un’azione come bruciare l’incenso, ad esempio, può essere descritta come interazione di fattori chimici, ma anche come un gesto liturgico. Interpretazioni differenti, ma non per questo arbitrarie. Le attuali ricerche sulla mente umana mostrano come la varietà di proposte non commensurabili tra loro siano legate alla struttura stessa dell’essere umano, alla sua maniera di relazionarsi nei confronti di sé stesso, degli altri e del mondo circostante. Nell’arco della giornata la medesima persona può essere chiamata a svolgere ruoli diversissimi, che richiedono «regole del gioco» differenti. Un rilievo simile può essere fatto per l’approccio alla realtà esterna. Una montagna può essere osservata con gli occhi del geologo, del poeta, del geografo, del rocciatore, dello sciatore, del turista, del fotografo, del pittore, del mistico ecc. La montagna è sempre la stessa, ma ciò che è differente è lo sguardo dell’osservatore, il suo mondo interiore, che lo porta a cogliere alcuni aspetti piuttosto che altri. È l’approccio multidimensionale proprio dell’essere umano.
Jerome Bruner, uno psicologo cognitivo statunitense, ha introdotto a questo proposito il concetto di «mente a più dimensioni», intendendo con questo termine le molteplici operazioni cognitive del soggetto, che a loro volta si traducono in scelte e attività differenti: «Culture diverse coltivano e fanno sviluppare talenti diversi, diverse forme di “intelligenza”. Addirittura le definiscono […]. Le nostre menti generano non soltanto versioni della realtà conformemente alla cultura, versioni canoniche e congruenti con credenze culturali consolidate circa la “realtà”, ma altresì, grazie alla nostra capacità di immaginazione, una serie di mondi possibili che potrebbero esistere, che forse esistono o che potremmo auspicare»[10].
Da qui l’implicazione etica presente in ogni interpretazione: tali molteplici approcci possono essere valutati come una ricchezza o come una minaccia. L’equilibrio riflessivo, rispettoso della complessità e desideroso di conoscere punti di vista differenti, è un esempio di atteggiamento etico che favorisce la maturità umana. La pretesa spiegazione neutrale, priva di qualsiasi prospettiva, si rivela ancora una volta un grave impoverimento dell’esperienza umana[11].
La disponibilità al dialogo tra differenti prospettive consente anche di guardarsi dal rischio, uguale e opposto, del relativismo contestuale: anch’esso è infatti caratterizzato dalla considerazione della molteplicità in termini di minaccia. La pluralità della mente apre a una varietà di mondi possibili, nessuno dei quali ha maggiore diritto di cittadinanza. Inoltre, aiuta a prendere consapevolezza del ruolo degli affetti e delle aspettative: essi, come si notava, non di rado sono le motivazioni più rilevanti, che possono favorire o ostacolare la ricerca.
Ripercorrendo la storia della scienza, Karl Popper nota sconsolato: «Se dovessimo contare sulla imparzialità degli scienziati, la scienza, perfino la scienza naturale, sarebbe del tutto impossibile»[12]. Il pensiero «scientifico» è costellato di pregiudizi, aspettative, illusioni, segni della presenza di mondi molteplici che si intersecano tra loro e ai quali per lo più non si fa caso. Si pensi, ad esempio, in sede medica, alle forti resistenze ad accettare il legame tra contagio e igiene ipotizzato dal dottor Ignaz Philipp Semmelweis nel XIX secolo per spiegare l’alta mortalità delle puerpere. Nonostante la drastica riduzione di mortalità nei reparti, l’équipe medica si rifiutò di lavarsi le mani dopo aver toccato i cadaveri, e destituì il medico, fino a internarlo in manicomio, dove subì violenze e umiliazioni di ogni tipo: «Si resta stupiti che uomini competitivi e altamente specializzati, potessero – nella propria scienza – rimanere così ciechi e stupidi»[13].
Tra i presupposti «tossici» ma duri a morire in campo scientifico si possono ricordare la tendenza a mischiare acque bianche e acque nere nelle città europee fino alla fine dell’Ottocento (alla base delle frequenti e micidiali epidemie di colera e di peste), o la convinzione di poter curare la sifilide con l’unguento di mercurio (da qui il detto circolante tra gli ammalati: «una notte con Venere e una vita con Mercurio»). D’altra parte, proprio la rilevazione della loro non plausibilità costituisce un’ulteriore conferma del fatto che è possibile appurare la verità o falsità degli asserti anche in presenza di contesti che sembrerebbero impedirlo.
La disponibilità a rivedere i propri assunti senza chiudere il confronto è dunque un atteggiamento etico indispensabile per la mentalità scientifica; accogliere un cambiamento di paradigma può essere considerato, per riprendere un’affermazione di Thomas Kuhn, una vera e propria forma di conversione, che l’avvicina a quello che la riflessione classica chiama «saggezza pratica». In tal senso, il ricercatore «virtuoso» (nel senso aristotelico) si mostra capace di bilanciare fiducia nelle proprie valutazioni e disponibilità ad accettare che il corso successivo degli eventi possa smentirle, per accoglierne altre, più rispettose della complessità[14].
La ricerca come arte di vivere
Il rapporto tra scienza e virtù ha caratterizzato la filosofia fin dal suo sorgere. Essa infatti nasce come arte di vivere; le sue indagini, pur attraversando i campi più diversi del sapere, avevano lo scopo di educare a riconoscere e praticare il bene: un significato smarrito nel corso dell’età moderna e recentemente riproposto, soprattutto grazie ai contributi dei filosofi Pierre Hadot e di Michel Foucault. Ci si chiede dunque in qual modo, nel contesto odierno, le scienze possano favorire tale significato originario.
Prendendo in considerazione alcuni passaggi dell’indagine scientifica – osservazione, metodo, spiegazione, interpretazione –, si è visto come essi tendano – in linea con le analisi di Hadot e Foucault – a plasmare la personalità, a dialogare con le sue credenze e la più generale rappresentazione del mondo. E, nel porre le domande ultime dell’esistenza, scienza e filosofia incrociano il sapere teologico.
Nello stesso tempo va anche precisato che, a differenza dell’indagine scientifica, l’uomo, per praticare l’arte di vivere, non può semplicemente appropriarsi delle scoperte fatte da chi lo ha preceduto. Ognuno è chiamato a percorrere per conto proprio il cammino verso la saggezza, senza limitarsi a ripetere chi lo ha preceduto. La riflessione sapienziale può tuttavia essere favorita da maestri, educatori, amici, testi che hanno lasciato un segno nell’animo, esempi di persone che nel campo della ricerca si sono distinte per l’onestà e la professionalità. In questo senso, anche gli atteggiamenti mostrati dalla vicenda di molti uomini di scienza possono costituire un contributo importante per l’arte di vivere.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2022
Riproduzione riservata
***
[1]. Cfr L. Caruana, Scienza e virtù. Uno studio sull’impatto della mentalità scientifica sul carattere morale, Roma, Gregorian & Biblical Press, 2021, 34; J. Locke, Saggio sull’intelletto umano, Milano, Bompiani, 2012, l. II, cap. VIII, 9.
[2]. Ivi, 42; cfr 29 s.
[3]. Ivi, 58.
[4]. Ivi, 71. Cfr D. Hume, Trattato sulla natura umana, Milano, Bompiani, 2001, 3, sc. 12.
[5]. Come confessò in seguito Wilbur, parlando di come progettò il primo aeroplano: «La mia immaginazione raffigura le cose in modo più vivido dei miei occhi» (W. Wright, «Lettera alla sorella», 8 giugno 1907, in F. C. Kelly [ed.], Miracle at Kitty Hawk: the Letters of Wilbur and Orville, New York, Straus & Young, 1996, 212).
[6]. L. Caruana, Scienza e virtù…, cit., 83.
[7]. Cfr I. D. Yalom, Guarire d’amore. I casi esemplari di un grande psicoterapeuta, Milano, Rizzoli, 1990, 18.
[8]. Cfr K. Gödel, «Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme», in Monatshefte für Mathematik und Physik 38 (1931) 173-198. Sul rapporto verità-dimostrazione, cfr D. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: un’eterna ghirlanda brillante, Milano, Adelphi, 1979; G. Gamow, Trent’anni che sconvolsero la fisica. La storia della teoria dei quanti, Bologna, Zanichelli, 1966.
[9]. L. Caruana, Scienza e virtù…, cit., 111.
[10]. J. Bruner, La mente a più dimensioni, Bari, Laterza, 2009, VIII.
[11]. «Lo scientismo consiste essenzialmente in una forma di spiegazione che è priva dell’idea di dipendenza dal contesto. Consiste in un tipo di spiegazione in cui viene ammesso solo un punto di vista corretto, rispetto a cose o eventi, e dove è ammesso solo il fisicalismo. Perciò, il caso dello scientismo mostra che tralasciare la dipendenza della spiegazione dal contesto non fa bene all’individuo e si associa ad una condizione di vita che impedisce un vero sviluppo umano» (L. Caruana, Scienza e virtù…, cit., 130; cfr 122).
[12]. K. Popper, Miseria dello storicismo, Milano, Feltrinelli, 1984, 136. Cfr G. Cucci, «Il potere dell’illusione», in Civ. Catt. 2018 IV 338-351.
[13]. M. Manzotti, «Perché lavare le mani: storia di un grande incompreso».
[14]. Cfr T. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Einaudi, 1979, 179-183; N. R. Hanson, I modelli della scoperta scientifica. Ricerca sui fondamenti concettuali della scienza, Milano, Feltrinelli, 1978.