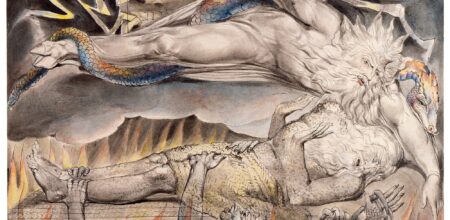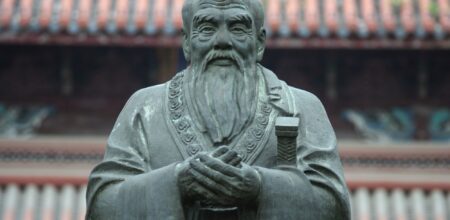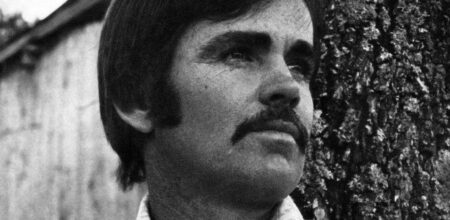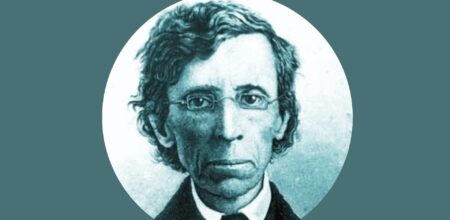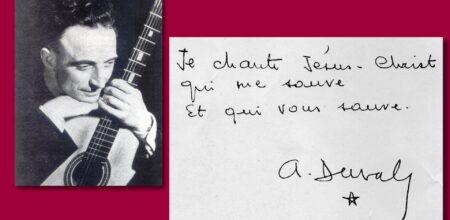|
|
La parola «discernimento» – nonostante la sua presenza antica nella tradizione spirituale della Chiesa – ha avuto maggiore rilevanza dall’inizio del pontificato di papa Francesco, ossia negli ultimi 10 anni. Non stupisce, perciò, che il Pontefice, tra il 31 agosto 2022 e il 4 gennaio 2023, abbia dedicato proprio a questo argomento 14 delle sue catechesi settimanali durante le udienze generali del mercoledì. Con un linguaggio allo stesso tempo semplice e profondo, papa Francesco presenta come esempio sant’Ignazio di Loyola e prende spunto dai suoi insegnamenti per ricordare e spiegare i princìpi, gli elementi e la pratica del discernimento spirituale. La lettura delle 14 catechesi costituisce una guida efficace a tale pratica, senz’altro indispensabile per chi vuole leggere la propria vita e prenderla in mano, facendo delle scelte che scaturiscano da un rapporto personale con il Signore[1].
Sebbene si riconosca, sin dalla prima catechesi, che il discernimento è un esercizio di intelligenza e di perizia, il vocabolario usato appartiene soprattutto al campo delle emozioni. Basti dire che, nell’insieme delle catechesi, la parola «cuore» compare ben 80 volte, «desiderio» o «desideri» 38 volte, e «affetto» o «affetti» 19 volte. Quindi, si può affermare subito che la lettura spirituale della propria vita, essenziale per qualsiasi processo di discernimento, è un esercizio di intelligenza e di perizia che si basa sulla lettura delle proprie emozioni, ossia sull’ascolto del proprio cuore. D’altra parte, un vero processo di discernimento è inseparabile dal desiderio di cercare e di adempiere la volontà di Dio, sapendo che Egli vuole unicamente il bene dei suoi figli. Con le parole di papa Francesco, «in tutto questo si concretizza un progetto di vita, e anche si concretizza la nostra relazione con Dio»[2], nella consapevolezza che le decisioni adulte sono personali e non delegabili. Un tale appello alla coscienza personale non esclude – anzi, per un cristiano richiede – un processo dialogico, per cui «in una decisione buona, giusta, si incontra la volontà di Dio con la nostra volontà; si incontra il cammino attuale con l’eterno»[3].
Arrivare a una decisione giusta, pur se preceduta dalla fatica della ricerca, «ti benefica di gioia», afferma il Papa, aggiungendo: «[La vita] dobbiamo deciderla continuamente, secondo le realtà che vengono. Dio ci invita a valutare e a scegliere: ci ha creato liberi e vuole che esercitiamo la nostra libertà»[4], pur ricordandoci che siamo creature, che non siamo noi il criterio del bene e del male e che le scelte personali hanno sempre delle conseguenze per noi, per gli altri e per il mondo. Fondamentalmente, il discernimento si pone sempre una domanda sull’amore: quale scelta è «un segnale di più amore, di più maturità nell’amore»[5], parole in cui possiamo identificare l’eco del magis del «Principio e fondamento» degli Esercizi Spirituali ignaziani, che ci esorta a desiderare e a scegliere «solo ciò che più ci porta al fine per cui siamo stati creati»[6].
Gli elementi del discernimento
Dopo la prima catechesi introduttiva e la presentazione di sant’Ignazio di Loyola come esempio, papa Francesco dedica quattro catechesi agli elementi del discernimento: la familiarità con il Signore, conoscere sé stessi, il desiderio e, infine, il libro della propria vita.
La familiarità con Dio, ovvero la preghiera, è indispensabile perché «è saper andare oltre i pensieri, entrare in intimità con il Signore, con una spontaneità affettuosa» che rende più facile, come capita nella vita dei santi, «riconoscere quello che a Lui è gradito»[7]. È questa familiarità che aiuta all’identificazione della volontà di Dio con il nostro bene, allontanando la tentazione dell’incertezza o del timore che non sia proprio così. La preghiera affettiva «in modo graduale ma efficace ci rende sempre più capaci di riconoscere ciò che conta per connaturalità, come qualcosa che sgorga dal profondo del nostro essere»[8].
Conoscere sé stessi è il secondo degli elementi del discernimento. Si tratta di un elemento essenziale, perché il discernimento «coinvolge le nostre facoltà umane: la memoria, l’intelletto, la volontà, gli affetti»[9]. La conoscenza di sé richiede la capacità di fermarsi per rendersi consapevole del modo di fare, dei sentimenti e dei pensieri che ci condizionano. «Richiede anche di distinguere tra le emozioni e le facoltà spirituali», per cui – sottolinea il Papa – «“sento” non è lo stesso di “sono convinto”; “mi sento di” non è lo stesso di “voglio”»[10]. Da qui nasce una domanda decisiva: «Sono libero o mi lascio andare ai sentimenti del momento, o alle provocazioni del momento?»[11]. Fondamentale per la conoscenza di sé è l’esame di coscienza, per rileggere quello che è capitato durante la giornata, non tanto alla ricerca dei peccati, ma piuttosto per «vedere il percorso dei sentimenti, delle attrazioni nel mio cuore»[12] e così crescere nella libertà.
Il terzo elemento del discernimento è il desiderio che, per i maestri spirituali, «è una nostalgia di pienezza che non trova mai pieno esaudimento, ed è il segno della presenza di Dio in noi»[13]. Come punto di riferimento, il desiderio «evoca una sofferenza, una carenza, e nello stesso tempo una tensione per raggiungere il bene che ci manca. Esso, allora, è la bussola per capire dove mi trovo e dove sto andando»[14], cercando di concretizzarlo. Il dialogo con il Signore ci aiuta a capire che cosa veramente vogliamo, ossia come si manifesta la nostra libertà, la quale, come progetto a lunga scadenza, non si confonde con la soddisfazione del desiderio del momento.
Infine, il quarto elemento del discernimento è la propria storia di vita che, nelle parole di Francesco, è «il “libro” più prezioso che ci è stato consegnato»[15]: un libro in cui, se rientriamo in noi stessi con serenità, possiamo trovare la verità e Dio stesso, come ci è testimoniato da sant’Agostino. In questo senso, «abituarsi a rileggere la propria vita educa lo sguardo, lo affina, consente di notare i piccoli miracoli che il buon Dio compie per noi ogni giorno»[16]. Il discernimento implica, quindi, «la lettura narrativa dei momenti belli e dei momenti bui, delle consolazioni e delle desolazioni che sperimentiamo nel corso della nostra vita. Nel discernimento è il cuore a parlarci di Dio, e noi dobbiamo imparare a comprendere il suo linguaggio»[17]. Questo linguaggio è, appunto, al centro delle quattro catechesi successive del Papa, dedicate alla desolazione e alla consolazione.
Il linguaggio della desolazione e della consolazione
Parlando della desolazione, papa Francesco riprende la definizione di sant’Ignazio di Loyola: «L’oscurità dell’anima, il turbamento interiore, lo stimolo verso le cose basse e terrene, l’inquietudine dovuta a diverse agitazioni e tentazioni: così l’anima si inclina alla sfiducia, è senza speranza, e senza amore, e si ritrova pigra, tiepida, triste, come separata dal suo Creatore e Signore»[18]. La desolazione va letta nel contesto del «libro della vita». Essa può essere il rimorso, che è un’occasione per cambiare vita, ossia un invito a percorrere una nuova strada; e può essere anche la tristezza, che diventa un «indispensabile campanello di allarme per la vita, invitandoci a esplorare paesaggi più ricchi e fertili che la fugacità e l’evasione non consentono»[19]. Tenendo presenti le regole di sant’Ignazio per il discernimento degli spiriti, il Papa ricorda che «per chi invece ha il desiderio di compiere il bene, la tristezza è un ostacolo con il quale il tentatore vuole scoraggiarci»[20]; per questo si deve rimanere fedeli a ciò che ci si era proposti di fare, affrontando le difficoltà e ricordandosi che la strada verso il bene «è stretta e in salita, richiede un combattimento, un vincere sé stessi»[21]. Non cedere alle difficoltà ci rafforza «sotto l’aspetto umano e spirituale» e ci fa capire che il Signore non ci abbandona mai[22].
La desolazione può anche essere vista come un invito alla gratuità, «a non agire sempre e solo in vista di una gratificazione emotiva»[23]. Anche nel buio, si cerca il Dio vivente, che è irriducibile alle nostre categorie. Ecco, allora, le parole incoraggianti di papa Francesco: «Non avere paura della desolazione, portarla avanti con perseveranza, non fuggire. E nella desolazione cercare di trovare il cuore di Cristo, trovare il Signore. E la risposta arriva, sempre»[24].
Per quanto riguarda la consolazione, essa è definita come «un’esperienza di gioia interiore, che consente di vedere la presenza di Dio in tutte le cose; rafforza la fede e la speranza, e anche la capacità di fare il bene»[25]. La consolazione tocca con soavità e delicatezza il più profondo di noi stessi: «La persona si sente avvolta dalla presenza di Dio, in una maniera sempre rispettosa della propria libertà. Non è mai qualcosa di stonato che cerca di forzare la nostra volontà, non è neppure un’euforia passeggera»; è una pace genuina «che fa germogliare i buoni sentimenti in noi»[26]. Come tale, è un dono dello Spirito Santo e non programmabile a piacere. La consolazione è collegata alla speranza e protesa al futuro. «Mette in cammino, consente di prendere iniziative fino a quel momento rimandate, o neppure immaginate»[27]. Ossia, «ti dà la pace e ti attira verso il Signore e ti mette in cammino per fare delle cose, per fare cose buone»[28]; la consolazione, quindi, ci rende audaci, aiutandoci nell’affrontare le difficoltà.
Podcast | SUD SUDAN. «UN CONFLITTO CHE NON È MAI FINITO»
Quattro milioni di sfollati, oltre 350mila morti, fame e povertà. Il Sud Sudan è il paese più giovane del mondo, con una storia già segnata dalle violenze. Oggi lo spettro della guerra torna a far paura, come racconta mons. Christian Carlassare, vescovo della diocesi di Bentiu. Ascolta il podcast
Va detto che, anche davanti alle consolazioni, occorre fare attenzione: «Se la consolazione autentica è come una goccia su una spugna, è soave e intima, le sue imitazioni – così si esprime il Pontefice – sono più rumorose e appariscenti, sono puro entusiasmo, sono fuochi di paglia, senza consistenza, portano a ripiegarsi su sé stessi, e a non curarsi degli altri. La falsa consolazione alla fine ci lascia vuoti, lontani dal centro della nostra esistenza»[29]; è un entusiasmo passeggero e non ci porta la pace vera. Questo avvertimento solleva la domanda su come riconoscere la consolazione autentica, oggetto di una specifica catechesi in cui papa Francesco ricorda ancora gli insegnamenti di sant’Ignazio di Loyola. Negli Esercizi Spirituali, il Santo spiega che «se nei pensieri tutto è buono, il principio, il mezzo e la fine, e se tutto è orientato verso il bene, questo è un segno dell’angelo buono»[30]. Invece, se si presentano anche dei pensieri cattivi o distrattivi, agitazione e assenza di pace, allora si tratta di «un chiaro segno che quei pensieri provengono dallo spirito cattivo»[31]. Di nuovo, occorre riflettere su ciò che succede nel proprio cuore, consapevoli che lo Spirito Santo ci accompagna e agisce in noi.
«La consolazione autentica – conclude papa Francesco – è una sorta di conferma del fatto che stiamo compiendo ciò che Dio vuole da noi»[32] e che il nostro discernimento ha avuto come oggetto non tanto il bene o il massimo bene possibile, bensì «ciò che è bene per me qui e ora: su questo sono chiamato a crescere, mettendo dei limiti ad altre proposte, attraenti ma irreali, per non essere ingannato nella ricerca del vero bene»[33]. Inoltre, una consolazione autentica che conferma la decisione presa «comunica una pace che dura nel tempo» e che porta «armonia, unità, fervore, zelo»[34]. È anche segno della bontà della decisione vederla come una «risposta all’amore e alla generosità che il Signore ha nei miei confronti. Non nasce da paura, non nasce da un ricatto affettivo o da una costrizione, ma nasce dalla gratitudine per il bene ricevuto, che muove il cuore a vivere con liberalità la relazione con il Signore»[35]. Un ulteriore elemento di conferma «è la consapevolezza di sentirsi al proprio posto nella vita», come pure il «sentirsi parte di un disegno più grande, a cui si desidera offrire il proprio contributo»[36]. Infine, segno di conferma è anche il fatto che la persona avverta «una crescente integrazione tra i suoi molteplici interessi», stabilisca una «corretta gerarchia di importanza» e riesca a «vivere tutto ciò con facilità, affrontando con rinnovata energia e forza d’animo le difficoltà che si presentano»[37].
Gli aiuti per il discernimento e l’accompagnamento spirituale
Nelle tre ultime catechesi sul discernimento, papa Francesco si sofferma sulla vigilanza, su alcuni aiuti per il discernimento e, infine, sull’accompagnamento spirituale. Dopo la scelta fatta e portata avanti, occorre vigilare, specialmente – potremmo aggiungere – se si tratta di una opzione di vita, ossia di una decisione vocazionale. Questo vuol dire che «il buon discepolo è vigilante, non si addormenta, non si lascia prendere da eccessiva sicurezza quando le cose vanno bene, ma rimane attento e pronto a fare il proprio dovere»[38]. Con realismo, il Papa ricorda che «il rischio c’è, ed è che il “guastafeste”, cioè il Maligno, possa rovinare tutto, facendoci tornare al punto di partenza, anzi, in una condizione ancora peggiore»[39]. La vigilanza richiesta implica «custodire il nostro cuore e capire cosa succede dentro»; si tratta dell’atteggiamento «da tenere nella condotta di vita, in modo che le nostre buone scelte, compiute a volte dopo un impegnativo discernimento, possano proseguire in maniera perseverante e coerente e portare frutto»[40]. Se manca la vigilanza, aumentano i rischi che tutto vada perduto, specialmente – ricorda il Papa – se «noi siamo troppo sicuri di noi stessi» e pensiamo che tutto vada «a gonfie vele». Proprio in questa situazione può arrivare «l’insidia dello spirito cattivo», che «entra con la nostra per uscirne con la sua», perché ci è mancata la vigilanza del cuore, che è segno di saggezza e «soprattutto di umiltà, perché abbiamo paura di cadere e l’umiltà è la via maestra della vita cristiana»[41].
Quali gli aiuti che possono rendere più agevole l’esercizio del discernimento? Nella penultima delle catechesi che stiamo ripercorrendo, il Pontefice ne elenca tre. In primo luogo, è indispensabile il confronto con la parola di Dio e la dottrina della Chiesa, che «ci aiutano a leggere ciò che si muove nel cuore, imparando a riconoscere la voce di Dio e a distinguerla da altre voci, che sembrano imporsi alla nostra attenzione, ma che ci lasciano alla fine confusi»[42]. In fondo – potremmo affermare – si tratta di ribadire che non siamo noi il criterio del bene e del male: questa è la grande tentazione che percorre, sin dalle origini, tutta la storia umana. Nel discernimento cristiano, nella ricerca di ciò che è giusto e buono, il sacrario della coscienza è illuminato dalla parola di Dio e dalla dottrina della Chiesa, appunto perché il processo di decisione personale include l’ascolto umile di Dio e della comunità dei credenti. Un secondo aiuto al discernimento spirituale è la «relazione affettiva con il Signore Gesù», in particolare davanti al Crocifisso: «Chi rimane di fronte al Crocifisso – insegna papa Francesco – avverte una pace nuova, impara a non avere paura di Dio, perché Gesù sulla croce non fa paura a nessuno, è l’immagine dell’impotenza totale e insieme dell’amore più pieno, capace di affrontare ogni prova per noi»[43]. Infine, un terzo aiuto è «il dono dello Spirito Santo, che è presente in noi, e che ci istruisce, rende viva la Parola di Dio che leggiamo, suggerisce significati nuovi, apre porte che sembravano chiuse, indica sentieri di vita là dove sembrava ci fossero solo buio e confusione»[44].
La quattordicesima e ultima catechesi è stata dedicata da papa Francesco all’accompagnamento spirituale, presentato come un ulteriore aiuto alla conoscenza di sé, condizione indispensabile per il discernimento. Si tratta di «guardarsi allo specchio con l’aiuto di un altro»[45], facendosi conoscere, anche negli aspetti più fragili, e lasciandosi accompagnare nel cammino della vita. «Raccontare di fronte a un altro ciò che abbiamo vissuto o che stiamo cercando aiuta a fare chiarezza in noi stessi, portando alla luce i tanti pensieri che ci abitano e che spesso ci inquietano»[46]. L’accompagnatore o l’accompagnatrice «non si sostituisce al Signore, non fa il lavoro al posto della persona accompagnata, ma cammina al suo fianco, la incoraggia a leggere ciò che si muove nel suo cuore, il luogo per eccellenza dove il Signore parla»[47]. Papa Francesco, dopo aver ricordato che la Vergine Maria è maestra di discernimento perché «parla poco, ascolta molto e custodisce nel cuore»[48], ci lascia un’opportuna esortazione finale: il discernimento, se bene appreso, «consente di vivere l’esperienza spirituale in maniera sempre più bella e ordinata. Soprattutto il discernimento è un dono di Dio, che va sempre chiesto, senza mai presumere di essere esperti e autosufficienti»[49].
* * *
Possiamo concludere che la lettura di queste catechesi di papa Francesco conferma l’importanza decisiva, nella vita cristiana, dell’ascolto sincero del proprio cuore nei processi di discernimento. Non si tratta di un invito alla soggettività, oppure al lasciarsi condurre dalle emozioni del momento. Si tratta, invece, di ascoltare il più profondo di sé stessi, là dove Dio parla; si tratta di far emergere i propri desideri più autentici, in modo da trasformarli, con gioia, in una vita piena di significato perché al servizio degli altri in tanti modi possibili. Inoltre, quando il processo di discernimento ha come oggetto una opzione di vita, esso ci porterà a una decisione in cui, guidati dallo Spirito Santo e tolti gli impedimenti, ognuno di noi troverà la propria vocazione, cioè il progetto di felicità che Dio stesso propone alla nostra libertà[50].
Copyright © La Civiltà Cattolica 2023
Riproduzione riservata
***
-
Cfr Papa Francesco, Sul discernimento, Bologna, EDB, 2023. Il volume, a cura di p. Antonio Spadaro, contiene un ampio saggio a firma di Miguel Ángel Fiorito S.I. e Diego Fares S.I., apparso in due parti sulla nostra rivista. ↑
-
Francesco, Catechesi del 31 agosto 2022. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ignazio di Loyola, s., Esercizi Spirituali, n. 23. Sull’eredità spirituale di sant’Ignazio di Loyola, cfr G. Cucci – M. Marelli, «Gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio: una proposta ancora valida?», in Civ. Catt. 2019 III 223-237. ↑
-
Francesco, Catechesi del 28 settembre 2022. ↑
-
Ivi. ↑
-
Id., Catechesi del 5 ottobre 2022. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Id., Catechesi del 12 ottobre 2022. ↑
-
Ivi. ↑
-
Id., Catechesi del 19 ottobre 2022. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ignazio di Loyola, s., Esercizi Spirituali, n. 317. ↑
-
Francesco, Catechesi del 26 ottobre 2022. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Cfr ivi. ↑
-
Id., Catechesi del 16 novembre 2022. ↑
-
Ivi. ↑
-
Id., Catechesi del 23 novembre 2022. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ignazio di Loyola, s., Esercizi Spirituali, n. 333. ↑
-
Ivi. ↑
-
Francesco, Catechesi del 23 novembre 2022. ↑
-
Ivi. ↑
-
Id., Catechesi del 7 dicembre 2022. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Id., Catechesi del 14 dicembre 2022. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Id., Catechesi del 21 dicembre 2022. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Id., Catechesi del 4 gennaio 2023. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Ivi. ↑
-
Si veda, a questo proposito, V. Pinto de Magalhães, Vocação e vocações, Braga, Editorial A.O., 2005. Di grande utilità per queste tematiche è J. Garcia de Castro (ed.), Diccionario de espiritualidad ignaciana, 2 voll., Bilbao – Santander, Mensajero – Sal Terrae, 2007. Per l’influsso che ha avuto su papa Francesco, va menzionato M. Á. Fiorito, Cercare e trovare la volontà di Dio: guida pratica agli Esercizi spirituali di sant’Ignazio di Loyola, Milano, Àncora, 2021. ↑