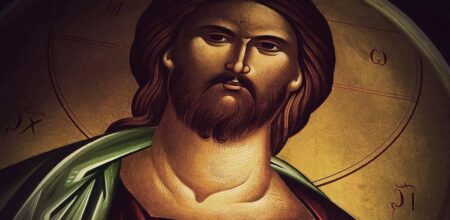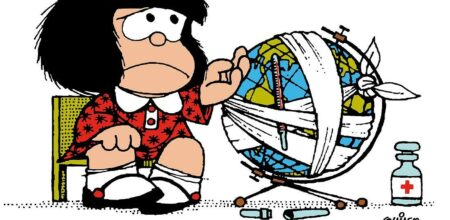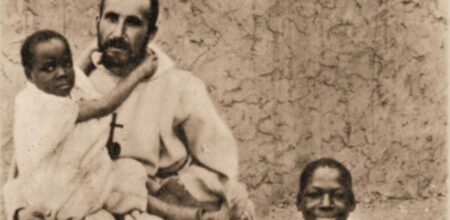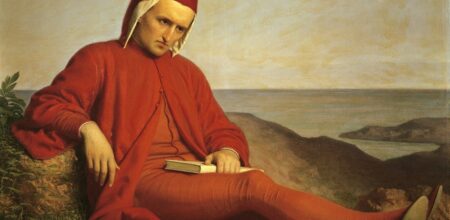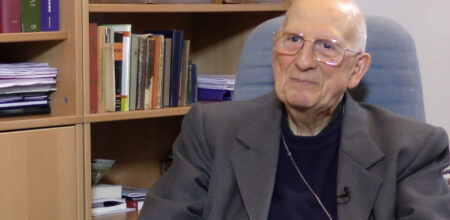|
|
Il testo è utile per iniziare a conoscere il contenuto del messaggio della poetessa Alda Merini (1931-2009), anche per questo semplice rilievo: avvicinarsi a lei a partire da quel di più, che è il «già», e da quel di meno, che è il «non-ancora». Termini teologici e teleologici, entro i quali si colloca il dramma e la ricerca di senso, vissuti come prova concessa alla poetessa per fare di lei un’eletta «attraverso il crogiolo della sofferenza» (p. 153).
Edi Natali, filosofa e teologa, membro del primo Consiglio ecclesiastico di donne della diocesi di Pistoia, offre ai lettori uno studio, inteso come apripista, nel contesto di un «sostanziale deserto critico» (p. 23) esistente nei confronti della Merini. Il suo contributo mira al superamento di tre limiti ben noti: 1) l’impossibilità di praticare una completa ricostruzione storica e critica delle opere della poetessa, derivante dalla mancanza di una bibliografia completa ed esaustiva; 2) l’esistenza di tematiche superconsiderate a vantaggio di altre ritenute erroneamente marginali; 3) l’assenza di un’analisi critica, autentica e completa, della produzione letteraria della Merini, dal momento che essa è tuttora oggetto di un approccio prevalentemente letterario.
La «Bibliografia su Alda Merini» e la «Bibliografia secondaria», presentate alla fine del testo, sono un invito ad addentrarsi nel messaggio della Merini e a contribuire al superamento delle difficoltà sopra accennate.
Il testo è suddiviso in tre macrosezioni. La prima – «Schegge di vita» – è dedicata all’insorgere del male e all’incombere della follia nella Merini, in funzione di un avvertire Dio come il più intimo e il più assente. Segue l’excursus «Il manicomio dalla legge Giolitti (1904) alla legge Basaglia sulla storia del manicomio»: per l’autrice, «penetrare nei rivoli della storia del manicomio permette di entrare in un climax che è indispensabile per leggere la poesia-testimonianza» (p. 77) della Merini nel periodo della degenza e oltre.
La terza sezione si compone di due capitoli. Nel primo – «Ho vissuto dieci anni nella giungla odorosa di salici, ero una rosa dormiente…» – viene esaminata la produzione della poetessa risalente al periodo dell’internamento. Il secondo capitolo – «E questa è la fede» – fa riferimento agli anni seguenti. È molto difficile separare il percorso del prima da quello del dopo, dal momento che dalla sofferenza radicale della poetessa si sprigiona quello sconfinamento mistico che la conduce a stare ai piedi di Dio, «un Dio luminoso e al tempo stesso oscuro […], capace di togliere lei a se stessa […], in un processo che richiama il distacco della mistica» (p. 70).
Sì, ci furono giorni dei quali la Merini scrisse: «Mi legarono mani e piedi e in quel momento, in quel preciso momento, vissi la passione di Cristo». Ma ad essi seguirono giorni in cui, come lei afferma, «tornai ad incontrare le margheritine, le violette. Dio!». Partire, nel corso di una sosta che segue una lunga sofferenza, da un punto di riferimento certo, sicuro, per aprirsi, immergersi nella Luce che non avrà mai fine. L’incipit umano è nella fame d’amore. Quello stesso amore di cui, secondo la Merini, Cristo stesso confessa di aver bisogno, quando dice di sé: «Mi appesero a una croce… Quello che tutti gli uomini non avevano capito è che io, il Figlio di Dio fatto uomo, il Messia, avevo soltanto sete di amore». La ricapitolazione è in Dio: decantarci è compito suo, ma dopo l’attraversamento della croce di Cristo.
L’autrice ama presentare la Merini mentre trascrive frammenti di sussurri, ascoltati dal Mistero, stando in ginocchio sul selciato (p. 17). A imitazione del Cristo nell’Orto degli Ulivi o nel senso del logion evangelico riferito al seme che, per portare frutti, muore.
EDI NATALI
Se decantarmi può solo Dio… La poesia e le notti di Alda Merini
Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2019, 272, € 19,00