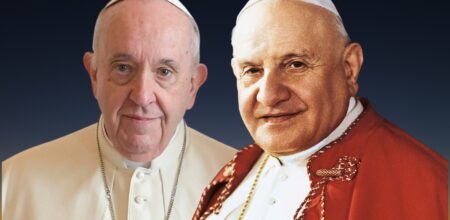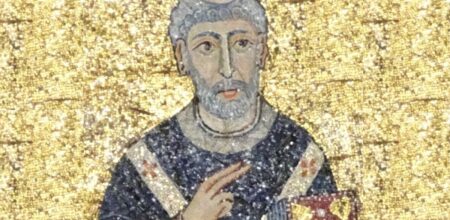|
|
Le assonanze bibliche interne al romanzo Moby-Dick si fanno sentire sin dal famoso incipit: «Chiamatemi Ishmael», per arrivare alla citazione finale di un versetto del libro di Giobbe: «E io solo sono scampato, a raccontartela». Esse alimentano cifre interpretative allegoriche (la balena come il Leviatano; la caccia al mostro come l’inseguimento di una forza creatrice e risanatrice, e però anche come la perenne lotta contro un male irriducibile; il cacciatore ferito, ossessionato da propositi di vendetta) e suggeriscono domande inquietanti per ogni lettore che abbia avvicinato questo testo misterioso.
Si tratta davvero di un romanzo? Il libro, pubblicato nel 1851, contiene non solo la narrazione di un interminabile inseguimento sulla baleniera «Pequod», ma anche un’etimologia (fornita da un intisichito ex assistente di ginnasio), degli estratti (redatti da un vice-vice bibliotecario), inserti enciclopedici sui cetacei e sulle loro rappresentazioni più o meno pertinenti, interpolazioni storiche, naturalistiche o mitologiche, un epilogo enigmatico («Il dramma è finito. Perché allora qualcuno si fa avanti? Perché uno è sopravvissuto alla distruzione»).
L’autore reale, Herman Melville, nacque a New York nel 1819, terzo di otto figli, si imbarcò come mozzo per diversi viaggi (nel 1841 a bordo di una baleniera); visse per quattro mesi con gli indigeni cannibali delle Isole Marchesi e successivamente tornò a New York; iniziò a scrivere con alterno successo; lavorò in dogana, pur di mantenere la famiglia, e morì sempre a New York nel 1891.
Il suo capolavoro, Moby-Dick appunto, è un’«opera-mondo», un’opera «balena» (whale, «balena», ricorda la parola whole, «intero, tutto»), in cui Melville adotta stili disparati, pur di riversare nelle pagine un multiverso di fatti, esperienze e vissuti, documentando i conflitti fra sorte (casualità), libertà e necessità (meccanismi fisici e destino fatale).
Lo scrittore utilizza e spreme i generi tradizionali, li combina, li confronta tra loro e poi li abbandona, dopo averli estenuati e trasfigurati. La prosa avvolge frasi e parole come una corrente silenziosa ma corrosiva e, al suo passaggio, disarticola le convenzioni linguistiche e semantiche, cosicché il lettore è costretto ad abbandonarsi al fascinoso succedersi e naufragare dei capitoli, senza garanzie ultime di ritrovarsi integro. Si avverte presto che l’opera resterà aperta e l’indagine esistenziale di Ishmael non verrà conclusa.
Il breve, ma denso saggio di Giorgio Mariani, docente di letteratura americana alla «Sapienza» di Roma, ci aiuta a esporci consapevolmente alle prove insidiose di una Great American Novel, un’avventura marinara dal respiro universale e dallo spessore epico paradigmatico per un’intera nazione (un nuovo mondo, desideroso di possedere una propria tradizione letteraria), un libro scottante, che fu riabilitato solo a partire dagli anni Venti del secolo scorso.
Vengono analizzati i precedenti del romanzo, i suoi elementi strutturali, le forme lessicali, i piani allegorici, le meta-narrazioni coinvolte, gli epigoni drammaturgici e, soprattutto, i personaggi, a partire dal capitano Achab, che odia la bianca, enorme balena (a causa della quale ha perso una gamba) e la insegue sui mari di tre quarti del Globo, contagiando l’intero equipaggio con la sua ipnotica paranoia. Al suo dispotismo resiste Ishmael, il democratico, malinconico superstite, testimone e narratore della vicenda.
Moby-Dick è un’opera privilegiata per intraprendere un’indagine sulla natura del mondo, sui confini della mente, sul conflitto etico-religioso e infine sull’identità di un Dio inafferrabile, che si sottrae ai vincoli delle definizioni oggettive e non si lascia arpionare né da una devozione miracolistica né da un opportunistico assoggettamento idolatrico.
È un libro (anche) per teologi, dato che tutti i personaggi sono alla ricerca – quest è il termine adottato dalla critica più accorta – di un senso vitale, che li abiliti a sperare nella vittoria sul male.
GIORGIO MARIANI
Melville: guida a Moby-Dick
Roma, Carocci, 2022, 136, € 13,00.