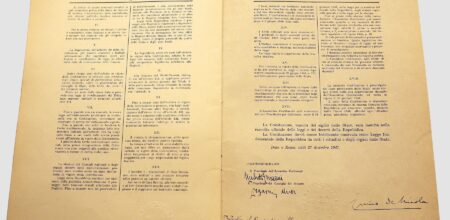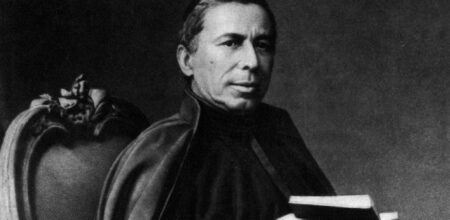Riccardo fu un canonico agostiniano del XII secolo. Originario della Scozia, entrò nell’abbazia di San Vittore, presso Parigi, divenendone anche abate. Meno conosciuto di Ugo, si distinse per una serie di opere ascetiche e mistiche, nonché per un De Trinitate. In un precedente Beniamino minore, aveva trattato di come preparare l’anima alla contemplazione. Qui invece, nel Beniamino maggiore, affronta direttamente il suo tema preferito.
Il titolo dell’opera dovrebbe essere in realtà L’arca dell’Alleanza, perché l’A. fa una lettura allegorica dell’arca fatta costruire da Mosè secondo le indicazioni divine (cfr Es 25,10-22). Una tale lettura era favorita dai diversi elementi che componevano l’arca: la struttura di legno di acacia; il rivestimento d’oro puro; i quattro anelli d’oro; le due stanghe di legno di acacia rivestite d’oro; il propiziatorio d’oro puro e i due cherubini d’oro. Questa struttura suggeriva l’idea di un ordine, non però statico, ma dinamico.
Riccardo sviluppa così uno dei temi più cari della spiritualità, a partire da Origene, e cioè che la vita spirituale è un cammino, fatto di inizi, di tappe successive e di una conquista della meta finale. L’immagine che domina queste pagine è dunque «la metafora del movimento» (p. XXII). Seguendo la scuola agostiniana, l’A. privilegia una prospettiva antropologica, «soffermandosi più che sull’oggetto della contemplazione, sulle possibilità che l’uomo ha a sua disposizione» (p. XXI).
Da dove partire, dunque? Da buon medievale, Riccardo risponde: dai sensi, sì dai cinque sensi. Non c’è niente nella mente che non parta prima dai sensi. Anche qui c’è una lunga tradizione, quella dei «sensi spirituali», iniziata da Origene, utilizzata da Agostino (basta rileggere il sero te amavi!) e sviluppata da Bonaventura. Contemplare con i sensi è vedere, sentire, gustare, toccare le cose per ciò che sono, cioè creature che portano in sé la traccia del Creatore. Questo è il primo passo. Il termine è dato dalla «possibilità dell’uomo di tornare alla comunione con Dio» (p. XI). E si tratta veramente di un «tornare a casa», poiché l’uomo è stato creato «a immagine di Dio» e «secondo la sua somiglianza».
È un cammino però che deve tener conto della condizione storica dell’uomo, il quale, nonostante questa spinta interiore verso Dio, sente le resistenze della sua finitudine, e soprattutto del suo orgoglio, che non vuole riconoscersi dipendente dall’altro. Ma quando l’Altro è Dio, cioè il Bene, la Verità e l’Amore, riconoscersi dipendenti non è umiliazione, bensì elevazione. Quindi, sebbene sia circondato dalla grazia, dall’inizio alla fine, l’uomo tuttavia rimane libero. Sono sorprendenti le affermazioni di Riccardo sulla libertà umana, perché, «mentre la razionalità è stata offuscata e condizionata dal peccato, la libertà non è stata minimamente compromessa: l’uomo è rimasto libero, nonostante si trovi in una condizione resa debole dal peccato» (p. XIV).
L’introduzione di sr. Mary Melone, da cui abbiamo tratto queste citazioni, è un’ottima premessa alla comprensione di un testo per molti aspetti lontano dalla sensibilità odierna, ma per altri aspetti ancora attuale. Basti ricordare che «fino all’epoca di Teresa d’Avila, Riccardo fu considerato il punto di riferimento per la teologia mistica e la dottrina della contemplazione. Ne danno conferma, ad esempio, Dante, che nel X canto del Paradiso, vv. 130-132, non esita ad affermare che Riccardo “a considerar fu più che viro”, come pure lo stesso Bonaventura, che lo ritiene “maestro” nella contemplazione» (p. XXI).
Riguardo al traduttore, p. Antonio Orazzo, sappiamo quanto il suo lavoro sia affidabile, data la sua lunga frequentazione degli autori patristici e medievali. Merita però segnalare quanto lui stesso annota, e cioè che per i testi biblici ha seguìto una sua traduzione, e questo per uniformare il commento al testo così come lo leggeva Riccardo. Ricorrere a traduzioni moderne della Bibbia, come molti fanno, rende a volte incomprensibile l’argomentazione dell’autore patristico o medievale, che si basa sulla Vulgata, spesso diversa dal testo ebraico.
RICCARDO DI SAN VITTORE
La grazia della contemplazione. Beniamino Maggiore
a cura di MARY MELONE – ANTONIO ORAZZO
Campobasso, Diogene Edizioni, 2016, LIII-228, € 25,00