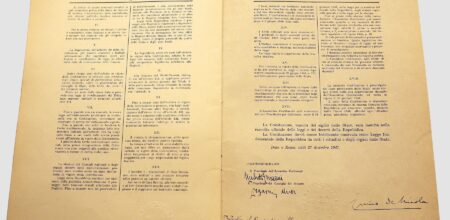|
|
Verismo italiano e naturalismo francese
In continuità con la scapigliatura milanese (1860-80), di cui aveva fatto parte lo stesso Verga – che improntò ad essa i romanzi Eva (1873), Tigre reale (1873) ed Eros (1875) –, e in concomitanza con il naturalismo francese[1], il cui manifesto Le Roman expérimental era stato redatto da Émile Zola nel 1880, nacque in Italia il verismo, che trovò in Luigi Capuana il teorico e in Giovanni Verga il grande novelliere-romanziere.
Zola affondava le sue radici nel positivismo di August Comte; nella «medicina sperimentale», teorizzata da Claude Bernard nel saggio L’ introduzione allo studio della medicina sperimentale (1865); nel positivismo evoluzionistico di Charles Darwin, esposto nel saggio L’ origine della specie (1859); e nell’estetica positivistica di Hippolyte Taine. Per quest’ultimo, l’opera letteraria risente di tre elementi fondamentali: la race (la razza), a cui è legata la teoria dell’ereditarietà, affermata in Italia da Lombroso; le moment (il momento storico), da cui nasce e in cui s’inquadra un’opera letteraria; le milieu (l’ambiente sociale), in cui vivono e da cui sono determinati fatalisticamente i personaggi dell’opera narrativa. Per Taine, anche le attività spirituali sono prodotti necessari di forze materiali. Nella sua opera Saggio sulle favole di La Fontaine (1853), egli afferma: «Si può considerare l’uomo come un animale di specie superiore, che produce filosofie e poemi pressappoco come i bachi da seta formano i loro bozzoli e le api i loro alveari».
Attraverso il naturalismo francese si diffuse anche l’«estetica del bisturi», secondo cui l’opera letteraria è una riproduzione fotografica della realtà e lo scrittore deve analizzarla con la stessa freddezza, impassibilità, impersonalità del chirurgo, che deve evitare ogni emozione nell’operare sui corpi. Taine illustrò la sua estetica nella Filosofia dell’arte e nella Storia della letteratura inglese[2].
Contemporaneamente al naturalismo di Flaubert e di Zola nasce in Italia, particolarmente in Sicilia, il verismo, con le opere teoriche e narrative di Capuana (1839-1915). Nel 1872 egli pubblica il saggio Il teatro contemporaneo, in cui espone l’estetica verista, ma insiste anche sulla notevole differenza tra il verismo italiano e il naturalismo francese, a partire dal nome stesso. Probabilmente egli fa derivare il termine «verismo» dalla commedia Nerone (1871) del romano Pietro Cossa, il quale, nel prologo, si esprime così: «Quanto allo stile e al modo di condurre / le scene, credo che l’autor s’attenne / a quella scola che piglia le leggi / dal “verismo” e, stimando che in ogn’arte / sia bello il vero, bandì dalla scena / il verso ch’à romore e non idea»[3].
Lo studioso Mario Santoro, che ha analizzato l’estetica verista di Capuana e la sua differenza dal naturalismo francese, ha scritto: «Il Capuana distingueva nettamente il nostro “verismo” dal naturalismo. La distinzione riguardava sostanzialmente il metodo narrativo: i naturalisti identificavano la storia del personaggio con una rigorosa inchiesta scientifica, mentre i veristi si limitavano ad “assimilarsi il metodo di osservazione” […], a “imitare proprio la natura che mette al mondo le creature e le abbandona a se stesse e al giudizio della società”. Ma, soprattutto, mentre il naturalismo annegava l’uomo nella trama della natura, per il verismo il centro dell’interesse era e doveva essere sempre l’uomo. E mentre Zola voleva che lo scrittore presentasse i “documenti umani” con la freddezza con cui un giudice raccoglie gli atti di un processo, il Capuana asseriva che il “documento” non aveva valore, ai fini dell’arte, finché non fosse animato dall’immaginazione e tradotto in “forma vivente”. […] Col tempo il Capuana accentuò la coscienza dell’assoluta autonomia dell’artista e della sua indipendenza da ogni presupposto ideologico; lo scrittore aveva il compito di rappresentare la realtà vivente dei personaggi senza mai fare di essi strumento di una “tesi” e senza mai violarne la interna struttura. Lo scrittore doveva dimenticare se stesso, immedesimarsi con il suo personaggio, vivere la sua vita, lasciarlo “responsabile di tutto quel che sente e pensa”»[4].
A nostro avviso, anche le denominazioni diverse delle due correnti confermano quanto è stato detto sopra: «naturalismo» è una parola che rimanda alla realtà obiettiva, esterna a noi, della natura, che viene indagata, fotografata in se stessa. Invece, la denominazione «verismo», proveniente dal termine «verità», implica una partecipazione personale del soggetto, che assimila concettualmente il mondo esterno della natura e da essa ricava gli «universali», che fondamentalmente sono nella realtà esterna e formalmente sono nel nostro spirito. Da qui la celebre definizione di verità come adaequatio rei et intellectus. Ora, nei romanzi verghiani la partecipazione del soggetto alla realtà è viva, ampia e produce un appassionante intreccio tra oggetto e soggetto.
Il naturalismo e il verismo, se ritrovano le loro origini immediate nel positivismo, nella questione sociale sollevata da Marx ed Engels con il Manifesto del 1848 e nel romanzo storico, che aveva difeso il linguaggio popolare – purché corretto – e la letteratura popolare, affondano le loro radici anche nel lontano realismo del Satyricon di Petronio Arbitro[5]; nella letteratura realistica di Boccaccio (cfr i personaggi del Decamerone Andreuccio da Perugia, Masetto da Lamporecchio) e di Machiavelli (Belfagor, La Mandragola, Il Principe); e nel realismo politico-autobiografico di Guicciardini (I Ricordi).
Il verismo verghiano
Consideriamo ora alcune caratteristiche del verismo verghiano. Il narratore catanese mutua da Zola la tecnica del romanzo ciclico: si pensi ai Rougon-Macquart, una saga familiare, composta di parecchi romanzi, di cui i più noti sono L’ assomoir (L’ammazzatoio, 1887) e Nanà (1880).
Verga crea il «ciclo dei vinti», ma con una notevole differenza rispetto a Zola: mentre quest’ultimo incentra la sua opera nella storia di una famiglia, il fulcro unitario del ciclo verghiano è costituito dalla presentazione dei singoli «vinti della storia», come padron ’Ntoni, ’Ntoni, Mastro don Gesualdo ecc. Manca nello scrittore siciliano un rapporto di cordialità con il popolo: egli non si fa portavoce del popolo, dei suoi mali, e tanto meno delle sue esigenze di redenzione o di miglioramento sociale; ’Ntoni e Mastro don Gesualdo tentano la via del progresso, ma sono sconfitti dalla storia.
Mentre Alessandro Manzoni aveva presentato le classi umili alla luce della Provvidenza e le aveva condotte a una soluzione positiva, Verga si ferma alla triste situazione dei «vinti», senza volerne interpretare e risolvere i problemi o migliorare la situazione[6]. Il popolo gli si offre solo come materia inerte che va studiata in modo spassionato e come documento sociale. La narrativa verghiana rimane un’esperienza solitaria, aristocratica: lo scrittore osserva dalla finestra il popolo e i suoi problemi sociali.
Tuttavia va sottolineata anche la sua sincera, umana empatia con le sofferenze e le sconfitte dei «vinti»: ricordiamo, ad esempio, l’addio di Mena a compar Alfio (c. VIII), l’addio di ’Ntoni al suo paese (c. XV) ne I Malavoglia, e l’umana, sofferta personalità di Diodata in Mastro don Gesualdo.
I documenti teorici sull’arte verghiana, stilati dallo stesso autore, sono soprattutto due: la «Lettera a Salvatore Farina», premessa alla novella L’ amante di Gramigna, e l’«Introduzione» a I Malavoglia.
Possiamo infine fare anche un confronto tra verismo e decadentismo. Il 1881 è l’anno in cui vengono pubblicati due capolavori: I Malavoglia di Verga e Malombra di Fogazzaro. Questi due romanzi sono manifestazioni di due correnti letterarie quasi antitetiche: l’una attestata sulla sponda dell’oggettività, dell’impassibilità; l’altra su quella della soggettività, del coinvolgimento personale. A noi sembra che la dimensione umano-soggettiva, la rivalutazione dell’Io e la partecipazione commossa del decadentismo abbiano mitigato la fredda, documentaristica «estetica del bisturi». Questa umanizzazione può spiegare l’atmosfera triste, coinvolgente del bozzetto Nedda e i due addii strazianti presenti ne I Malavoglia, nonché l’amore devoto, sofferto di Diodata verso Mastro don Gesualdo.
Un intreccio analogo tra diverse correnti di estetica si era verificato tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento con la coesistenza di protoromanticismo, neoclassicismo e romanticismo, da cui sono derivati la tragedia alfieriana, ispirata allo Sturm und Drang e all’Übermensch, la poesia neoclassica di Vincenzo Monti (Iliade) e di Ippolito Pindemonte (Odissea), l’arte neoclassica di Canova e lo splendido «carme» romantico di Ugo Foscolo I Sepolcri, permeato della cosiddetta «religione delle illusioni». Anzi, Foscolo sintetizza in sé i tre movimenti, donandoci tre capolavori letterari: Ultime lettere di Jacopo Ortis (protoromanticismo), I Sepolcri (romanticismo) e Le Grazie (neoclassicismo).
Questa compresenza mitiga le asprezze tedesche del protoromanticismo. Così, accanto al drammatico, disperato Saul, Alfieri ci presenta la tragedia Mirra, la cui protagonista è una giovane morbosamente innamorata del padre, Ciniro, re di Cipro, ma anche desiderosa di non soccombere alla tentazione e piena di pietas filialis verso il genitore.
Parini intreccia, ne Il Giorno e nelle Odi, cultura classica, da una parte, e istanze educative e problematiche sociali proprie del romanticismo, dall’altra; egli ha a cuore la riabilitazione redentiva del «giovin signore».
Foscolo fonde in sé e nella sua opera il romanticismo delle «illusioni», la sofferta aspirazione all’immortalità, le delusioni dell’esule e l’olimpica, contemplativa serenità de Le Grazie, dove vibrano bellezza e redenzione estetica.
Canova con i suoi capolavori scultorei (Le tre Grazie, Amore e Psiche, Clemente XIV ecc.) rinnova il miracolo dell’arte berniniana, imprimendo al marmo purezza eterea, levigatezza luminosa e calda, pacata umanità.
Questa compresenza equilibrata di valori differenti è una caratteristica della letteratura italiana, che raggiunge il culmine nella Divina Commedia, sinfonia perfetta, saggiamente contrappuntistica tra i vari stili letterari, e nei Promessi Sposi, fusione equilibrata tra i migliori elementi dell’Illuminismo e del Romanticismo e la luminosa, rasserenante visione cristiana della vita.
Concezione del dolore
La sofferenza è qualcosa che si subisce e per cui si piange da soli. È questa una concezione egoistica che hanno i paesani e che Verga cerca di comprendere, forse anche di giustificare. Gli altri fanno eco al tuo dolore e al tuo pianto, egli dice, per consuetudine. Ecco perché, insieme al dolore, nelle sue opere compaiono anche tanti pettegolezzi: caratteristico è il c. IV del romanzo I Malavoglia, che narra le visite di condoglianze per la morte di Bastianazzo[7]. Invece di porre il dolore al centro della scena, Verga lo fa apparire quasi di scorcio attraverso tante meschinità, che accrescono la sofferenza.
Il dolore personale non può trovare un vero e proprio conforto da parte degli altri; anzi, di solito esso è l’inizio della rovina di una casa o di una persona[8]. Per Verga, il dolore è sostanzialmente un male, ma lo si accetta e lo si subisce, perché si vede in esso una purificazione dai mali compiuti.
Un’altra peculiarità dello scrittore siciliano è l’intreccio frequente tra il dolore e la dimensione economica. Questo emerge nei ragionamenti di padron ’Ntoni e fa capolino nell’addio di Mena a compar Alfio: Mena è triste, perché deve lasciare compar Alfio, che ama profondamente; è costretta a farlo, perché la famiglia dei Malavoglia è caduta nella miseria, è oberata di debiti. Quindi, perfino nell’amore tra Mena e compar Alfio, il più idilliaco del romanzo, serpeggia la dimensione economica. Così Mena ama Alfio, ma padron ’Ntoni vuole che sposi uno della famiglia Cipolla, perché i Cipolla sono ricchi e possono aiutare a pagare i debiti dei Malavoglia. Per padron ’Ntoni, il valore supremo è la «religione della casa, della tradizione», a cui tutto deve essere sacrificato. A questa religione si ribella ’Ntoni, che per questo viene respinto dall’ambiente in cui vive e deve emigrare[9].
Non rientra in questa prospettiva il dolore della Longa per la morte di suo marito Bastianazzo (cc. III e IV) e per la perdita di suo figlio Luca, morto nella battaglia navale di Lissa, durante la terza guerra di indipendenza (c. IX). L’unico sollievo al suo dolore è costituito dalle sue visite alla Madonna Addolorata nella chiesa di Aci Trezza, e dalla sua stessa identificazione con l’Addolorata.
Concezione della vita
Per Verga, l’esistenza umana è dominata da un destino che conduce fatalmente le persone dove vuole. L’opera dell’uomo è svalorizzata, e l’uomo è costretto a subire tutto, senza una speranza di riscatto o di ricompensa, terrena o ultraterrena. Lo scrittore non ammette una Provvidenza che governa il mondo e a cui tutti possono guardare. Le azioni buone compiute dai personaggi verghiani non sono il frutto di una religione o di un culto verso l’Essere supremo, ma sono dettate unicamente da quella dirittura morale che è presente in loro in forza di una tradizione. Manca nello scrittore siciliano un’apertura al soprannaturale, che allarga le nostre prospettive; per lui, niente esiste all’infuori di ciò che si vede.
Dinanzi al nostro sguardo sfilano sempre occhi tristi, stanchi, tormentati dal dolore, privi di sorriso; gente povera, bimbi laceri, vestiti di solito con gli abiti tradizionali, che si trasmettono di padre in figlio. È difficile trovare la descrizione di una bellezza fisica; e quando si presenta, essa è oscurata dalla tristezza, dal dolore o da una condotta ambigua: si pensi a Lia, nipote di padron ’Ntoni, figlia della Longa; oppure a Bianca Trao e a sua figlia Isabella, poi legittimata da Mastro don Gesualdo.
Anche molte descrizioni della natura non si possono gustare, perché soffocate dalla preoccupante tristezza di tanti problemi irrisolti: pensiamo, ad esempio, alla triste alba descritta nell’ultimo capitolo de I Malavoglia.
I personaggi verghiani sono un esercito di «vinti». I romanzi Eva e Il marito di Elena sono il preludio alla concezione della vita presente nei due più grandi romanzi di Verga. Eva, Cesare, Elena preannunciano padron ’Ntoni, ’Ntoni e Mastro don Gesualdo. Pertanto la vita è una realtà monotona, senza sussulti di creatività, dominata da un fato duro e irrazionale. Prevale un mondo grigio, privo di tenebre e di luce, di satana e di Dio: l’esistenza umana è racchiusa in una macina e triturata dalle affannose necessità quotidiane, all’interno delle quali, tuttavia, risaltano gli affetti familiari[10].
Concezione sociale di Verga
Le opere di Verga nascono in vista di una generica riabilitazione di una classe sociale spesso disprezzata. In ciò lo scrittore siciliano si contrappone ad alcuni autori precedenti, che ponevano come protagonisti della loro opera personaggi illustri.
Nella Introduzione ai Promessi Sposi Manzoni aveva già criticato questi ultimi, affermando che anche le vicende di «genti meccaniche» costituiscono la «Storia» e possono divenire soggetto di narrazione letteraria; perciò aveva scelto come protagonisti del suo romanzo due umili popolani. C’è però una profonda differenza tra Manzoni e Verga: il primo riabilita il popolo alla luce del Vangelo, mentre il secondo vuole valorizzare gli umili mediante le energie buone e cattive che si trovano in essi.
Ma lo scrittore siciliano non sempre riesce nel suo intento. I suoi romanzi presentano personaggi incapaci di superare passioni e comportamenti immorali: si pensi alla figura degradante di Mazzarò nella novella La Roba; a Mastro don Gesualdo, che supera per il degrado Mazzarò; a Rocco Spatu, ignobile ubriacone; ad Agostino Piedipapera, sensale e astuto favoreggiatore del contrabbando. Verso questi sventurati lo scrittore nutre un sentimento sostanzialmente di comprensione; perciò è portato a giustificare il bene e il male, con la convinzione che il male morale di tali personaggi sia purificato dalla loro dura sofferenza, che è il loro pane quotidiano.
Qui emerge un’altra differenza tra Manzoni e Verga. Mentre il primo, quando è necessario, condanna il male anche nei personaggi a lui cari – pensiamo, ad esempio, alla disapprovazione della condotta di Renzo nel tumulto di Milano o alla sofferta condanna della «sventurata» monaca di Monza –, il secondo presenta i suoi personaggi così come sono e li lascia nella loro condizione, senza alcuna prospettiva di redenzione sociale e spirituale.
Verga inoltre mostra un atteggiamento di compassione anche verso i vincitori, i favoriti dalla sorte, perché li vede già come i «vinti» di domani. Per lui oppressi e trionfatori sono esseri destinati al dolore, dominati dalla forza invisibile del «fato», incapaci di opporsi ai più forti.
Il contrasto generazionale
Lo scontro tra padron ’Ntoni e ’Ntoni occupa gran parte del romanzo: diviene acuto dopo il fallito fidanzamento di ’Ntoni con Barbara, figlia di Venera Zuppida (c. IX), e si sviluppa, in un climax di fuoco, negli ultimi capitoli (XI-XV), sino alla drammatica acme dell’addio di ’Ntoni al paese.
Siamo di fronte a una tragedia greca, ma senza catarsi. Il racconto si svolge intorno a due poli: il nonno e il giovane ’Ntoni; il protagonista e l’antagonista; l’uno custode tenace dell’onestà antica – perché «il motto dell’antico mai tradì» –, della cultura paesana espressa nei proverbi, della saggia rassegnazione, l’altro portatore della scontentezza inquieta, che lo spingerà al vagabondaggio e alla vergogna del carcere.
’Ntoni considera il modus vivendi del nonno passività, sottomissione al triste destino di miseria e di sofferenze, al quale egli stesso vuole sfuggire. Ma purtroppo, con la sua ribellione, diventa il traditore della «religione domestica» e il distruttore totale, ad ogni livello, dei Malavoglia.
Quando prende coscienza della sua situazione di peccato, ’Ntoni diventa esule disperato e lascia la sua famiglia e la sua città. Si rinnova in lui la tragedia di Edipo, ma con una differenza: quest’ultimo commette il male senza saperlo, vittima innocente del fato; ’Ntoni, invece, si ribella, commette il male consapevolmente, diventando la vergogna dell’onesta famiglia dei Malavoglia.
Simbolo del degrado di ’Ntoni è l’incontro, prima di lasciare Aci Trezza, con Rocco Spatu, figura scialba del paese: «Ora – egli dice – è tempo d’andarmene, perché fra poco comincerà a passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar la sua giornata è stato Rocco Spatu» (c. XV). È la conclusione del romanzo. Il critico Luigi Russo commenta così questo episodio: «’Ntoni è costretto di nuovo a perdersi vagabondo fra gli uomini, ora che ha capito, ora che sa ogni cosa. Non c’è posto per il figliuol prodigo nella severa moralità del mondo verghiano. Una pietà altissima accompagna nell’ultimo distacco la figura del giovane: tanto più alta quanto più è dissimulata nell’apparente obiettività dello stile, in quelle immagini e dizioni estremamente scabre, essenziali, dalle quali si sprigiona una sorta di canto dolente. E tutte le cose e il paesaggio pare acconsentano a quella ferma esecuzione di pena»[11].
Antiprovvidenza e concezione del progresso in Giovanni Verga
«Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron ’Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio». Questo è l’incipit del romanzo. E il critico Piero Nardi commenta: «Il nomignolo ’Ntoni ha nel sentimento del Verga una sua ironia e una sua tristezza […]; dei vari membri della famiglia alcuni sono caratterizzati dalla buona volontà più ostinata e uno è tipicamente svogliato, anzi ribelle, come ’Ntoni. Ambedue i tipi sono destinati al fallimento […]. Questo nome della barca ha nell’intenzione e nel sentimento dell’autore una sua ironia e una sua tristezza. La barca, nel romanzo, si rivelerà come la negazione della “Provvidenza” per i poveri Malavoglia»[12].
Fin dalle prime battute il romanzo è immerso in una tragedia senza speranza, sotto il peso del fatalismo e nella negazione amara della Provvidenza. Sul dolore dei Malavoglia non si stende quasi mai il sorriso di Dio Padre, come nei Promessi Sposi era brillato sulla sofferenza di Renzo, Lucia e Agnese. Anzi, il termine «Provvidenza» acquista il significato blasfemo di «malaugurio»: così avviene nel c. I, con la perdita dei lupini; e nel c. X, con la barca sbattuta e colpita dalla tempesta marina; e infine, nel c. XV la Mena, nel colloquio con compar Alfio, ricorda che la barca Provvidenza era stata alienata per sopperire alle necessità familiari dei Malavoglia. Così il termine «Provvidenza» esprime solo una sintesi di disgrazie[13].
Forse l’unico personaggio su cui brilla per un momento il raggio della Provvidenza è la Longa, quando va a sfogare, davanti alla Madonna Addolorata, il suo dolore per la morte del figlio Luca (c. IX).
Accanto alla Longa, come personaggio che nutre fiducia nella vita, si pone Alessi, il quale ricostruisce la casa del nespolo e invita ’Ntoni a rimanervi (c. XV). Ma purtroppo ’Ntoni si sente costretto a rifiutare tale proposta, conformemente al suo destino di «vinto».
Volendo approfondire questa «antiprovvidenza» verghiana, possiamo fare un confronto tra l’addio di ’Ntoni al paese (c. XV de I Malavoglia) e l’addio di Lucia nel c. VIII dei Promessi Sposi.
Nell’addio manzoniano dominano, nei vari personaggi, fiducia in Dio Padre e speranza verso un futuro in cui misericordia e giustizia divine trionferanno; si tratta inoltre di un addio temporaneo. Nell’addio verghiano, invece, emerge la disperazione del vinto, che deve lasciare definitivamente il paese, perché ha violato la santità della casa e della tradizione e ha condotto alla morte padron ’Ntoni, simbolo della tradizione stessa.
Accanto a Lucia ci sono due persone di alto profilo umano e religioso: Agnese e Renzo. Invece, ’Ntoni, dopo una notte tenebrosa e il drammatico soliloquio sul proprio fallimento, alle prime luci dell’alba s’imbatte in Rocco Spatu, una delle figure più oscure del romanzo, insieme a zio Crocifisso e padron Cipolla.
L’addio di ’Ntoni è immerso nelle tenebre della sera e della notte: alle prime luci dell’alba egli lascia il paese e va ramingo per il mondo. L’addio notturno di Lucia, invece, è fasciato dalla luce argentea della luna, che imprime pace ed elevazione estetico-religiosa a tutta la scena.
Asfissiante, terrestre, orizzontale è il paesaggio in cui è calato l’addio di ’Ntoni; verticale, ascensionale, pacatamente lirico è il paesaggio in cui s’inquadra l’addio di Lucia: «… Addio monti, sorgenti dall’acque ed elevati al cielo… addio torrenti… addio casa natìa, addio Chiesa dove l’animo tornò tante volte sereno…».
Lo sguardo di Lucia si ferma sulle acque; poi, attraverso il pendìo, sale verso la casa e infine verso la chiesa. Questo movimento verticale prepara l’ascensione verso il Dio provvidente, che dall’alto guida la storia.
Infine possiamo notare che dove si radica maggiormente l’antiprovvidenza di Verga è nella sua concezione del progresso[14].
I protagonisti verghiani tendono tutti a progredire: i Malavoglia, per liberarsi dai bisogni materiali; Mastro don Gesualdo vuole progredire economicamente e socialmente con l’avidità delle ricchezze; la duchessa di Leyra, nel romanzo rimasto incompiuto, persegue la vanità aristocratica; l’onorevole Scipioni tende all’ambizione politica. Ma alla fine tutti questi personaggi vengono rovinati dalle loro ambizioni e vanità. Il progresso immette uno spiraglio di luce nel tetro pessimismo di Verga, ma alla fine i protagonisti diventano dei «vinti». E anche i «vincitori» di oggi saranno i «vinti» di domani.
Per Verga, un certo progresso è immanente alla piccola e grande «Storia», ma passa sempre per la via del peccato, delle passioni, della deviazione dai valori, come la casa, la tradizione o il rapporto verso gli altri. Pertanto, i singoli protagonisti del progresso scompaiono, fagocitati dalla disperazione e dal fallimento, e finiscono nella categoria dei «vinti».
E se anche il progresso attuato rimarrà e sarà ereditato da altri, come nel caso di Alessi, che ricostruisce la casa del nespolo, e della figlia di Mastro don Gesualdo, che eredita le ricchezze accumulate dal padre, nessun personaggio riesce poi a liberarsi dalla fatalità del peccato.
La dimensione negativa e fatalistica emerge anche nella pagina idilliaca e amara dedicata al triste addio di compar Alfio ai Malavoglia, e soprattutto a Mena (c. VIII). Egli parte per trovare lavoro, e Mena, che lo ama profondamente, rimane con il cuore straziato. La tristezza che caratterizza il distacco tra compar Alfio e Mena viene fatta risaltare dalle parole conclusive dell’addio: «[Dice compar Alfio:] “Ma questi oramai sono discorsi inutili, e bisogna fare quel che si può. Anche il mio asino va dove lo faccio andare”. “Ora addio, conchiuse Mena; anch’io ci ho come una spina qui dentro… ed ora che vedrò sempre quella finestra chiusa, mi parrà di averci chiuso anche il cuore, e d’averci chiuso sopra quella finestra, pesante come una porta di palmento. Ma così vuol Dio. Ora vi saluto e me ne vado”. La poveretta piangeva cheta cheta, colla mano sugli occhi, e se ne andò insieme alla Nunziata a piangere sotto il nespolo, al chiaro di luna»[15].
Copyright © La Civiltà Cattolica 2018
Riproduzione riservata
***
ANTHROPOLOGY IN GIOVANNI VERGA’ NOVELS
After delineating the characteristics and the differences between Italian Verism and French Naturalism – naturalism submerged man in the very fabric of nature, for realism the center of interest was and always had to be man -, the article shows how the concept of pain, of life and of society which characterized Verga’s novels and some of his novellas was portrayed. In addition, the themes of generational conflict, of anti-providence and progress, both individual and community, in the Verghian work are discussed.
***
[1]. I naturalisti considerano loro maestro Gustave Flaubert, autore dei famosi romanzi Madame Bovary, Salammbô e dell’opera, fondamentalmente autobiografica, L’ educazione sentimentale.
[2]. Per un’esposizione più ampia del pensiero estetico di Taine e la relativa critica, cfr Dizionario critico della letteratura francese, vol. 11, Torino, Utet, 1972, 1168-1170.
[3]. P. Cossa, Nerone, Torino, Casanova, 1882, 17.
[4]. M. Santoro, Letteratura italiana del Novecento, Firenze, Le Monnier, 1980, 65 s.
[5]. Nel suo studio su Fortunata, moglie del celebre Trimalcione, Auerbach afferma che Petronio è il grande iniziatore della letteratura realistica occidentale: cfr E. Auerbach, Mimesis, Torino, Einaudi, 1981, 30-57.
[6]. Sul confronto tra Manzoni e Verga, cfr G. Barberi Squarotti, Le finzioni dietro il verismo, Palermo, Flaccovio, 1982. In quest’opera lo studioso vuole dimostrare che, mentre Manzoni esamina e giudica la realtà e si assume la responsabilità delle sue valutazioni, Verga, nascondendosi dietro l’imparzialità e l’oggettività, si limita a descrivere la società, senza cercare di cambiarla, di migliorarla.
[7]. Bastianazzo è il marito della Longa, morto nell’affondamento della barca, denominata ironicamente Provvidenza.
[8]. Si pensi all’affondamento della Provvidenza, che è all’origine di una catena di mali abbattutisi sui Malavoglia. L’intreccio fra dolore e pettegolezzi ritorna nel c. IX (morte di Luca) e nel c. XI (morte della Longa).
[9]. Cfr L. Russo, Giovanni Verga, Bari, Laterza, 1995, 131 s; 148-150.
[10]. La concezione verghiana della vita viene ben illustrata nel saggio di A. Momigliano, Dante, Verga, Manzoni, Messina – Firenze, D’Anna, 1965.
[11]. G. Verga, I Malavoglia, a cura di L. Russo, Napoli, Ricciardi, 1920.
[12]. Id., I Malavoglia, a cura di P. Nardi, Milano, Mondadori, 1968.
[13]. L’idea di denominare Provvidenza la barca dei Malavoglia è un’eco, sia pure inconscia, della tradizione greca di dare nomi beneauguranti alle navi, a causa dei grandi rischi insiti nella navigazione. Tali nomi erano «Salvezza», «Grazia», «Illuminazione», «Salvatrice», «Soccorso», «Gioia», oltre che «Provvidenza»: cfr H. Rahner, Miti greci nell’interpretazione cristiana, Bologna, il Mulino, 1971, 373.
[14]. Cfr G. Verga, Prefazione a I Malavoglia: «Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggiore precisione. […] Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti questi, la ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese».
[15]. G. Verga, «I Malavoglia», in Id., I grandi romanzi, Milano, Mondadori, 2001, 120.