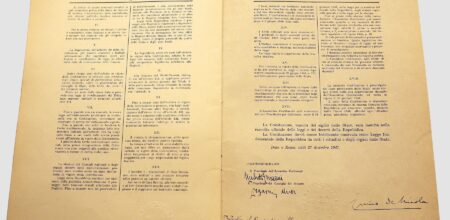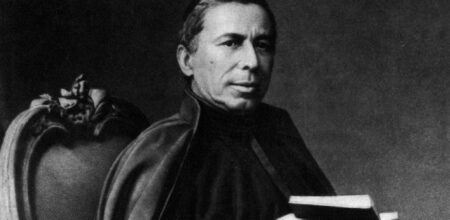Qual è il centro della teologia di Lutero? Il volume di Galzignato si propone di rispondere a questa domanda, studiando la genesi del concetto di «Evangelo» nel riformatore: appunto il cuore del suo pensiero e della sua vita. L’imponente lavoro è la tesi dottorale dell’A. in Teologia dogmatica, pubblicata ora integralmente per i 500 anni della Riforma, con la presentazione di Roberto Tommasi.
Il saggio si sviluppa in tre sezioni: la prima approfondisce, negli anni della formazione, le cause di una crisi che Lutero afferma di aver superato con la scoperta del vero significato della «giustizia di Dio»; la seconda si concentra sulle componenti che plasmano l’idea di «Evangelo» negli scritti giovanili: il commento ai Salmi, alla lettera ai Romani e alla lettera ai Galati; l’ultima parte invece ne scava le radici teologiche.
Il lavoro si qualifica come ricerca metodica e rigorosa, basata sulle opere di Lutero (citate in originale con versione a fronte) e raffrontata con l’abbondante letteratura, che gioca un ruolo considerevole nell’apparato delle note, in fitto dialogo con il testo.
L’A. premette che la teologia del riformatore è un’esperienza viva: nasce dalla vita, dalla preghiera e dal confronto continuo con le problematiche esistenziali. Lutero confida le sue angosce al padre spirituale, lo Staupitz, che lo indirizza all’apostolo Paolo, ad Agostino, ai mistici, in particolare a san Bernardo. Si accende così in lui una luce che lo porta a una nuova comprensione della iustitia Dei: non la giustizia che condanna, ma quella per cui Dio è giusto e rende giusti.
Lutero prende le distanze dalla teologia che pone l’accento sulle opere e sull’impegno spirituale: il Cacangelium (il «cattivo evangelo»: pp. 518 s). In tal modo si scioglie il dramma che lacera la coscienza: la consapevolezza di essere sempre peccatore e incapace di salvarsi si apre alla speranza di una salvezza donata per la sola fede nella grazia. L’itinerario culmina nella scoperta dell’«Evangelo», cioè del lieto annuncio della «soavissima misericordia di Dio Padre, Cristo donato a noi» (pp. 8 e 707).
I primi segni della scoperta si hanno nel commento ai Salmi. Poi, all’inizio del corso su Paolo, la giustizia di Dio sembra essere (videtur) quella che proviene dalla fede: ci si trova davanti a un pensiero in formazione (p. 352). Lutero precisa: i destinatari della promessa di Dio non sono i facientes, ma i credentes (pp. 380; 491). E solo per fede l’uomo può conoscere di essere insieme peccatore e giustificato (simul peccator et iustus). Segue la definizione dell’«uomo vecchio»: non è solo colui che compie le opere della carne, ma colui che agisce con giustizia e si esercita nei beni spirituali con la propria sapienza. Infine, nel commento a Rm 8 e 9, si notano la gioia e l’entusiasmo per una scoperta che viene dalla Parola di Dio: la giustizia è donata nell’Evangelo ex fide totaliter, è gratuita, non lascia nulla nelle mani dell’uomo e libera l’Evangelo da ogni norma legale. Da qui la preghiera: «Tu, Signore Gesù, sei la mia giustizia e io sono il tuo peccato» (p. 479).
Un’ulteriore conferma di questa scoperta si ha nei sermoni del 1515-16. Perciò l’A. propone di situare la scoperta dell’«Evangelo» verso la fine del 1516, quando Lutero confessa che gli si sono aperte le porte del Paradiso.
Nella prefazione, l’A. spiega che il suo lavoro è anche una risposta all’invito del Vaticano II a creare un dialogo tra i credenti in Cristo. Indubbio è il taglio ecumenico dello studio.
MARIO GALZIGNATO
La genesi storico-teologica dell’«Evangelo» di Martin Lutero
Padova, Messaggero – Facoltà Teologica del Triveneto, 2017, 774, € 38,00.