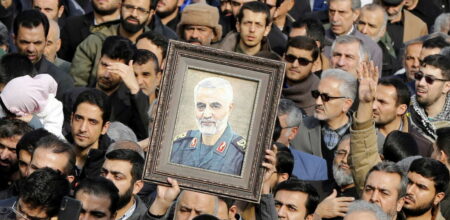|
|
Dopo aver apprezzato il lucido e straziante Vita e morte di un ingegnere (2012), il monumentale La scuola cattolica (2016), romanzo nel quale Edoardo Albinati sembra aver fatto i conti in maniera definitiva con la propria identità, e il sensuale, doloroso racconto dal titolo Un adulterio (2017), avevamo trovato assai stimolanti anche le pagine di Cronistoria di un pensiero infame (2018), il pamphlet in cui egli ha polemizzato, utilizzando toni aspri e sarcastici, con il ministro dell’Interno dell’epoca, affrontando nel contempo alcuni temi di grande rilevanza: dall’uso e abuso della verità al ruolo dei cosiddetti «intellettuali». Ora l’autore torna alla narrativa con questo nuovo testo, che si caratterizza anzitutto per la coralità, la giovane età di quasi tutti i personaggi e la loro smania di essere se stessi, di capire, di desiderare senza tener conto di limiti di sorta: figure che, preda in gran parte di una furiosa, fervida passionalità, ci fanno rivivere un periodo della nostra storia recente e, grazie alla forza delle loro parole, restano impresse nella nostra memoria.
Occorre poi notare che Albinati colloca le tante vicende narrate all’inizio degli anni Ottanta: un periodo che il romanziere racconta senza nostalgie né rimpianti, ma con un marcato distacco e guardando nel contempo ai comportamenti individuali con meticolosa attenzione. Intorno all’amicizia tra due ventenni – Nico e Nanni – prendono vita le storie di un gran numero di personaggi: bambine riottose, studenti svogliati, nonne autoritarie, babysitter austere, supplenti dalle trecce bionde, maghi astiosi, studentesse prosperose, intellettuali infidi, diplomatici altezzosamente glaciali, terroristi irresoluti.
Dobbiamo osservare come Albinati si dimostri capace di delineare il carattere di questi personaggi attraverso le loro parole: l’opera, sotto questo aspetto, è un vero e proprio «romanzo di conversazione», nell’ambito del quale assume di conseguenza enorme importanza il discorso diretto, che qui – dalla chiacchierata al litigio, dal dialogo al soliloquio – viene utilizzato dall’auore con grande maestria. Le parole con cui i vari personaggi si esprimono danno l’impressione di essere ben calibrate in rapporto alla situazione raccontata, in grado di conferire energia alla lingua e all’esperienza quotidiana, senza cadere mai in eccessi o sciatterie.
Abbiamo già accennato agli anni nei quali vivono e si muovono i tanti protagonisti del romanzo. L’autore descrive così la mentalità del periodo: «Era un’epoca radicale e fanatica durante la quale nessuno si accontentava di quello che era, nessuno era soddisfatto del modo in cui lo facevano. Bisognava afferrare la pienezza» (p. 81). E, dopo appena qualche riga, aggiunge: «I gradi, le tappe, le misure erano considerate con giusto disprezzo. Nel termine “rivoluzione” nessuno scorgeva un significato eccessivo, un obiettivo esagerato: si era coscienti di esigere una cosa ovvia».
A proposito degli aspetti stilistici, va sottolineata la qualità della prosa di Albinati, che appare sempre molto controllata, contrassegnata dalla notevole incisività e scorrevolezza, dall’apprezzabile varietà dei registri espressivi e dalla pregevole ricchezza del lessico. Nel complesso, una scrittura che, forse, non è mai stata così felice.
E sembra interessante sottolineare come, nell’economia del romanzo, un ruolo di indubbio rilievo venga svolto dalla cosiddetta «città meridionale», alla quale sono dedicati il bellissimo preludio e qualche altro paragrafo sapientemente inserito nell’ambito del testo. Si tratta di una presenza costante che ne fa, se non la protagonista, uno dei principali personaggi della narrazione. Roma acquisisce così un ruolo centrale, e riesce a esercitare un intenso fascino, come raramente le è capitato nelle pagine di un autore dei nostri giorni. Una peculiarità, questa, che contribuisce a fare di Cuori fanatici un’opera pienamente riuscita e meritevole di grande attenzione.
EDOARDO ALBINATI
Cuori fanatici. Amore e ragione
Milano, Rizzoli, 2019, 396, € 20,00.