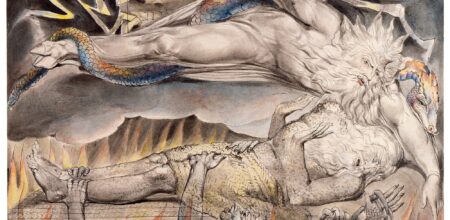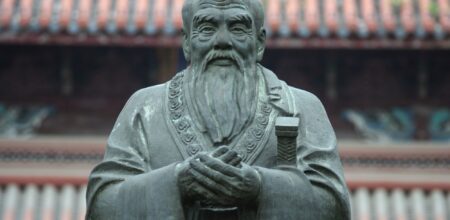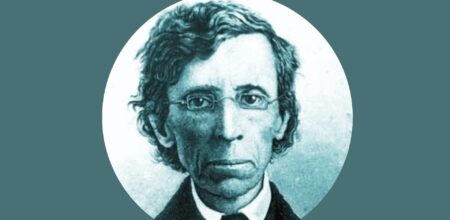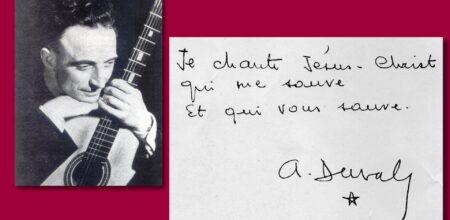Cormac McCarthy è deceduto «per cause naturali»[1] lo scorso 13 giugno, presso la sua abitazione a Santa Fe (New Mexico), alla soglia dei 90 anni. L’ultima fatica letteraria su cui aveva lungamente lavorato – il dittico formato dai romanzi Il passeggero e Stella Maris (2022) – assume così il duplice valore di epitome letteraria e di testamento spirituale. L’opera, di grande complessità strutturale e filosofica, ha disorientato i lettori, che l’hanno avvicinata sull’eco mondiale suscitata dalla morte dell’autore. Non è, in effetti, il miglior punto di partenza, e forse solo quanti hanno seguito McCarthy fin qui possono apprezzarne lo spessore di autobiografia intellettuale[2].
Più volte proposto dai media per il Nobel per la Letteratura, McCarthy si è invece distinto per riservatezza ed estrema parsimonia nel concedere interviste, accrescendo attorno a sé una certa aura di leggenda. Il successo lo aveva raggiunto solo alla quinta opera, grazie all’appassionata divulgazione di critici come Harold Bloom[3], ed era stato amplificato dal Premio Pulitzer per La strada, quasi un Vangelo del terzo millennio[4]. Il plauso congiunto di critica e pubblico è giustificato dalla capacità di riprendere e rivitalizzare in piena postmodernità generi letterari ben definiti, persino pop – il western, l’avventura sul fiume, l’on the road, il picaresco, il noir, la distopia –, innervandovi una dirompente tensione metafisica che dilata fino al loro estremo limite le maglie della forma-romanzo, senza tuttavia rinunciare al gusto per la narrazione.
Questo spiega in parte il peculiare rapporto di McCarthy con il cinema. Sebbene dai suoi romanzi siano stati tratti numerosi film, e lui stesso abbia firmato una sceneggiatura originale per una pellicola[5], raramente le trasposizioni sul grande schermo hanno convinto. Forse perché nelle sue opere, nonostante il ritmo epico e l’elevata carica di azione, il vero motore è ben altro, e irrappresentabile: le grandi domande metafisiche. Che cos’è un uomo? Perché c’è il male? Qual è il nostro posto sulla terra? C’è un Dio? Sono gli interrogativi che ritroviamo negli autori dichiaratamente più cari a McCarthy – Hermann Melville, Fëdor Dostoevskij, William Faulkner, Flannery O’Connor[6] –, ed è sorprendente che, dopo la cosiddetta «fine delle grandi narrazioni», qualcuno sia tornato a porle al centro con tanta ostinata, implacabile insistenza. Il lettore di McCarthy non è mai rassicurato da risposte preconfezionate che, in ogni caso, saranno conquistate a caro prezzo. In questo contributo vorremmo fornire a chi si
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento