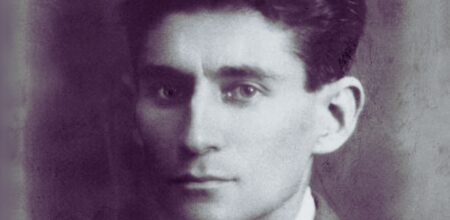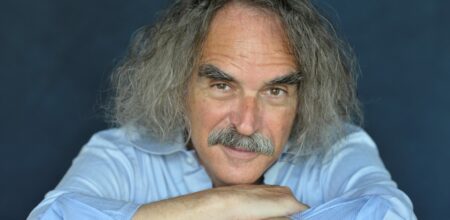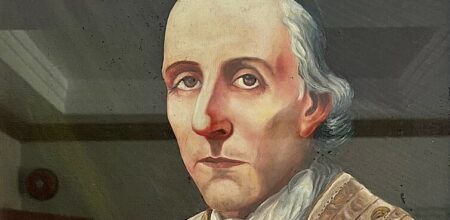|
|
La ripresa di un tema sempre presente
È opinione diffusa che la psicologia e la psicoanalisi, per non parlare della psichiatria, si occupino soprattutto del versante «malato» del comportamento umano: ne interpretano i sintomi, le possibili conseguenze, in vista di una modalità efficace di cura. Un tale approccio è indubbiamente importante e aiuta la persona a vivere; tuttavia, qualora venga assolutizzato, può portare a conseguenze negative, come la tendenza a considerare la realtà con una tonalità tendente allo scuro, o al nero profondo ecc. È significativo che alcune tematiche decisive dell’esistenza umana, come la speranza e la gratitudine, capaci di fornire un aiuto essenziale per affrontare situazioni critiche, trovino di fatto poco spazio nella ricerca psicologica proprio a motivo della loro componente «sana»[1].
L’immagine sottostante, di mondo e di uomo, che viene di conseguenza comunicata non è delle più confortanti e desta non poche perplessità qualora se ne traggano le logiche conseguenze. Aprendo un convegno sul tema dell’altruismo, l’allora presidente dell’American Psychological Association, Donald T. Campbell, riconosceva che le lenti troppo fosche e ristrette con cui lo psicologo tende a considerare l’uomo non solo rendevano difficile riconoscervi una possibile «bontà», ma finivano per osteggiare ogni tentativo in senso contrario: «La psicologia e la psichiatria […] non solo descrivono l’uomo come egoisticamente motivato, ma implicitamente o esplicitamente insegnano che egli deve essere così»[2]. A lui fa eco un celebre psichiatra statunitense, di origine lituano-ebraica, Irvin Yalom, il quale, nel libro Momma and the meaning of life, una sorta di autobiografia psicoanalitica, nota la difficoltà ad affrontare questioni di tipo globale, sapienziale, anche se imprescindibili per il lavoro terapeutico: «I testi di psichiatria raramente discutono ciò che caratterizza una personalità “buona”, tranne il fatto di definirla come una difesa nei confronti di oscuri impulsi»[3]. Da qui la povertà di ricerche e studi su temi «scomodi», come la gratuità, l’empatia o l’altruismo ecc.
Non mancano comunque reazioni in senso contrario. Lo psicologo Abraham Maslow ha contestato la tendenza a interessarsi soltanto a persone problematiche o con deficienze nello sviluppo, riducendo la psicologia a mera analisi e cura delle patologie. A questa lettura «malata» della persona egli obietta che, quando si studiano soggetti contenti di sé e della propria vita, si scoprono elementi nuovi e importanti per la psicodinamica della persona, in grado di ridare significato alla stessa ricerca psicologica: «Da quando Maslow interrogava delle persone che realizzavano la propria esistenza con successo, privilegiando l’esame di certi momenti di pienezza (peak-experiences, “esperienze culminanti”) che avevano ispirato la loro vita o l’avevano di tanto in tanto contrassegnata, egli scoprì che le loro motivazioni e i loro modi di percezione dell’universo, delle cose e delle persone, avevano delle caratteristiche fino ad allora sconosciute nella psicologia generale»[4].
Le osservazioni di Maslow sono state riprese in particolare dalla cosiddetta «psicologia positiva», interessata a rilevare cosa renda la vita appagante, felice, piuttosto che limitarsi a indagarne gli aspetti malati. Nel 2004 è stato pubblicato uno studio a più voci sul tema, curato da Christopher Peterson e Martin Seligman[5]. Essi, esaminando la letteratura in proposito, compresa quella a carattere filosofico e religioso, delineano alcuni punti di forza capaci di rendere più bella l’esistenza e più stabile la persona, rafforzandone il carattere. Un altro esponente di questa corrente, Alan Waterman, rimanda all’importanza dell’eudaimonia aristotelica, cioè della pratica dell’attività più nobile dell’uomo, come la contemplazione, per condurre una vita piena[6].
Le caratteristiche rilevanti della psicologia positiva
In linea con la riflessione filosofica classica, anche Peterson e Seligman mettono ai primi posti le virtù esplorate da Aristotele e Tommaso: la saggezza, il coraggio, l’amore, la giustizia, la temperanza, la trascendenza[7]. Si tratta di qualità coltivate dalla persona nell’arco del tempo, grazie all’educazione, a relazioni affettivamente rilevanti, alla vita in comunità, a uno sviluppo sano e armonico, capace cioè di curare i vari ambiti della personalità.
Tra le caratteristiche principali rilevate dalle ricerche, la felicità è strettamente legata all’amore, inteso non come piacere (eros), ma come donazione (agapē), come capacità di vivere relazioni affettive gratificanti, durature e stabili, favorite dalla presenza di comunità di riferimento rilevanti anche sotto l’aspetto pubblico, come la famiglia e le istituzioni culturali, sociali e religiose. Se un bambino cresce all’interno di un matrimonio affettivamente stabile, mostra un indubbio vantaggio a livello scolastico dal punto di vista cognitivo, di attenzione, apprendimento e interessi, insieme alla capacità di vivere con i compagni in modo rispettoso e non violento[8]. Interrogando gruppi e singole persone soddisfatti della propria vita, sono così emerse alcune caratteristiche costanti: le relazioni in famiglia, la professione, gli amici, la salute, la possibilità di esprimere i propri desideri profondi[9].
Un’altra ricerca degna di nota è stata condotta dallo psichiatra Robert Waldinger, dell’Università di Harvard. Egli ha portato a termine l’indagine più completa ed estesa sul tema della qualità della vita – 75 anni (dal 1938 al 2013) –, coinvolgendo intere generazioni nel corso dello sviluppo. Le persone del campionario, inizialmente 724, sono diventate in seguito 2.000, aggiungendosi a esse la generazione dei figli e dei nipoti[10]. Il gruppo risultava molto variegato, comprendendo situazioni estremamente diverse riguardo al ceto sociale, all’istruzione e alle esperienze di vita. C’era chi aveva sperimentato la Seconda guerra mondiale, la «guerra fredda», la prosperità economica, il consumismo, la contestazione giovanile, la rivoluzione informatica e digitale. C’erano i ricchi di Harvard e i poveri di Boston, privi dei beni più essenziali.
E nel frattempo erano invecchiati anche i loro curatori, che hanno passato il testimone ad altri colleghi: Robert Waldinger è stato il quarto (dopo George Vaillant, Xingjia Cui, Stephen Soldz) ad assumere il ruolo di direttore della ricerca, che viene puntualmente aggiornata ogni due anni. Il percorso di vita delle persone intervistate è altrettanto vario: tra loro si contano professionisti, dirigenti, politici di rilievo – tra i quali John F. Kennedy, divenuto presidente degli Stati Uniti –, ma anche impiegati, alcolizzati, drogati, malati psichiatrici. Alcuni erano passati dai livelli più bassi alla sommità dei vertici della nazione, e altri, al contrario, partiti in cima, erano precipitati in fondo. Per tutte queste ragioni si tratta di un campionario unico dell’umanità nei suoi possibili percorsi.
Il parametro decisivo: le relazioni
Le conclusioni della ricerca sono molteplici. Tre lezioni in particolare emergono come punti costanti di riferimento, che si ritroveranno anche in altri studi.
- La prima lezione è molto simile a quanto puntualizzato da Peterson e Seligman: ciò che contribuisce più di ogni altra cosa alla qualità della vita sono le relazioni affettivamente belle e gratificanti (legate a famiglia, amici, comunità di riferimento), mentre la solitudine è nociva, al punto da costituire una delle più frequenti cause di autodistruzione, fino alla morte. È un dato emerso anche dal report del Ministero della solitudine, istituito in Gran Bretagna. Le nuove opportunità digitali sembrano amplificare tale tendenza[11]. D’altra parte, le relazioni conflittuali sono più nocive della solitudine.
- La seconda lezione è che le relazioni affettivamente belle e gratificanti, oltre a rendere felici, mantengono in salute e fanno vivere più a lungo. I ricercatori, come possibile verifica della teoria, hanno ipotizzato, nel campione di riferimento, quali cinquantenni sarebbero stati ancora vivi e in salute trent’anni più tardi. E i cinquantenni che all’epoca soddisfacevano i criteri della felicità erano anche quelli che a 80 anni continuavano a essere vivi e contenti della loro condizione. Il parametro decisivo dei «sani» non era la costituzione fisica, le attività sportive, la quantità di zuccheri o di colesterolo nel sangue, ma la qualità delle relazioni. E quando parlano di «relazioni di qualità», i ricercatori non intendono assenza di conflitti, ma la fiducia nella loro stabilità: «Buone relazioni intime sembrano proteggerci dagli acciacchi della vecchiaia. Alcune coppie di ottuagenari possono bisticciare un giorno sì e un giorno no, ma, finché sentono di poter davvero contare sull’altro quando le cose si fanno difficili, quei litigi non scalfiscono per nulla i loro ricordi»[12].
Inoltre, la consapevolezza di essere contenti della propria vita sembra proteggere dal dolore molto più dell’assunzione di farmaci. In pratica, si invecchia come si è vissuti. La sofferenza più devastante non è legata alla malattia o all’infermità fisica, ma alla sensazione di non trovare uno scopo per la propria vita.
Henri Nouwen, frequentando la comunità de L’Arche, notava: «Nella mia comunità, ci sono molti uomini e donne gravemente handicappati, ma la più grande sorgente di sofferenza non è l’handicap in quanto tale, ma la sensazione di essere inutili, indegni, incompresi e non amati. È molto più facile accettare l’incapacità a parlare, camminare o nutrirsi da soli, che accettare l’incapacità ad avere un valore speciale per un’altra persona»[13].
Lo scrittore giapponese Murakami Haruki distingue opportunamente tra dolore e sofferenza: il dolore è subìto, ma può essere vissuto diversamente dal commento interiore del soggetto, dal suo mondo di valori e di motivazioni. Un medesimo accadimento doloroso comporta una sofferenza differente a seconda del soggetto che lo vive. Per questo Murakami osserva: «Il dolore non si può evitare, ma la sofferenza è opzionale. Supponiamo per esempio che uno pensi: “Non ce la faccio più, è troppo faticoso”. La fatica è una realtà inevitabile, mentre la possibilità di farcela o meno è a esclusiva discrezione di ogni individuo»[14]. - La terza lezione emersa da questa pluridecennale ricerca è che la felicità favorisce anche la vivacità intellettuale, il desiderio di aprirsi a nuove conoscenze ed esperienze, che è un aspetto essenziale per la qualità della vita.
L’équipe di Waldinger, una volta compiuta la ricerca, si è anche domandata perché queste verità, sebbene note da sempre, siano per lo più ignorate. E ha osservato la presenza di «distorsioni cognitive», di automatismi egoistici, la tendenza a ripiegarsi su sé stessi e a volere i frutti nell’immediato. Quando chiedevano alle persone a cosa associassero la felicità, la maggior parte di loro rispondeva: quando si ricevono soldi e li si spende per sé. Due presupposti entrambi errati, eppure estremamente radicati. Einstein notava che è più facile dividere l’atomo che vincere un pregiudizio. In realtà si è felici solo quando ci si propone di far felici altri.
Altre ricerche sul medesimo tema, condotte sempre negli Stati Uniti (la nazione nella quale questo argomento è stato più studiato), individuano parametri molto simili. Essi sono, in ordine di importanza: 1) la famiglia; 2) la stabilità economica; 3) un lavoro gratificante; 4) le relazioni amicali; 5) la salute. Altri parametri, pur rilevanti – come la libertà e i valori di riferimento generali –, risultano più difficili da inserire in una graduatoria, in quanto trasversali a tutte le situazioni[15].
L’amore coniugale viene considerato tuttora come uno dei valori più alti, specie se associato alla generatività e alla cura dei figli, anche se a prima vista ciò sembra incompatibile con il piacere e la soddisfazione immediata, proprie di una proposta legata all’autorealizzazione personale: «La ricerca sulla felicità ha provato che il benessere psicologico dei genitori cala sensibilmente soprattutto nei primi anni dopo la nascita di un figlio, il che portava a chiedersi se avere figli non finisse per rendere infelici. Ma molte ricerche mostrano che le notti insonni e la mancanza di tempo libero non mettono a repentaglio la pienezza di senso derivata dall’essere genitori, e ciò vale soprattutto per coloro che mettono il benessere dei figli al di sopra dei propri bisogni»[16].
Jonathan Freedman, in un’indagine condotta su un campione di 100.000 persone, rileva a sua volta come la felicità non sia affatto associata al successo o alla quantità di beni, ma alla qualità delle relazioni, in particolare nel matrimonio[17].
Le resistenze alla felicità
Le conclusioni degli studi sono molto vicine a quanto la storia del pensiero aveva mostrato sotto altre forme: aspetti in qualche modo già noti, ma nei confronti dei quali emerge sempre una curiosa resistenza.
I ricercatori si sono anche chiesti perché tali conclusioni, pur confermate a ogni indagine, siano per lo più disattese, vista la loro evidenza e costanza nel tempo. Il punto discriminante è il «costo» che tutto ciò richiede, come per ogni cosa importante (studio, professione, risultati sportivi, fedeltà agli impegni), in termini di fatica, applicazione, rinuncia, tempi lunghi. Quando ci si appassiona con gratuità a qualcosa si trae un profitto maggiore e soprattutto si fa esperienza della bellezza di «sentire e gustare interiormente», che, come ricorda Ignazio di Loyola, è ciò che davvero «sazia l’anima» (Esercizi spirituali, n. 2). Ciò richiede tuttavia di investire su qualcosa a fondo perduto, non immediatamente gratificante; da qui il dubbio se davvero «il gioco valga la candela». In realtà, quello che danneggia la qualità della vita sono proprio la fretta e la brama di possesso.
Podcast | SUD SUDAN. «UN CONFLITTO CHE NON È MAI FINITO»
Quattro milioni di sfollati, oltre 350mila morti, fame e povertà. Il Sud Sudan è il paese più giovane del mondo, con una storia già segnata dalle violenze. Oggi lo spettro della guerra torna a far paura, come racconta mons. Christian Carlassare, vescovo della diocesi di Bentiu. Ascolta il podcast
La spontaneità non è una buona consigliera per affrontare al meglio le tematiche della vita, ma richiede di essere confrontata, educata e spesso anche messa in discussione criticamente. Va anche precisato che quanto emerge dalla costellazione «felicità» risulta poco gradito a chi tira le fila delle odierne società industrializzate, delle grandi agenzie del capitale e anche delle associazioni malavitose. Tutte hanno in comune la ricerca sfrenata del profitto, da conseguire unicamente per sé stessi. Senza poterlo trovare. Al contrario, chi è contento della propria vita non ha bisogno di compensazioni molteplici.
La presenza di relazioni qualitativamente rilevanti è indispensabile, oltre che per la felicità individuale, anche per la salute della collettività, perché è legata a quella che il sociologo statunitense Robert Putnam chiama «il capitale sociale», la rete di relazioni e interessi alla base di una società e della sua salute. Il capitale sociale «consente innanzitutto ai cittadini di risolvere più facilmente i problemi collettivi»[18]. Per questo può essere considerato l’indice della salute di una comunità, perché fornisce anticorpi in grado di affrontare e superare eventi negativi e tragiche calamità. Questo è un aspetto fondamentale per la qualità della vita, che necessita di ritrovare il suo posto centrale, anzitutto in sede di riflessione.
Alcuni passi possibili
La relazione con la gente comune può aiutare a comprendere cosa rende bella la propria vita, spendendosi per gli altri. La ricerca su più generazioni condotta da George E. Vaillant, Xingjia Cui, Stephen Soldz e Robert Waldinger mostrava in maniera evidente come la felicità fosse strettamente legata alla cura delle relazioni: una cura gratuita, non in vista di un profitto. Le loro conclusioni sono di una semplicità sconcertante: «Può essere semplicemente dedicare più tempo alle persone invece che alla Tv, o vivacizzare una relazione spenta facendo qualcosa di nuovo insieme, lunghe passeggiate o uscite serali, o rimettersi in contatto con un familiare che non si sente da anni, perché le comuni faide familiari richiedono un grosso tributo alla persone che tengono il muso»[19]. La pienezza di vivere è legata al desiderio di mettere a disposizione i doni ricevuti aiutando altri.
Martin Seligman indica in particolare alcuni passi concreti per investire nelle relazioni:
- devolvere il 5% delle entrate lorde in beneficenza;
- un tempo stabilito da dedicare agli ultimi, per una attività di volontariato o di carattere caritativo/sociale, come ad esempio andare a trovare ammalati in ospedale;
- se qualcuno chiede dei soldi, cercare di dialogare con lui, invece di limitarsi a dare una elemosina[20].
Un altro aspetto importante è considerare la brevità del tempo a disposizione. Di fronte alla morte, emerge per contrasto cosa conti davvero nella vita, e spesso questa è la molla decisiva per decidersi ad agire. Con le parole di Mark Twain: «La vita è così breve, non c’è tempo per litigi, scuse, rancori, rese di conti. C’è solamente il tempo per amare e solamente un istante, per così dire, per quello»[21].
Irvin Yalom, accompagnando gruppi di malati terminali, riconosceva, insieme al carico psicologico e affettivo di tale lavoro, un profondo insegnamento capace di ribaltare radicalmente la tavola dei valori di ciò che viene considerato importante. Un membro del gruppo entrò un giorno con un’espressione radiosa sul viso, perché aveva deciso che il suo modo di affrontare la morte poteva essere l’insegnamento più prezioso da trasmettere ai figli: «Non ho mai incontrato un esempio migliore di come avere un significato nella vita generi una sensazione di benessere. È anche un esempio straordinario del concetto dei “cerchi nell’acqua”, che aiuta molti ad attenuare il terrore della morte. I cerchi nell’acqua si riferiscono al passaggio di parti del nostro io ad altri, persino a persone che non conosciamo, proprio come i cerchi provocati da un ciottolo lanciato in uno stagno continuano ad allargarsi finché non sono più visibili e tuttavia proseguono […]. Diversi altri membri del gruppo condividevano quell’esperienza. Secondo le parole di una paziente: “Che peccato aver dovuto aspettare fino a ora che il mio corpo è crivellato dal cancro, per imparare a vivere” […]: anche se la realtà della morte ci può distruggere, l’idea della morte ci può salvare. Mi sembra renda bene l’idea che, siccome abbiamo solo una possibilità di vivere, dovremmo sfruttarla pienamente e concludere la vita con il minor numero possibile di rimpianti»[22].
Convertire la mente
Le molteplici «stelle» di riferimento rilevate dalla psicologia positiva sono accomunate da un radicale ribaltamento di prospettiva circa i criteri di valutazione che giungono dalla spontaneità o dal buon senso. Molti ritengono, ad esempio, che occuparsi di chi sta male potrebbe deprimere o togliere il gusto di vivere (ognuno ha già così tanti guai a cui badare!). Al contrario, la scoperta di sentirsi importanti per qualcuno è motivo di una gioia e contentezza di vivere che nessun’altra cosa sembra essere in grado di dare: «L’impegno sociale nel lungo periodo è un vantaggio per se stessi. Si può verificare che la depressione e il disagio si manifestano con minor frequenza e che si trae maggiore soddisfazione dall’agire per il bene comune piuttosto che dal dedicarsi a piacevoli attività in solitudine. Inoltre, cosa ben più importante, viene meno quel senso di vuoto che accompagna le forme più estreme di individualismo»[23].
«C’è più gioia nel dare che nel ricevere» (At 20,35). Questo insegnamento, per lo più trascurato, coglie la vera essenza della felicità: essa fiorisce in modo inaspettato quando ci si dedica a rendere felici gli altri. Le cose più importanti giungono gratuitamente, e le si può riconoscere quando si smette di preoccuparsi di sé stessi.
Kierkegaard notava che la porta che conduce alla felicità si apre sull’esterno: chi la tira verso di sé la blocca irrimediabilmente[24]. Questa è un’immagine eloquente delle «distorsioni cognitive» e delle false aspettative nei confronti della vita. La pienezza di vivere viene conseguita quando non la si cerca direttamente: quando, in altre parole, si smette di restare ripiegati su sé stessi e sui propri problemi per rivolgersi ad altri, con gratuità.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2024
Riproduzione riservata
***
[1]. Cfr G. Cucci, La forza dalla debolezza. Aspetti psicologici della vita spirituale, Roma, AdP, 20224, 179-186; 201-210.
[2]. D. T. Campbell, «On the conflicts between biological and social evolution and between psychology and moral tradition», in American Psychologist 30 (1975) 1104.
[3]. I. D. Yalom, Momma and the meaning of life. Tales of Psychotherapy, New York, Basic Books, 1999, 22 (in it. Il senso della vita, Vicenza, Neri Pozza, 2022).
[4]. A. Godin, Psicologia delle esperienze religiose. Il desiderio e la realtà, Brescia, Queriniana, 1993, 84. Cfr A. H. Maslow, Toward a Psychology of Being, Princeton, Van Nostrand, 1962, 67-96 (in it. Verso una psicologia dell’essere, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1971).
[5]. Ch. Peterson – M. E. P. Seligman, Character strengths and virtues: A handbook and classification, Washington, American Psychological Association, 2004.
[6]. Cfr A. T. Waterman, «The relevance of Aristotle’s Conception of Eudaimonia for the Psychological Study of Happiness», in Theoretical & Philosophical Psychology 17 (1990/1) 39-44; Id. (ed.), The best within us: Positive psychology perspectives on eudaimonia, Washington, American Psychological Association, 2013.
[7]. Cfr N. Park – Ch. Peterson – M. E. P. Seligman, «Strengths of character and well–being», in Journal of Social and Clinical Psychology 23 (2004/5) 603-619.
[8] . Cfr I. Boniwell, La scienza della felicità. Introduzione alla psicologia positiva,Bologna, il Mulino, 2016, 123; M. Seligman, Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment,New York,The Free Press, 2002, 188.
[9] . Cfr R. Layard, Felicità. La nuova scienza del benessere comune, Milano, Rizzoli, 2005, 84.
[10]. Cfr http://adultdevelopment.wix.com/harvardstudy/; R. J. Waldinger – M. S. Schulz, «What’s love got to do with it? Social functioning, perceived health, and daily happiness in married octogenarians», in Psychol Aging, 25 giugno 2010, 422–431.
[11]. Cfr «Effect on loneliness on local communities», in https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CDP-2017-0221/CDP-2017-0221.pdf/; S. Turkle, Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri, Torino, Einaudi, 2019; M. Spitzer, Connessi e isolati. Un’epidemia silenziosa, Milano, Corbaccio, 2018.
[12]. R. J. Waldinger – M. S. Schulz, «What’s Love Got To Do With It?», cit., 427.
[13]. H. Nouwen, Sentirsi amati. La vita spirituale in un mondo secolare,Brescia, Queriniana, 1993, 72 s.
[14]. H. Murakami, L’arte di correre, Torino, Einaudi, 2009, 4.
[15]. Cfr http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf
[16]. J. Retzbach, «Il senso della vita», in Mind, n. 164, 2018, 31.
[17]. Cfr J. L. Freedman, Happy people: What happiness is, who has it, and why, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1978.
[18]. R. D. Putnam, Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita della cultura civica in America, Bologna, il Mulino, 2004, 345. Cfr G. Cucci, «Il capitale sociale. Una risorsa indispensabile per la qualità della vita», in Civ. Catt. 2019 I 417-430.
[19]. R. Waldinger, «What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness», in https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness
[20]. Cfr M. Seligman, Imparare l’ottimismo. Come cambiare la vita cambiando il pensiero, Firenze, Giunti, 2013, 374 s.
[21]. M. Twain, Lettera a Clara Spaulding, 20 agosto 1886.
[22]. I. D. Yalom, Diventare se stessi, Vicenza, Neri Pozza, 2018, 213 s. Corsivi nel testo.
[23]. M. Seligman, Imparare l’ottimismo, cit., 375 s.
[24]. Cfr S. Kierkegaard, Aut-Aut, in Id., Opere, Firenze, Sansoni, 1972, 10.