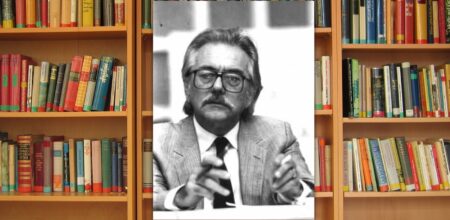|
|
I progressi attuali hanno fatto sì che la medicina sappia prolungare la vita, ma non la sua qualità: molto spesso la medicina riesce solo a rinviare la morte. Ne è derivata la parola «eutanasia» con cui, più che una buona morte, si intende un buon cammino verso di essa; e si reclama il «diritto a morire dignitosamente», che, secondo la maniera egotica con cui noi uomini tendiamo a ragionare, confonde la dignità con l’assenza di malessere e con il non avere bisogno degli altri.
Senza entrare nel merito della questione, in questa sede ci si limita a osservare che la situazione descritta ha cambiato anche il modo in cui vediamo la fine della vita individuale: consideriamo la morte più come un «uscire da» che un «arrivare a». E non sarebbe male interrogarsi sul secondo aspetto.
Sopravvive comunque il termine classico «riposo». Ma questo riposo viene concepito come un addormentarsi (così profondamente che non si è nemmeno più in grado di sognare), piuttosto che come una pienezza autentica: come riposo nel nulla più che come «riposo eterno».
Il corpo: carcere o splendore?
Quanto detto suggerisce che prima di provare ad affacciarci pur sommariamente su quell’«arrivare» concepito come pienezza, è bene dedicare qualche riflessione previa al corpo e al suo naturale deteriorarsi (che pare contraddire quanto si è detto).
Anche qui incontreremo la classica dialettica che pervade tutto l’umano. In effetti, i platonici ai loro tempi parlavano del corpo umano come carcere o prigione dell’anima.
Oggi la nostra idolatria della gioventù e l’ammirazione per le sue promesse (d’altra parte mantenute così di rado), insieme alla paura che abbiamo della caducità (davanti a cui preferiamo chiudere gli occhi), ci hanno portato a disprezzare i greci, a concepire il corpo non come carcere, ma come espressione dell’anima. E abbiamo coniato quell’aforisma ricorrente secondo cui io non «ho» un corpo, ma «sono» un corpo.
Come spesso accade, qui sono in discussione mezze verità non incompatibili …