
|
|
José Tolentino de Mendonça, prima di essere cardinale e prefetto del Dicastero della cultura e dell’educazione, era ben noto in Portogallo per il suo impegno culturale-accademico e militante e per la sua poesia, raccolta nel 2014 in un volume dal titolo A noite abre meus olhos, «La notte apre i miei occhi».
Adesso esce in traduzione italiana la raccolta Il papavero e il monaco. Tolentino scrive nella sua premessa che questo è un libro di haiku, cioè una composizione classica giapponese di tre versi con metrica fissa di cinque, sette e cinque more.
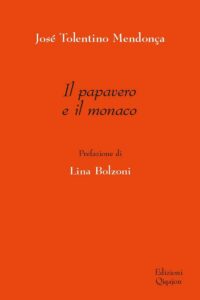
Ma l’haiku di Tolentino è quello assimilato da Jack Kerouac e dai poeti della beat generation, cioè l’haiku liberato dallo schema metrico. Restano però i versi corti. «Io detesto gli accumuli di parole. In fondo, ce ne vogliono così poche per quelle quattro cose che veramente contano nella vita»: sono parole di Etty Hillesum, ma che ben rispondono alla sua intenzione.
Non descrizione, ma apparizione
L’haiku – scrive Tolentino – «si presenta come un’istantanea che cattura il flagrante e l’implicito, la meraviglia e la tensione inerenti alla vita». Alla fine così il cardinale conferma quel che Roland Barthes aveva affermato in un suo celebre saggio: l’arte occidentale trasforma l’impressione in descrizione.
L’haiku invece non descrive mai: la sua arte è anti-descrittiva, nella misura in cui ogni stadio della cosa è immediatamente, caparbiamente, vittoriosamente trasformato in una fragile essenza di «apparizione».
Tuttavia bisogna fugare l’idea che la poesia sia una grazia del tutto esteriore, del tutto indeducibile. Per Tolentino – esattamente come per Cristina Campo –, essa è anche una forma di attenzione, e dunque di ascolto. Se non si tende l’orecchio, non c’è ispirazione. Scrivere poesia è tenere l’orecchio in ascolto.
E il risultato è come un’esplosione in corso, ma colta con un fermo immagine che contiene sia la luce sia le ombre che essa crea. Leggendo le pagine de Il papavero e il monaco viene in mente il poeta statunitense William Carlos Williams…
















