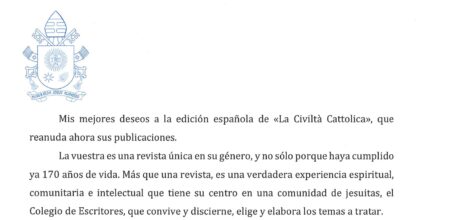|
|
La Laylat al-Qadr («Notte del destino») è uno dei momenti forti della vita di Gerusalemme. In tempi normali, centinaia di migliaia di musulmani accorrono da ogni parte della Palestina e di Israele all’Haram al-Sharif (il Nobile Santuario, un ampio complesso nella Città vecchia, che comprende la Cupola della roccia e la moschea di al-Aqsa) per celebrare questa notte santa.
La notte commemora la prima rivelazione del Corano al profeta dell’islam, Maometto. Ha luogo ogni anno, verso il termine del Ramadan – il mese di digiuno –, e i musulmani della Terra Santa la attedono con trepidazione per trascorrerla in preghiera, in meditazione e in comunità all’interno del sacro recinto. La novantasettesima sura del Corano descrive la Laylat al-Qadr come «migliore di mille mesi», e continua: «In essa discendono gli angeli e lo Spirito con il permesso del loro Signore per [fissare] ogni decreto. È pace, fino al levarsi dell’alba». Ma quest’anno, in cui Laylat al-Qadr è caduta l’8 maggio, non c’è stata pace, e i sogni di molti sono stati infranti dalla rinnovata esplosione di violenza che ha travolto gran parte di Israele e della Palestina.
Sebbene il divampare della violenza non sorprenda coloro che vivono nel cuore di quella piaga non curata che è Israele-Palestina, questa volta l’entità e l’intensità della violenza sono degne di nota.
Gerusalemme, una città sotto assedio
Il mese del Ramadan, iniziato il 12 aprile 2021, è stato contrassegnato dall’ombra della pandemia da Covid-19. A molti musulmani è stato impedito lo spostamento dalla Palestina a Gerusalemme, per la perdurante diffusione del virus e le poche vaccinazioni eseguite nella zona palestinese. Sebbene Israele continui a controllare quei territori, direttamente o indirettamente, disciplinando l’accesso alle aree considerate autonome, e nonostante il notevole successo che ha ottenuto nella lotta contro il coronavirus, il vaccino non è stato condiviso con i palestinesi.
I musulmani provenienti da Gerusalemme e dall’interno di Israele erano soliti confluire per la notte all’Haram al-Sharif. Quest’anno le autorità israeliane hanno deciso di vietare loro di radunarsi alla Porta di Damasco, la principale via di accesso per i palestinesi che si recano all’Haram. La piazza e le scalinate fuori di questa Porta sono abituale palcoscenico di eventi culturali e il punto d’incontro di tutti coloro che lasciano la Città vecchia prima di tornare a casa. Di solito qui le famiglie si scambiano saluti e notizie in un’atmosfera festosa.
La polizia israeliana si è presentata in forze e ha transennato l’area, disperdendo i musulmani che tentavano di radunarsi. Le successive proteste della comunità palestinese, guidate da giovani arrabbiati, hanno denunciato l’azione della polizia come un simbolo del perdurante e inarrestabile tentativo israeliano di impadronirsi dell’intera Gerusalemme Est.
Gli scontri intorno alla Porta di Damasco si sono estesi all’area dell’Haram. Le forze armate israeliane sono penetrate nelle moschee, e molte persone sono state ferite e arrestate all’interno della sacra spianata. Vedere l’intero Haram trasformato in una zona di guerra ha sconvolto, ancora una volta, i musulmani di tutto il mondo.
Poco a nord dell’Haram, il quartiere di Sheikh Jarrah è teatro di un altro tentativo israeliano che dura da anni. Si tratta di uno scenario di crescente violenza, fomentato dagli sfratti imposti a famiglie palestinesi a cui è stato ingiunto di abbandonare le case che avevano occupato all’indomani della guerra del 1948, quando fu istituito lo Stato di Israele. Queste famiglie, fuggite dal territorio divenuto israeliano, si stabilirono in proprietà fino allora abitate da ebrei, a loro volta insediatisi nelle nuove aree disponibili.
Può darsi che la restituzione delle proprietà ai possessori originari risponda a un principio di giustizia, tuttavia questo diritto di ripristino viene applicato esclusivamente agli ebrei. A loro volta, le centinaia di migliaia di palestinesi fuggiti o cacciati dai territori divenuti parte dello Stato israeliano avevano dovuto lasciare proprietà consistenti: case, campi e attività commerciali, che furono espropriati e consegnati agli ebrei immigrati nel Paese. Ora non c’è alcuna intenzione di restituirli agli arabi palestinesi che li possedevano in origine. Inoltre, non appena le proprietà di precedente appartenenza ebraica vengono evacuate dai palestinesi, a prendervi residenza non sono gli ex proprietari, ma coloni ebrei che vi si trasferiscono allo scopo di creare enclave ebraiche forti e sorvegliate nel cuore dei quartieri arabi. Il fenomeno è ben noto a Gerusalemme Est e ripercorre il processo analogo svoltosi nel quartiere di Silwan, nella parte sud della Città vecchia. Arabi ed ebrei progressisti protestano da anni, con scarsi risultati, contro le manovre israeliane a Sheikh Jarrah e a Silwan. In concomitanza con gli eventi alla Porta di Damasco, anche le proteste a Sheikh Jarrah sono diventate più violente.
Sheikh Jarrah, Silwan e la Porta di Damasco sono tre punti chiave di Gerusalemme Est che illustrano un principio generale. Da decenni Israele esercita un rigido controllo sulla parte araba della città, con la determinazione a rendere sempre più difficile la vita dei palestinesi che vi abitano. Subito dopo la guerra del 1967 le autorità israeliane avviarono la costruzione di veri e propri anelli di insediamenti ebraici intorno a Gerusalemme Est, per separarla da Betlemme a sud, da Ramallah a nord e da Gerico a est. Contemporaneamente venne approvata la legge che annetteva Gerusalemme Est, definita parte integrante dello Stato di Israele a Gerusalemme Ovest, capitale «eterna» del popolo ebraico. Il muro che venne costruito all’inizio degli anni Novanta fu presentato dagli israeliani come una misura di sicurezza contro gli attacchi terroristici, ma di fatto ha ulteriormente diviso Gerusalemme Est dal resto del territorio palestinese.
In anni più recenti, le autorità israeliane hanno avviato un processo di mappatura del territorio e pianificazione urbana che prelude a una vasta confisca di terreni e impedisce ai palestinesi di sviluppare la città, di costruire quartieri residenziali e di avviare imprese commerciali. Molti abitanti di Gerusalemme Est, impossibilitati a trovare alloggio nella loro città, sono stati costretti a emigrare oltre i confini municipali israeliani di Gerusalemme, perdendo la residenza, e in molti casi questo ha comportato la confisca delle loro carte d’identità di Gerusalemme. Inoltre, i gerosolimitani che sposano palestinesi della Cisgiordania non possono risiedere con loro a Gerusalemme, perché ai partner è negato il diritto di soggiorno nella città. E se si trasferiscono con il coniuge in Cisgiordania, rischiano di perdere il loro diritto di residenza a Gerusalemme.
Una situazione di stallo politico
La soluzione degli innumerevoli conflitti che oggi investono Gerusalemme e i suoi residenti palestinesi dipende da un processo politico israelo-palestinese che è inesistente. Se, con un eufemismo benevolo, prima del 2017 lo si poteva definire «traballante», a partire da quella data esso è stato letteralmente devastato sotto i colpi dell’amministrazione Trump. Il trasferimento dell’ambasciata americana a Gerusalemme, la rottura delle relazioni ufficiali con i palestinesi e la legittimazione delle politiche di Netanyahu hanno seminato disperazione nei circoli palestinesi.
Più recentemente, il divieto israeliano ai palestinesi di Gerusalemme Est di partecipare alle elezioni politiche generali della Palestina, previste per il mese di maggio del 2021, è servito da giustificazione per l’annullamento dell’intero appuntamento elettorale. Molti palestinesi sono convinti che la vera ragione di questo rinvio fosse dovuta al timore del presidente Mahmoud Abbas di perderle, a vantaggio della fazione islamica di Hamas. Più in generale, gli abitanti di Gerusalemme Est si sentono del tutto abbandonati dall’Autorità palestinese nel far fronte ai tentativi israeliani di controllare Gerusalemme e ritengono che essa preferisca concentrare gli sforzi diplomatici e politici sulla lotta per mantenere l’integrità dei restanti territori in Cisgiordania fuori dalla zona di Gerusalemme.
Un ulteriore contributo a questo stallo politico viene dalla situazione dello Stato israeliano. Nel luglio 2019 Benjamin Netanyahu è diventato il primo ministro israeliano più longevo di sempre, superando David Ben Gurion. Dopo le ultime elezioni israeliane del 23 marzo 2021, egli è stato nuovamente incaricato di provare a formare un nuovo governo. Ma, di fronte alle crescenti critiche che gli venivano non solo dal centro e dalla sinistra israeliani, ma anche dalla destra, necessitava di un sostegno più consistente di quello che gli potevano offrire i suoi alleati ebrei ultraortodossi. Pertanto ha promosso la formazione di una coalizione di estrema destra, che comprendeva esponenti di gruppi estremisti ben noti per il rifiuto di qualsiasi compromesso con i palestinesi e per il razzismo nei confronti di tutti gli israeliani «non ebrei». Queste forze politiche sono entrate in Parlamento all’indomani delle elezioni, convinte che la tenuta di Netanyahu dipendesse da loro e che quindi lui le avrebbe assecondate.
Il 22 aprile, un mese dopo le elezioni, questi gruppi israeliani estremisti hanno organizzato una marcia su Gerusalemme Est, con il proposito dichiarato di restituire l’onore agli ebrei nella città: onore offeso dai video pubblicati sui social media da alcuni giovani palestinesi, che si erano ripresi mentre compivano bravate, come schiaffeggiare e spintonare ebrei in luoghi pubblici. Quelle immagini sono state sfruttate come combustibile per alimentare l’indignazione popolare. Centinaia di attivisti si sono radunati a Gerusalemme Ovest, innalzando striscioni e cantando slogan che minacciavano gli arabi mentre marciavano verso la Porta di Damasco. La polizia israeliana non ha sciolto il corteo, limitandosi a impedire l’accesso dei partecipanti all’area della Porta di Damasco. La violenza, già in corso a causa delle barricate erette dalla polizia, si è intensificata, provocando molti feriti. Bande di manifestanti ebrei sono tornate a Gerusalemme Ovest e hanno aggredito qualsiasi cittadino arabo incontrassero. Pochi giorni dopo, il 25 aprile, la polizia ha annullato la misteriosa e inspiegabile decisione di occupare la Porta di Damasco, ritirandosi e consentendo la rimozione delle transenne. Tuttavia la calma non è durata a lungo, e nelle sere del Ramadan la tensione è rimasta alta.
Quando si è giunti alla Laylat al-Qadr dell’8 maggio, le elezioni palestinesi erano state rinviate a tempo indeterminato e il mandato di Netanyahu di formare un nuovo governo era ormai scaduto. Il 4 maggio, infatti, il presidente israeliano Reuven Rivlin aveva conferito il compito di formare un governo a Yair Lapid, capo dell’opposizione. Questi ha cercato di dare vita a una coalizione anti-Netanyahu, basandola sulle accuse di corruzione contro il premier e sulla sua rottura con gli altri leader della destra israeliana. In sostanza, ha cercato consenso contro la persona di Netanyahu, piuttosto che creare un’alternativa credibile per la società israeliana, e quindi si è visto costretto a ignorare l’attuale situazione instabile per non alienarsi i potenziali alleati di sinistra e di destra. Nel frattempo, Netanyahu ha continuato a governare in attesa che si giungesse alla nomina di un suo successore.
Mentre la Laylat al-Qadr calava sulla città, le autorità israeliane hanno deciso di fermare le decine di pullman che trasportavano a Gerusalemme i fedeli musulmani provenienti dall’entroterra. I passeggeri, tutti cittadini israeliani musulmani, sono scesi dai pullman e si sono avviati a piedi verso la Città santa, convinti che la polizia si sarebbe comportata con maggiore prudenza verso di loro di quanto avesse fatto con i residenti di Gerusalemme Est e degli altri territori occupati. Questo, nel giro di breve tempo, ha indotto le autorità a tornare sulla loro decisione, e i pullman hanno ripreso il viaggio, ma il danno era stato fatto e i pellegrini ribollivano di rabbia. Quella che era vista come la profanazione di un momento e di un luogo sacro ha infiammato i musulmani ovunque, e in particolare nelle città e nei paesi della Palestina e di Israele.
Due giorni dopo la Laylat al-Qadr, il 10 maggio, migliaia di ebrei israeliani sono affluiti a Gerusalemme per celebrare l’anniversario dell’occupazione israeliana di Gerusalemme Est. Yom Yerushalayim («Giorno di Gerusalemme») è una commemorazione annuale che ogni anno ha comportato crescenti tensioni in città. L’evento principale consiste nella «Marcia delle bandiere», in cui migliaia di giovani ebrei israeliani sfilano per le strade di Gerusalemme sventolando bandiere israeliane e cantando canzoni nazionaliste. Durante la marcia attraversano la Porta di Damasco e percorrono il Quartiere musulmano della Città vecchia, diretti al Muro occidentale, luogo sacro e simbolo ebraico, che è situato subito sotto l’Haram al-Sharif. Con un ordine dell’ultimo minuto, il primo ministro Netanyahu ha annullato la parata attraverso la Città vecchia, ma la frustrazione e la rabbia erano già montate e con esse la violenza fuori e dentro l’Haram e nel quartiere di Sheikh Jarrah.
Palestinesi che sono israeliani
La violenza a Gerusalemme Est, e in particolare nell’Haram, ha suscitato forti reazioni non soltanto tra i palestinesi che vivono sotto l’occupazione israeliana entro i territori sequestrati nella guerra del 1967, ma anche tra quei palestinesi che sono cittadini di Israele e vivono all’interno dei confini internazionali definiti nel 1948. Molti di loro avevano sperimentato in prima persona le tensioni a Gerusalemme in occasione del viaggio all’Haram. Gli arabi palestinesi che sono cittadini dello Stato di Israele costituiscono circa il 21% della popolazione complessiva e prendono parte alla vita politica israeliana. Nelle elezioni del 2020, una coalizione di quattro partiti prevalentemente arabi, la Lista comune, era riuscita a ottenere 15 dei 120 seggi parlamentari, un vero primato.
A tenere unita tale coalizione era l’opposizione, concorde sull’occupazione israeliana dei territori palestinesi e sulla discriminazione nei confronti degli arabi all’interno di Israele. Questo programma condiviso è stato tuttavia sconfessato da un importante politico arabo conservatore, Mansour Abbas, che è a capo di una delle quattro formazioni che compongono la coalizione. Abbas non solo ha rotto con gli alleati, ma ha avviato colloqui con la destra israeliana, con l’intento di sostenere un governo Netanyahu. Abbas condivide con la destra israeliana un approccio conservatore a varie questioni sociali. Constatata la scissione della Lista comune, alle elezioni del 2021 molti cittadini arabi di Israele non sono andati a votare. Il consenso ai partiti prevalentemente arabi è sceso da 15 seggi a 10 (sei alla Lista comune e quattro al partito conservatore di Abbas). Dopo le elezioni, la necessità, per Netanyahu, del sostegno di Abbas nella formazione di un governo è diventata stringente. Ma altri suoi alleati, gli estremisti di destra, hanno rifiutato di accettare il coinvolgimento degli arabi nella coalizione che si cercava di formare.
Il rifiuto che gli alleati di Netanyahu hanno opposto ad Abbas ha evidenziato ancora una volta la discriminazione verso i cittadini arabi palestinesi di Israele. Pur avendo il diritto di voto, essi sono confinati in un regime di discriminazione che tocca quasi ogni aspetto della loro vita in uno Stato che si autodefinisce «ebraico», sebbene insista a proclamarsi democratico. Nel 2018, il Parlamento israeliano ha approvato una legge che ribadiva che Israele è lo Stato-nazione del popolo ebraico, evidenziando ancora una volta la natura problematica della democrazia israeliana. La discriminazione che colpisce gli arabi è particolarmente evidente nei settori dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria, dell’occupazione, dello sviluppo della comunità, della proprietà territoriale e dei servizi municipali. Un’altra conseguenza devastante di questo regime discriminatorio è determinata dall’assenza della polizia nelle località arabe: per questo vi sono sbocciati la criminalità, lo spaccio di armi e quello della droga, che ogni anno provoca decine di morti tra i giovani e gli adulti. L’uguaglianza dei cittadini arabi in Israele è, insieme all’occupazione dei territori palestinesi, una delle principali questioni politiche all’interno della società israeliana.
Questa disparità appare più evidente che mai nelle città in cui convivono cittadini ebrei e arabi: Jaffa, Ramla, Lidda, Haifa, Acri e Nazaret. Ai quartieri ebraici viene riservata la maggior parte dei contributi e dei progetti di sviluppo, causando una disuguaglianza evidente per qualsiasi osservatore che paragoni le infrastrutture nei diversi settori di queste località. Gli ebrei e gli arabi che hanno assistito agli eventi di Gerusalemme hanno trasformato queste città in campi di battaglia paralleli. Estremisti ebrei e giovani arabi furibondi si sono scontrati nelle strade. Davanti allo spettacolo dei vicini che aggredivano i vicini e ne distruggevano le proprietà, la discriminazione ha avuto di nuovo la meglio, perché la polizia ha arrestato per lo più arabi e spesso ha chiuso gli occhi sulla violenza ebraica. L’esplosione dell’odio e della vendetta, in particolare nelle città miste, ma in generale in tutto il settore arabo, per le autorità israeliane costituisce una sfida forse ancora più grande che non gli eventi di Gaza, perché intacca il tessuto sociale israeliano e smentisce i ricorrenti slogan sulla coesistenza arabo-israeliana all’interno di Israele.
Gaza ruggisce e geme
Il 10 maggio, mentre gli entusiasti partecipanti al «Giorno di Gerusalemme» si accingevano a far partire la loro parata, diretta oltre la Porta di Damasco e attraverso il quartiere musulmano, Hamas, il movimento islamico che a Gaza costituisce anche il governo locale, ha pronunciato un ultimatum per gli israeliani, chiedendo il ritiro immediato delle loro forze armate dall’Haram. Se non fossero state immediatamente rimosse, Hamas minacciava di bombardare di missili Gerusalemme e altre città israeliane. Per molti, in tutto il mondo, l’intera vicenda che stiamo riepilogando ha avuto inizio quando Hamas ha effettivamente lanciato i suoi missili. Questo atto di guerra ha attirato l’attenzione di un mondo sostanzialmente annoiato dalle continue schermaglie tra israeliani e palestinesi.
Hamas, che è di ideologia islamica e considera la distruzione di Israele come un proprio obiettivo, da molti mesi aveva promosso un periodo di pace con Israele, dialogando con i rappresentanti di Netanyahu attraverso mediatori egiziani ed europei. Il bombardamento di Israele, compiuto in nome della difesa della moschea di Al-Aqsa, probabilmente ha dato sfogo anche alla frustrazione accumulata in mesi di negoziati infruttuosi. Inoltre, Hamas aveva sperato che la programmata tornata elettorale palestinese avrebbe portato a una sua vittoria, sicché il rinvio delle elezioni è stato un duro colpo.
In sostanza, sia Netanyahu sia i dirigenti di Hamas hanno scelto di impegnarsi in un conflitto aperto e violento animati da secondi fini: Netanyahu per rimanere al potere; e i dirigenti di Hamas per guadagnarsi il sostegno popolare senza il processo elettorale. Alla luce della crisi in atto, figure importanti dell’opposizione a Netanyahu hanno abbandonato i tentativi di formare un governo alternativo, e molti palestinesi hanno applaudito alla spavalderia di Hamas.
Il boato proveniente da Gaza è risuonato in tutto Israele. La pioggia di missili ha fatto correre israeliani terrorizzati nei rifugi, e un certo numero di loro è morto sotto il fuoco (10 persone entro il mezzogiorno del 17 maggio). I missili sono piovuti sulle aree meridionali (comprese le città di Beer Sheva, Sderot e Ashkelon), ma hanno raggiunto anche il centro del Paese e le zone intorno a Tel Aviv e a Gerusalemme. Hamas ha rivelato un arsenale più imponente di quanto la maggior parte degli israeliani si aspettasse. La rappresaglia israeliana è stata immediata e violenta. Fino al 17 maggio, 196 abitanti di Gaza erano stati uccisi dai bombardamenti, oltre 1.200 persone erano rimaste ferite, e i danni materiali erano enormi.
Al ruggito di Gaza ha fatto eco il gemito continuo di un’area che è di nuovo insanguinata e devastata. Gaza è da anni sotto assedio e sotto il controllo di un regime islamico autoritario. Con i suoi vasti campi profughi, è fortemente sovrappopolata; oltre il 70% degli abitanti sono discendenti di rifugiati da quelle aree della Palestina che nel 1948 divennero israeliane. Di fatto, Gaza è il luogo più densamente popolato della Terra: conta due milioni di persone che vivono in un’area geografica di 364 chilometri quadrati. La disoccupazione è vicina al 50%; l’elettricità scarseggia, con forniture che non superano le otto ore al giorno; quasi assenti sono le infrastrutture idriche e fognarie. Lo sviluppo economico è pressoché inesistente. La miseria di Gaza è proverbiale quanto la vitalità e la prosperità di Tel Aviv.
Quanto manca all’alba?
Mentre il mondo sta a guardare, israeliani e palestinesi continuano a combattere. Purtroppo, questa non è una novità, né una sorpresa. Quella di Israele-Palestina è da decenni una ferita non curata. Vi assiste gran parte del mondo, esprimendo generiche condanne della violenza e torcendo il linguaggio in modo che rimanga imparziale e, alla fine, inefficace. La ferita resta insanguinata e non medicata. Anche adesso chi si adopera per placare gli animi e far tacere le armi fa affidamento sulla stanchezza. In definitiva, l’obiettivo rimane «ristabilire la calma», in modo che la vita possa continuare. Tuttavia, quando la vita continuerà, e così sarà, per la maggior parte dei palestinesi si tratterà di una vita ancora sotto occupazione e all’ombra della discriminazione, e per la maggior parte degli israeliani di una vita vissuta nel timore di rappresaglie e violenze. Una piaga non curata come Israele-Palestina continuerà a suscitare ideologie improntate all’odio e alla vendetta, che generano disprezzo e promuovono la violenza. Perché la realtà è guerra fino al levarsi dell’alba, l’alba di un nuovo giorno.
Il Pontefice è intervenuto due volte al Regina Coeli sul conflitto. Il 9 maggio ha invitato «tutti a cercare soluzioni condivise affinché l’identità multireligiosa e multiculturale della Città Santa sia rispettata e possa prevalere la fratellanza». Il successivo 16 maggio ha denunciato la «spirale di morte e distruzione», affermando: «Numerose persone sono rimaste ferite, e tanti innocenti sono morti. Tra di loro ci sono anche i bambini, e questo è terribile e inaccettabile. La loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro, ma lo si vuole distruggere». Ha invitato tutti a pregare «incessantemente affinché israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono, per essere pazienti costruttori di pace e di giustizia, aprendosi, passo dopo passo, ad una speranza comune, ad una convivenza tra fratelli».
Una dichiarazione rilasciata dal Patriarcato latino di Gerusalemme il 9 maggio, giornata intermedia tra la Laylat al-Qadr e il «Giorno di Gerusalemme», riferendosi a Gerusalemme, auspica l’alba di un nuovo giorno: «La nostra Chiesa è stata chiara sul fatto che la pace richiede giustizia. Fintantoché i diritti di tutti, israeliani e palestinesi, non saranno sostenuti e rispettati, non ci sarà giustizia, e quindi nessuna pace nella città. È nostro dovere non ignorare l’ingiustizia né alcuna aggressione contro la dignità umana, indipendentemente da chi le commette». Queste parole riguardo a Gerusalemme si possono estendere all’intero Israele-Palestina. Secondo questa dichiarazione, tutti – israeliani e palestinesi, ebrei, musulmani e cristiani – devono avere «lo stesso diritto di costruirsi un futuro basato sulla libertà, sull’uguaglianza e sulla pace». Inoltre, il Patriarcato si è spinto a immaginare un giorno in cui Gerusalemme possa essere «un luogo di preghiera e di incontro aperto a tutti, e dove tutti i credenti e i cittadini, di ogni fede e appartenenza, possono sentirsi “a casa”, protetti e sicuri». Sarebbe davvero l’alba di un nuovo giorno, un giorno di pace.
* * *
Il 21 maggio 2021, alle 2 del mattino, è entrato in vigore un cessate il fuoco, mediato dall’Egitto dopo che l’amministrazione statunitense è riuscita a far comprendere al primo ministro israeliano Netanyahu che i bombardamenti su Gaza dovevano finire. Sia l’amministrazione Netanyahu sia Hamas hanno immediatamente rivendicato la vittoria, entrambe le parti sottolineando la distruzione che avevano causato nelle vite di quelli della parte avversa. Dodici erano i morti da parte israeliana – tra cui tre lavoratori immigrati e due cittadini arabi palestinesi di Israele –, mentre 226 palestinesi erano morti a causa dei bombardamenti israeliani di Gaza, e altri 12 palestinesi erano stati uccisi dai soldati israeliani in Cisgiordania. Nonostante le affermazioni in senso contrario, è improbabile che quest’ultimo conflitto abbia aggiunto qualcosa di positivo alla risoluzione delle cause profonde della violenza. L’unica domanda che rimane ora è quanto durerà la calma prima del prossimo ciclo di violenza.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2021
Riproduzione riservata