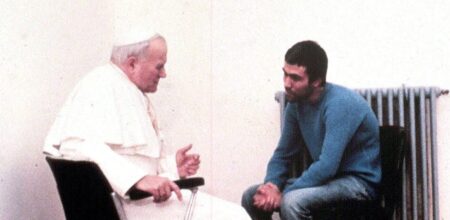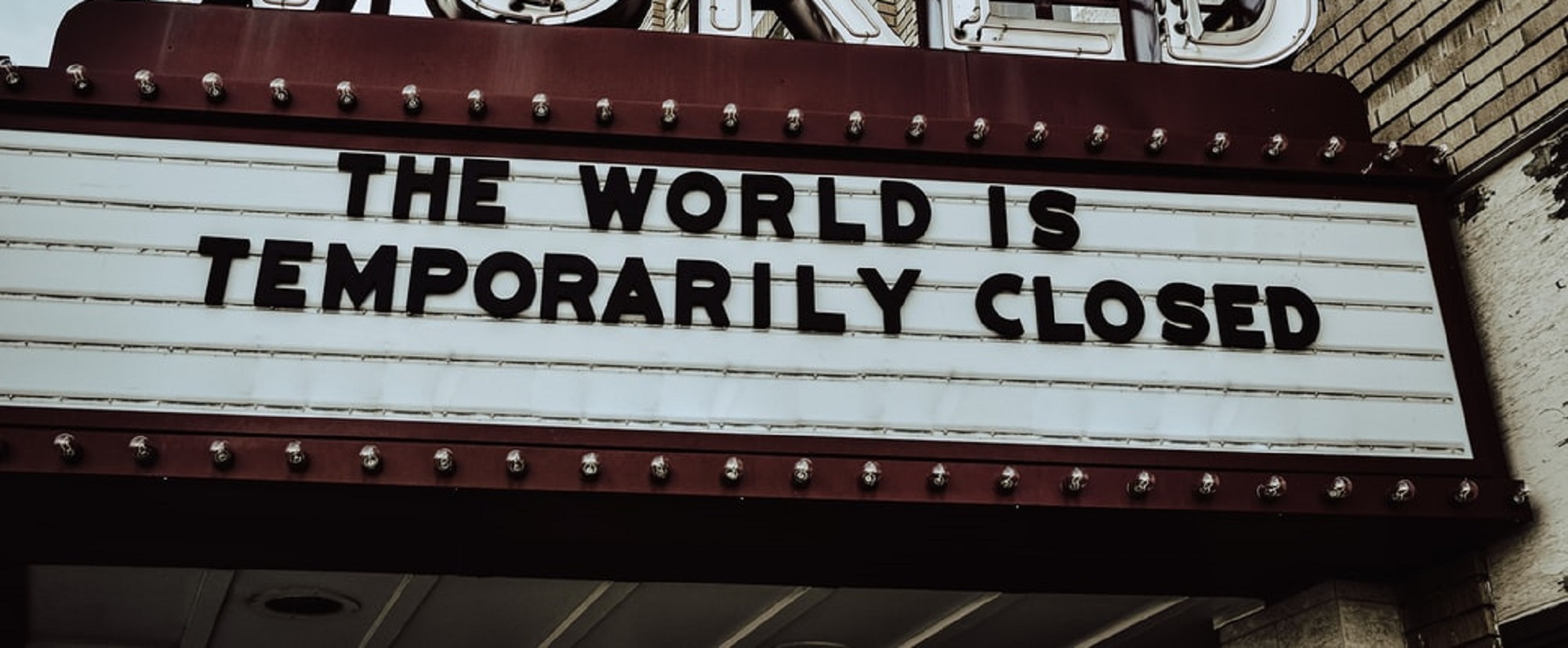
|
|
L’irruzione di una nuova malattia comporta incertezza e paura, soprattutto se facciamo parte delle categorie più vulnerabili. A seconda dell’accessibilità di dispositivi medici e della nostra possibilità di proteggerci, la minaccia tocca diversamente il nostro modo di comprenderla e di proporre soluzioni. Vogliamo qui approfondire una caratteristica specifica della minaccia virale che ci colpisce: potremmo definirla la sua «capacità di rivelare».
Covid-19, silenzioso rivelatore di realtà nascoste
Svelare è scoprire qualcosa di nascosto, portarlo alla luce, togliere il velo. Il Covid-19, fra i suoi tanti connotati, si presenta come un silenzioso rivelatore di molte realtà che spesso rimangono nascoste nella quotidianità dei sistemi economici, politici, sociali e culturali, nei quali, in un modo o nell’altro, siamo immersi. Superando frontiere irrigidite e vigilate, ha denunciato politiche xenofobe, nazionaliste e razziste, i cui discorsi ha reso inconsistenti. Si accanisce ad accusare i sistemi sanitari di quei Paesi che, avendo a suo tempo trascurato di investire nella salute pubblica o avendone consegnato l’amministrazione al settore privato, oggi non hanno altra alternativa se non riconoscere il valore di un sistema sanitario di qualità e accessibile a tutti. Il virus mette in risalto le preoccupazioni reali dei ricercatori scientifici e delle grandi aziende farmaceutiche che li finanziano. Pone in evidenza la voracità di un mercato globale che si sfrega le mani con l’unguento della speculazione.
Questo agente infettivo tradisce la ricerca di un silenzio complice da parte del sistema economico, che mette il capitale al di sopra dell’essere umano. Nel contempo, rimprovera aspramente le trascuratezze dei sistemi educativi, di tutela degli anziani, della produzione nazionale, dei diritti del lavoratore, del settore abitativo, della lotta contro la povertà estrema e la denutrizione. Rinfaccia le lacune dell’autorità politica e ne mette a nudo gli eterni alleati. Smaschera gli individualisti, gli accaparratori, coloro che cercano di rimestare nel torbido a forza di corruzione. Rende manifesta la disuguaglianza dei popoli, permettendosi perfino di irrompere nei Paesi – diversamente da altre epidemie – passando attraverso le classi più abbienti, quelle che possono viaggiare. Per utilizzare un’immagine, e fatte le opportune distinzioni, il Covid-19 si potrebbe considerare l’accusatore più efficace e profetico dei nostri tempi; ma per svolgere il suo compito ha utilizzato un metodo crudele: la morte di migliaia di persone. Forse a questo si riferiva Albert Camus, quando affermava che «il flagello ama il segreto delle tane»[1].
Ci sembra giusto interrogare questo divulgatore efficace su ciò che porta alla luce attraverso le riflessioni che suscita nel suo propagarsi. La filosofa spagnola Patricia Manrique[2] ha tuttavia ammonito che la riflessione sugli avvenimenti attuali richiede tempo, se vogliamo evitare che il nostro sguardo distorto impedisca alla novità che vorremmo analizzare di mostrarci la sua effettiva realtà. E ricorda con Emmanuel Lévinas che affrettarsi a dire qualcosa finisce per ridurre l’«alterità» a «ipseità»[3].
L’avvertimento non è fuori luogo. L’enorme flusso di opinioni e ragionamenti sulla pandemia che proviene in questi tempi dal mondo intellettuale e il modo in cui essi si appiattiscono sul pensiero previo individuale tradiscono una fretta riflessiva. Per questo Manrique fa leva sulla necessaria «ospitalità dell’alterità», che permette all’ideologia e alla «egoità» di cedere il passo alla novità nata dalla realtà che si cerca di comprendere. Il suo invito suggerisce di lasciare che la nuova realtà susciti domande e generi una serena ricerca di risposte. Innegabilmente ci propone un modo controculturale di analizzare la realtà. La fretta riflessiva, infatti, appare curiosamente affine al produttivismo capitalista che molti intellettuali desiderano contrastare, e l’ansia di riempire gli spazi aperti dal blocco delle attività stride con le critiche alla cultura postmoderna che emergono dalla filosofia, dall’antropologia e dalla sociologia contemporanee.
Riflessioni sulla pandemia da parte del mondo intellettuale
Osserviamo ora alcune reazioni alla pandemia da parte del mondo intellettuale. Il filosofo italiano Giorgio Agamben[4] non ha esitato a denunciare qualcosa che è sempre stato un suo tema di ricerca: lo stato di eccezione eletto a metodologia normale di governo. A partire da questo egli ha definito sproporzionate le misure di isolamento e si è riferito all’epidemia come a un’invenzione pretestuosa, tesa a limitare uno dei valori più importanti dell’Occidente: la libertà. Ha bollato le misure di confinamento, definendole una reazione esagerata a quella che ha asserito essere «una normale influenza». Ha ridotto il virus a mero sostituto ideologico del terrorismo, nella misura in cui giustifica l’eccezionalità e provoca il panico collettivo. Panico che pochi giorni dopo egli denunciava come causa dell’abolizione del prossimo in virtù del paradigma del portatore asintomatico[5]. Questo, secondo lui, genera il timore dell’incontro e pertanto l’annullamento dell’azione politica, obiettivo ultimo dei governanti, le cui misure adottate vengono da lui denunciate come più dure di quelle del fascismo e del nazismo[6]. Camus, nel testo che abbiamo citato, afferma: «Vi tocca pensare spesso alla vostra ignoranza, per essere sicuri di osservare la misura, unica padrona dei flagelli»[7]. Non erano necessarie tante morti per riconoscere come vera la minaccia, e le misure di distanziamento come una via per prendersi cura del prossimo.
Il chimico e filosofo catalano Santiago López Petit[8] ha fatto subito eco ad Agamben, sostenendo che il virus è stato prodotto dal capitalismo – che egli ritiene di per sé omicida – per normalizzare lo stato di eccezione. Secondo lui, il capitalismo sfrenato articola la propria agroindustria e l’eziologia delle pandemie recenti in modo tale da produrre il virus, che poi userà per controllare la popolazione. Per la precisione, egli avverte che non si tratta tanto di un complotto, quanto piuttosto della conseguenza logica dell’essere vittime dell’«algoritmo della vita», che programma tutto e mette in primo piano – valendosi del consenso neoliberale – la decisione politica e la nazionalizzazione.
Da parte sua, Slavoj Žižek[9], uno dei sociologi più provocatori del momento, si è affrettato a proclamare i colpi mortali inferti al capitalismo e la reinvenzione del comunismo come conseguenze che sorgerebbero dalla pandemia di Covid-19. La sua posizione si fonda su un ottimismo peculiare. Egli osserva che il virus ha messo in luce pandemie già esistenti nelle nostre società: le fake news e le teorie paranoiche del complotto, così come le manifestazioni di razzismo e xenofobia. D’altra parte, esso offre la possibilità contagiosa e virtuosa di sognare una società alternativa. Su queste basi Žižek si spinge a immaginare una trasformazione radicale del sistema economico mondiale basata sulla brusca riscoperta di una vulnerabilità biologica ed ecologica condivisa. La sua proposta consiste nell’adottare il comunismo come sistema politico ed economico, non però alla maniera antica, bensì come comunismo della solidarietà, della fiducia, della scienza e dell’impegno; il tutto governato, secondo il suo progetto, da un organismo regolatorio economico globale. L’entusiasmo di cui è impregnato il suo argomentare, teso verso una proiezione del futuro che rasenta l’ingenuità, contrasta con la totale assenza, nella sua riflessione, delle conseguenze umane della pandemia. E certamente l’entusiasmo ideologico può precludere uno sguardo obiettivo sul dolore circostante.
Il dibattito non si è fatto attendere. Byung-Chul Han[10], filosofo coreano residente a Berlino, meno ottimista di Žižek, ritiene che il capitalismo non soltanto seguirà il suo corso, ma vedrà la Cina nel ruolo di vigilante e accaparratrice della produzione mondiale. Il capitalismo continuerà, secondo lui, perché la sua sparizione significherebbe un cambiamento radicale di stili di vita ben consolidati, e anche perché, affinché questo accada, sarebbe necessaria la volontà di trasformare i poteri economici mondiali, che invece in queste circostanze continuano ad accumulare profitti. È enfatico: «il virus non può sostituire la ragione», tantomeno «genera alcun sentimento collettivo forte»; pertanto non ha la capacità rivoluzionaria che Žižek gli attribuisce.
Tuttavia Han vorrebbe un mondo in cui l’individualismo perdesse centralità, per l’incontro con la «negatività dell’altro», come ha sottolineato di continuo nella sua opera[11]. Egli lo propone da una prospettiva della realtà più collettivista, denunciando misure assurde, come la chiusura delle frontiere, o perfino strizzando l’occhio alla cessione della privacy, alla maniera orientale, per il controllo di pandemie future. Il suo grande timore, così come per Agamben, è che il virus si trasformi in una giustificazione per instaurare situazioni di eccezionalità foriere di totalitarismo. Purtroppo Han sorvola senza approfondirli, e relega al margine, dati come il numero delle morti causate dal virus o lo scarto preventivo subìto dagli anziani nella distribuzione delle cure e dell’attenzione clinica.
Anche il filosofo italiano Franco Berardi[12] ha aggiunto la propria parte di scetticismo alla caduta del capitalismo. Inoltre, egli ritiene che il neoliberalismo approfitterà di questa pandemia per estendere ulteriormente i propri tentacoli. Lo farà, egli dice, poggiando su nuove forme di controllo e di segregazione delle popolazioni: in altre parole, sfruttando la biopolitica e il totalitarismo. Berardi è convinto che entrambe queste dinamiche si affermeranno, dato che culturalmente non siamo preparati alla privazione della mobilità e a separare il piacere dal consumo, tantomeno a dare valore alla frugalità e alla condivisione. Questo sguardo sull’umanità lo conduce a una diagnosi ambigua: da questa crisi usciremo o più individualisti, aggressivi, egoisti e competitivi, o più solidali e desiderosi di uguaglianza.
Noi crediamo che sia troppo presto per dirlo, ma al tempo stesso pensiamo che siamo ancora in tempo per provare, almeno, a influire sul risultato finale della pandemia. Ci sarà da fare. La valutazione di Berardi circa le possibilità umane e la cultura contemporanea non infonde speranza. Noi però non crediamo che questa sia l’unica verità dell’essere umano: nel mondo ci sono anche desideri, volontà e opportunità per un impegno maggiore nella direzione della giustizia, dell’empatia e della solidarietà.
Dal canto suo, la filosofa Judith Butler[13], nel contesto sociopolitico degli Stati Uniti, ha insistito sul fatto che il virus non fa discriminazioni, mentre non si può dire lo stesso di noi esseri umani. Ne deriva, secondo lei, il legame tra nazionalismo, razzismo, xenofobia e capitalismo nel modellare le relazioni discriminatorie che la pandemia può suscitare, con il nefasto risultato che alcune vite vengono valutate più degne di altre. Butler asserisce che la disuguaglianza sociale ed economica imperante nel mondo consente al virus di fare discriminazioni sull’accesso alle cure mediche e, in futuro, all’assunzione del vaccino tanto atteso.
Ma, ancora una volta, le discriminazioni non sono da attribuirsi al virus: la denuncia va convogliata sui responsabili dei sistemi politici, sociali ed economici, che classificano le persone per categorie a seconda del potere di acquisto, dell’origine etnica e dei documenti migratori, facendo sì che esse vengano percepite e trattate come esseri umani di seconda categoria. La discriminazione, la pressione economica e le dinamiche che creano esclusione sociale oggi mostrano il loro vero volto. L’indifferenza e l’apatia di fronte alla situazione di coloro che subiscono alcune di queste dinamiche non devono rientrare tra le opzioni per configurare il nostro futuro.
Questo tipo di «virus» discriminatorio, che adesso potrebbe esplodere approfittando della minaccia biologica che ci confina nelle case, viene denunciato di riflesso anche dall’antropologo David Harvey[14], il quale indaga sulle possibilità di sussistenza del capitalismo globale. Egli non ritiene casuale che l’emergenza causata dal virus provochi uno squilibrio economico globale. Secondo lui, ciò è dovuto a una politica neoliberista incentrata sugli affari piuttosto che sulle persone e sul loro benessere. Oggi è necessario mettere le persone al centro delle politiche pubbliche e dell’economia. Quindi si dovranno cercare forme creative e impegnate per incidere, come individui e come collettività, sulla configurazione di un futuro più solidale, umano ed ecologicamente sostenibile.
Filosofi come Alain Badiou[15] hanno una visione più pessimista riguardo alla capacità rivoluzionaria del virus, vista la sconfortante ingenuità delle analisi e delle proposte che sorgono in rapporto alla pandemia. Badiou giunge ad affermare che uno degli effetti della pandemia è quello di dissolvere parte dell’attività intrinseca della ragione, suscitando misticismi, profezie, favole e maledizioni del tutto infondati. Egli osserva inoltre che la complessità della situazione attuale mescola insieme cause naturali e sociali, la dimensione economica e quella politica, quella locale e quella transnazionale, e pertanto non consente soluzioni uniche o troppo innovative: infatti, davanti alla paura, per proteggerci, ci aggrappiamo a ciò che ci è già noto.
Frontiere e soluzioni
Come esito di questa dinamica, i politici propongono soluzioni alla pandemia che cerchino di mantenere quanto più possibile intatto il sistema economico. Di fatto, ciò innesca la più estesa delle discussioni a livello mondiale – non per questo meno contestabile dal punto di vista morale –, che si propone di distinguere – cercando di mettere insieme entrambe le opzioni – fra la salute delle persone e la salvezza dell’economia. Ma salvare quest’ultima potrebbe significare lasciare proprio intatta quell’economia incentrata sul capitale che genera una spirale di disuguaglianza, di mancanza di opportunità, di precarietà lavorativa e di fame nel mondo, ossia esattamente quella che scarta metà dell’umanità e le impedisce di vivere dignitosamente[16]. Scegliere come fulcro delle politiche pubbliche la salvezza dell’economia, del tipo di economia nella quale siamo immersi, equivarrebbe a segregare i più poveri dietro il muro dell’indifferenza. Urgono proposte di economia solidali e socialmente responsabili verso la vita di coloro che soffrono di più.
Il filosofo tedesco Gabriel Markus[17] ritiene che il Covid-19 accentui l’idea dell’unità globale e dell’uguaglianza dell’intera umanità. Davanti al virus, egli afferma, non siamo altro che questo: umani, ospiti per la sua riproduzione; non ci sono differenze. Per questo Markus si interroga sull’utilità di chiudere le frontiere tra i Paesi, se non per prevenire il collasso dei sistemi sanitari nazionali. Allo stesso modo, egli critica l’ordine mondiale pre-pandemia, definendolo letale. Propone un nuovo illuminismo, che sappia educare nell’etica le nuove generazioni affinché non cadano in una cieca fiducia nella scienza e nella tecnica, ormai in disgrazia per non aver saputo contenere questa minaccia virale. Pertanto invita a una «pandemia metafisica»[18]: il ritorno alla normalità non dovrebbe condurre a un rapido oblio di quanto accaduto, ma a un impegno solidale generato da un’umanità condivisa.
Lo storico israeliano Yuval Noah Harari[19] si associa a Markus e a Han nel denunciare l’assurda chiusura delle frontiere[20]. Egli rivolge un duplice appello: a guardare oltre l’urgenza della pandemia e a pensare al mondo in cui desideriamo vivere dopo che la pandemia sarà superata. In questa linea, Harari pone le seguenti alternative: o la vigilanza totalitaria o la legittimazione dei cittadini; o l’isolamento nazionalista o la solidarietà globale. Quello che teme è una sorveglianza informatica che limiti la libertà. Quando si chiede alla popolazione di scegliere fra la propria privacy e la salute, la si sottopone a un’opzione ingannevole. Harari afferma chiaramente che senza fiducia e senza solidarietà globale la pandemia non potrà essere contrastata con successo. E conclude che la soluzione alla pandemia non verrà dalla segregazione, bensì dalla cooperazione. A questo riguardo, secondo noi, la cooperazione deve essere ispirata da un alto grado di giustizia sociale, di equità e di ricerca del bene comune.
Il filosofo e politico inglese John Gray[21] ritiene che stiamo assistendo a un addio all’iperglobalizzazione. Secondo lui, la biovigilanza da parte dello Stato, alla quale gli individui saranno disposti a cedere per la loro sicurezza, sarà la modalità postliberale di governare. Appare singolare la sua affermazione secondo la quale il sistema politico resterà intatto e al contempo sarà il motore di un cambio di prospettiva nella gestione del mercato mondiale, che diventerebbe più bilanciato dalla produzione locale e meno basato sull’efficienza. La sua proposta prevede gli stessi attori e un tempo davvero esiguo per giungere a una trasformazione così radicale. Curiosamente, Gray ritiene «pensiero magico» la convinzione che l’aumento della cooperazione internazionale sarà la chiave per risolvere l’emergenza virale ed economica. A ciò dovrebbe aggiungersi il fatto che la popolazione, di fronte alla perdita di mobilità, cederebbe il passo alla virtualizzazione. Nella proposta del filosofo inglese si percepisce la fretta. Un cambiamento così drastico e accelerato dell’economia e della cultura non può avvenire a partire dall’isolamento e dalla passività: per lo meno ci devono essere empatia, incontro, dialogo, uscita da sé e impegno solidale.
Come possiamo osservare, tra i pensatori contemporanei predomina la preoccupazione per le dimensioni politiche, economiche e sociali che potrebbero minacciare la libertà dei cittadini. Alcuni ne traggono proposte dalla sinistra, altri dalla destra intellettuale. Quel che è certo è che è ancora troppo presto per sapere quali saranno le conseguenze politiche, economiche o psicologiche con cui dovremo confrontarci. Non sappiamo se la nostra cultura cambierà radicalmente o se riprenderà presto il ritmo di prima. Ci rimane l’immaginazione come vaccino intellettuale, come ha detto David Grossman[22].
Una trasformazione globale
Ma ora ci permettiamo di incorrere in quel procedimento di cui con Patricia Manrique avevamo elogiato la criticabilità: daremo la nostra opinione. Noi riteniamo – e lo diciamo facendo una generalizzazione consapevole e azzardata – che le preoccupazioni della classe intellettuale siano più legate a un comodo immaginario che a uno sguardo profondo sulla realtà che la gente vive. Chi cerca con cura, nei tanti articoli che si susseguono, parole come «povertà», «indigenti», «emarginazione» o «esclusione sociale», noterà come esse risultino le grandi assenti dalle riflessioni di questi giorni. Sorprende infatti che la parola «vulnerabile» venga pronunciata soltanto in relazione a coloro che potrebbero subire maggiori conseguenze dal virus, vale a dire in un’unica accezione: «vulnerabilità biologica»[23].
Nel contesto latinoamericano è emersa anche qualche sporadica riflessione più legata ai tradizionali temi Nord-Sud o agli imperialismi postcoloniali, almeno nell’ambito filosofico[24], ma non in quello teologico. Non è forse vero che, nella fretta di esprimere opinioni, ci siamo dimenticati degli indigenti? Non si sta forse insinuando una difesa velata del liberalismo, a forza di evidenziare a tal punto i limiti delle libertà individuali e collettive? Non lo sappiamo, e nemmeno vogliamo incolpare nessuno. Noi stessi ci troviamo a scrivere queste righe da una residenza per professori a Madrid, dove disponiamo di un grande giardino in cui possiamo passeggiare e, sebbene in casa abbiamo una persona contagiata dal virus, le dimensioni dell’ambiente ci permettono di mantenerla isolata e di proteggerci dal pericolo del contagio.
Se guardassimo la realtà soltanto a partire da dove abitiamo e dalle nostre possibilità, il maggiore inconveniente potrebbe essere per molti di noi solo quello di non poterci muovere liberamente all’esterno. Ma constatiamo anche che proprio qui, attorno a noi, ci sono persone senza tetto che se la passano molto male, che tante persone perdono il lavoro o avvertono il rischio che, quando tutto questo sarà finito, non avranno un posto in cui vivere. La quarantena per una famiglia numerosa che abita in una casa di piccole dimensioni equivale a un supplizio. I giovani corrono il rischio che si amplifichi la loro già consueta precarietà lavorativa. In molti angoli del mondo i lavoratori immigrati e le popolazioni vittime di discriminazione razziale sono i più colpiti dal virus, che li coglie senza risorse, senza assicurazioni sanitarie e stigmatizzati dall’esclusione e dalla disuguaglianza. Questa realtà è per lo più assente da molte delle considerazioni fatte e scritte.
Per questo, se ci è concesso di immaginare una trasformazione globale, essa deve sorgere «dal basso», dall’integrazione degli esclusi di questo mondo. Perché questo accada, la classe intellettuale dovrà associarsi alla funzione rivelatrice e accusatoria del Covid-19, oppure tutto si limiterà a un mero appoggio al ristabilimento dell’ordine precedente, in cui gli emarginati di sempre torneranno invisibili ai poteri reali di questo mondo.
Se il virus sta mostrando la vulnerabilità dei Paesi ricchi e la loro suscettibilità alla morte – così come per tutti gli esseri umani –, non dobbiamo ignorare o dimenticare che tale situazione non è affatto nuova per quanti in questo mondo si trovano nella povertà estrema, anche prima e senza il coronavirus. Essi convivono abitualmente con la morte, sia per assenza dei servizi essenziali (acqua, cure mediche e così via), sia per la loro vulnerabilità rispetto alla violenza sistematica e concreta. Non c’è dubbio che le riflessioni sulla biopolitica o la sorveglianza informatica, sulla farmacopornografia[25] o la psicopolitica siano interessanti, e nemmeno metteremo in discussione l’attualità del filosofo Michel Foucault; ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che questi temi sono importanti per una minoranza degli esseri umani. La fame, la denutrizione, il mancato accesso all’acqua potabile, la violenza di ogni tipo, l’insicurezza sociale e sanitaria, la corruzione, la scarsa qualità dei sistemi educativi, la precarietà lavorativa e così via costituiscono la quotidianità di oltre la metà dell’umanità. Il Covid-19 mette tutto questo in piena evidenza.
Dato che la pandemia ha toccato duramente i Paesi più ricchi, le preoccupazioni del mondo intellettuale cambieranno, ora che è quanto mai chiaro che siamo tutti uguali? Sperando che l’immaginazione non si prenda gioco di noi, crediamo che qualsiasi possibile trasformazione culturale del mondo come frutto dell’irruzione della vulnerabilità biologica condivisa sarà efficace soltanto se riconosceremo che il miglioramento delle condizioni di vita di tutti andrà a beneficio dell’intera umanità. Auspichiamo che nelle nostre peregrinazioni filosofiche non ci dimentichiamo di coloro che, emarginati dai sistemi sociali, economici, politici e culturali, dovrebbero occupare il centro delle nostre denunce profetiche e costituire il cardine delle nostre preoccupazioni e delle nostre azioni. Siamo convinti che questo ci renderebbe più umani.
***
– ESPAÑOL —
Copyright © 2020 – La Civiltà Cattolica
Riproduzione riservata
***
PHILOSOPHERS ON THE VIRUS. Intellectuals respond to Covid-19
The Coronavirus contagion has seen many intellectuals analyze its incidence, and to imagine a post-pandemic future. At the core of this article we find the revelatory character of Covid-19, and its ability to highlight the forces at play in the issues of poverty, exclusion and social vulnerability that pass unnoticed, or which perhaps we have decided to ignore in our daily lives. Thus, it openly addresses and reproaches humanity for the enormous social inequalities, dehumanizing management of the economy and neglect of life in general, under the pretext of dubious, and unjust progress. Will the injustices brought to light by the virus transform the intellectual world’s analysis?
***
[1]. A. Camus, «Esortazione ai medici», in Oss. Rom., 6 aprile 2020.
[2]. Cfr P. Manrique, «Hospitalidad e inmunidad virtuosa», in La Vorágine, 27 marzo 2020.
[3]. Cfr E. Lévinas, Totalità e infinito, Milano, Jaca Book, 2006.
[4]. Cfr G. Agamben, «L’invenzione di un’epidemia», in Quodlibet, 26 febbraio 2020.
[5]. Cfr Id., «Contagio», ivi, 11 marzo 2020.
[6]. Cfr Id., «Nuove riflessioni», ivi, 22 aprile 2020.
[7]. A. Camus, «Esortazione ai medici», cit.
[8]. Cfr S. López Petit, «El coronavirus com a declaració de guerra», in Critic, 18 marzo 2020.
[9]. Cfr S. Žižek, «Il coronavirus è un colpo al capitalismo à la Kill Bill che potrebbe reinventare il comunismo», in Sovrapposizioni, 6 marzo 2020.
[10]. Cfr B.-C. Han, «L’emergenza virale e il mondo di domani», in Global Project, 1 aprile 2020.
[11]. Cfr B.-C. Han, La società della stanchezza, Milano, nottetempo, 2012; Id., L’espulsione dell’altro, ivi, 2017. Cfr anche M. Rastoin, «Ritrovare il senso del tempo. Riflessioni sul pensiero di Byung-Chul Han», in Civ. Catt. 2019 I 32-41.
[12]. Cfr F. Berardi, «Cronaca della psicodeflazione», in Nero Editions, 16 marzo 2020.
[13]. Cfr J. Butler, «Il capitalismo è giunto al suo limite», in Dinamo Press, 20 marzo 2020.
[14]. Cfr D. Harvey, «Anti-Capitalist Politics in the Time of Covid-19», in Jacobin Magazine, 20 marzo 2020.
[15]. Cfr A. Badiou, «Sulla situazione epidemica», in Filosofia in movimento, 23 marzo 2020.
[16]. Cfr A. V. Banerjee – E. Duflo, Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global, Barcelona, Taurus, 2014; T. Piketty, Il capitale nel XXI secolo, Milano, Bompiani, 2016.
[17]. Cfr G. Markus, «El orden mundial previo al virus era letal», in El País, 25 marzo 2020.
[18]. Qui possiamo citare ancora Camus: «Voi dunque, medici della peste, vi dovete fortificare contro l’idea della morte e riconciliarvi con essa, prima di entrare nel regno che la peste gli prepara. Se siete vincitori su questo punto, lo sarete sempre e vi si vedrà sorridere nel mezzo del terrore. Concludete che avete bisogno di essere filosofi» («L’irruzione dell’assurdo», cit.).
[19]. Cfr Y. N. Harari, «Il mondo dopo il virus», in Internazionale, 6 aprile 2020.
[20]. Cfr Id., «In the Battle Against Coronavirus, Humanity Lacks Leadership», in Time, 15 marzo 2020.
[21]. Cfr J. Gray, «Adiós globalización, empieza un mundo nuevo. O por qué esta crisis es un punto de inflexión en la historia», in El País, 12 aprile 2020.
[22]. Cfr D. Grossman, «Un mismo tejido humano infeccioso», ivi, 12 aprile 2020.
[23]. Cfr H. T. Have, Vulnerability: challenging bioethics, New York, Routledge, 2016. Sul tema cfr anche D. Fares, «I paradossi della vulnerabilità», in Civ. Catt. 2018 II 533-545.
[24]. Cfr R. Zibechi, «A las puertas de un nuevo orden mundial», in El Salto, 25 marzo 2020; M. Galindo, «Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir», in Radio Deseo, marzo 2020.
[25]. Cfr P. B. Preciado, «Aprendiendo del virus», in El País, 28 marzo 2020.