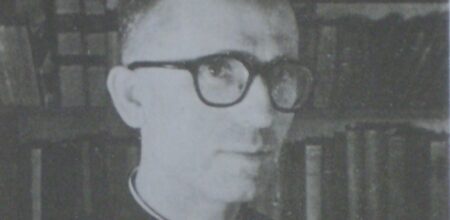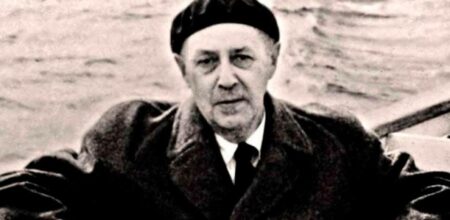|
|
Questo volume intende rispondere ad alcuni quesiti che ruotano attorno alla reazione della società italiana nei confronti delle persecuzioni antiebraiche: se la maggioranza dei nostri connazionali le abbia approvate, osteggiate o accolte con sostanziale indifferenza; se tali comportamenti siano cambiati nel momento degli arresti e delle deportazioni che ebbero luogo a partire dall’ottobre del 1943; se la gran parte di quanti vissero quegli avvenimenti abbia continuato a conservarne il ricordo, e come, eventualmente, sia mutata la loro memoria della Shoah. Tutte questioni ancora aperte, che Valeria Galimi, ricercatrice di Storia contemporanea all’Università di Milano, analizza lucidamente, prendendo le mosse dal dibattito storiografico, che negli ultimi decenni è stato arricchito da numerosi contributi e che ha messo esplicitamente in discussione la rassicurante immagine del «bravo italiano», il quale, stando a uno stereotipo assai diffuso tanto nel nostro Paese quanto all’estero, sarebbe stato sostanzialmente immune dal razzismo.
Ciononostante, molte ricostruzioni generali della Shoah continuano a riservare all’Italia un ruolo marginale, mentre si deve osservare come, ancora oggi, il mito dell’italiano salvatore o comunque buon vicino della minoranza israelita sia tutt’altro che venuto meno.
Di fronte a una situazione del genere, secondo l’autrice, si pone la necessità di studiare più a fondo – nonché in un lasso di tempo più lungo – i rapporti tra ebrei e non ebrei, iniziando dal periodo in cui il regime fascista approvò le leggi razziali per passare poi ad analizzare alcuni «momenti» del rapporto tra società italiana e persecuzioni antisemite.
Il primo momento preso in esame nel libro è il 1938, l’anno che vide il varo della legislazione antisemita. La questione è arrivare a stabilire quale sia stato, in quel periodo, il giudizio prevalente al riguardo nell’ambito della maggioranza non ebraica. Dalla disamina effettuata emerge che in una prima fase, fino al 1940, gli italiani hanno valutato le conseguenze di quei provvedimenti con grande attenzione, cercando però, talora, di approfittarne. In seguito, probabilmente a causa dell’accesa propaganda che riuscì a dispiegare i suoi effetti soprattutto durante la guerra, la maggioranza della popolazione sembra aver assunto posizioni antisemite più marcate. Un atteggiamento, quindi, assai lontano da quell’indifferenza che le è stata a lungo attribuita.
A proposito poi della maniera in cui gli italiani valutarono gli arresti e le deportazioni che colpirono gli israeliti, l’A. cerca di andare oltre l’ormai tradizionale distinzione tra «vittime», «carnefici» e «spettatori», concentrandosi sia sui rapporti tra ebrei e non ebrei che si andavano instaurando dagli anni Trenta allo scoppio del conflitto mondiale – e si sarebbero rivelati decisivi nel determinare in seguito la sorte dei perseguitati –, sia sulla pluralità degli attori che, da una parte, contribuirono al buon funzionamento della macchina dello sterminio e, dall’altra, vissero e agirono insieme agli ebrei nell’ambito delle comunità locali. Questo consente all’autrice di precisare meglio il significato di alcune categorie, come quelle di «giusto» e di «delatore».
Riguardo infine al tema del «ricordo» relativo alla Shoah, la studiosa esamina con grande attenzione la ricezione del processo Eichmann che, nell’Italia del 1961, contribuì non poco alla conoscenza dell’argomento e alla relativa riflessione, sebbene abbia svolto un ruolo determinante nella creazione del «mito del bravo italiano».
VALERIA GALIMI
Sotto gli occhi di tutti. La società italiana e le persecuzioni contro gli ebrei
Firenze, Le Monnier, 2018, VI-202, € 14,00.