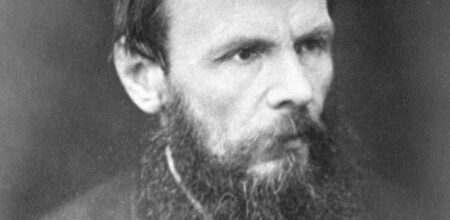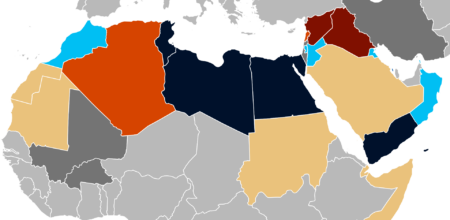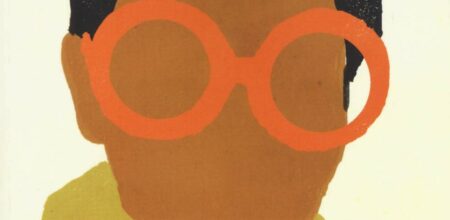|
|
Romano Guardini iniziò a interessarsi della poesia di Rainer Maria Rilke fin dalla metà degli anni Trenta: ne fece argomento di due corsi universitari (nel 1948 a Tubinga e nel 1949 a Monaco di Baviera) e poi di un lavoro editoriale che vide la luce nel 1953. Ora, grazie al volume XXIV dell’edizione dell’Opera Omnia del teologo italo-tedesco, possiamo rileggere integralmente la sua lunga disamina di un poeta che, se da una parte lo attirava per la sua capacità di sondare gli abissi dell’animo umano, dall’altra lo respingeva per il suo scetticismo religioso.
Come nota Lucia Mor, curatrice del volume, l’autore annotava, alla fine del lavoro di correzione delle bozze, che «Rilke è un poeta né veramente grande né schietto» (p. 36). Il che sembrerebbe contraddire la notevole attenzione che l’autore mostrava verso il poeta. Per capirlo, bisogna riandare a un episodio accaduto durante il primo dei due corsi di Guardini sullo scrittore praghese: alcuni studenti avevano contestato l’interpretazione che egli dava di Rilke, «viziata» dalla visione cattolica della sua fede, che diveniva, secondo loro, una lettura di parte. Il teologo rispose che in ogni lettura critica entra la visione complessiva del mondo dell’autore, compresa la fede, e che anche naturalismo e positivismo avevano decretato la fine della spiritualità attraverso un’interpretazione di parte e angusta, quella materialistica. In effetti, nonostante la visione cristiano-cattolica, e nonostante le sue stesse «resistenze» di credente, il teologo scende nelle profondità più abissali dei 10 libri che formano le Elegie duinesi, scritte tra il 1912 e il 1922.
È vero ciò che afferma Guardini, ma spesso egli si fida troppo delle confessioni dirette del poeta, come quando, in alcune lettere, questi dichiara il suo distacco, e talvolta l’ostilità, verso il cristianesimo. L’arte, in questo caso la poesia, non è solo trascrizione del lato conscio dell’essere, ma qualcosa che viene da altre dimensioni, che talvolta prendono il sopravvento. Anche perché Guardini stesso mostra di esserne consapevole, quando afferma, ad esempio, che «il sogno può rivelare connessioni che la vita vigile non conosce, e forse non vuole neppure conoscere» (p. 110).
Il percorso critico di Guardini è in ogni caso affascinante: in particolare, la sua tesi che l’amore, per Rilke, come per i trovatori provenzali del XII secolo, non era il possesso dell’amata, di cui anzi è necessaria l’assenza.
Un altro tema profondo che l’autore coglie nella Quinta Elegia è quello degli acrobati del circo, che con le loro «arti così insensate» (p. 257) rappresentano non soltanto la fascinazione di un momento, ma anche una scelta di diversità e di autenticità rispetto a una vita fatta di ripetizioni e di distacco dal rapporto con Dio, che, secondo Guardini, è il vero male della cultura moderna. Una dimensione che riemerge, nel simbolismo della poesia, con l’accenno al Giardino perduto, «ricordo d’esserci stati una volta nel Paradiso terrestre» (p. 363): una presenza molto forte in Rilke, come in un altro autore caro al teologo italo-tedesco, Hӧlderlin.
In definitiva, Guardini, nel suo cammino attraverso la poetica di Rilke, vuole dimostrare che le parole della poesia sono importanti, come anche il percorso umano degli autori, ma che il grande scrittore riesce a trovare il raggio divino che illumina ogni cosa e dà senso a ogni cosa. Quello che Guardini rimprovera al poeta tedesco è proprio quel suo lasciarsi irretire dal fascino delle sue stesse parole, fino a dimenticare il vero senso della vita. Questo l’insegnamento più importante del libro: le parole della poesia, se consapevoli del dono divino della vita, possono rappresentare la riscoperta del vero senso della vita.
ROMANO GUARDINI
Rainer Maria Rilke
a cura di LUCIA MOR
Brescia, Morcelliana, 2020, 688, € 50,00.