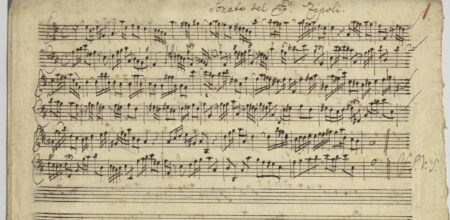|
|
Il libro contiene una meditazione profonda sulle ultime parole di Gesù, un tema che è stato ampiamente trattato nella predicazione e nella letteratura religiosa e che ha assunto una forma definitiva nel XII secolo. Conservate in modo diverso dagli evangelisti, le ultime parole di Gesù sono state oggetto di riflessione da parte dei Padri della Chiesa e messe in ordine dalla pietà medievale.
L’autore si è attenuto all’ordine tradizionale, già documentato nella Vita Christi di Ludolfo di Sassonia e seguito da san Bonaventura, da san Bernardino da Siena e dai grandi compositori musicali. Ultimamente è stato affermato che non si conosce quale sia l’ordine storico in cui Gesù ha pronunciato quelle parole, in quanto i racconti evangelici differiscono tra loro; tuttavia il modo in cui esse sono state sistemate dalla devozione medievale ha un senso, perché esprime una dinamica rivelativa unitaria.
Dopo il Prologo, in cui si espongono alcune considerazioni metodologiche, l’autore dedica a ciascuna delle frasi di Gesù un intero capitolo del libro, il cui percorso risulta così costituito da sette tappe, modulate secondo l’ordine ricevuto dalla tradizione: 1) «Padre, perdona loro …» (Lc 23,34); 2) «Oggi sarai con me in paradiso» (Lc 23,43); 3) «Ecco tuo figlio… Ecco tua madre» (Gv 19,26-27); 4) «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46; Mc 15,34); 5) «Ho sete» (Gv 19,28); 6) «È compiuto» (Gv 19,30); 7) «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46).
Nel corso della meditazione, l’autore afferma che queste frasi hanno il valore di un sigillo conclusivo della vita e della predicazione di Gesù e il significato di un’ultima rivelazione: «Queste parole, consegnate sul ciglio del silenzio, acquisiscono la forza di una parola testamentaria, di un lascito estremo, gravido di senso, perché in qualche modo riassumono e compendiano una vita, affidandone il distillato a coloro che sanno farsi prossimi, con l’orecchio e con il cuore» (p. 16).
Ampiamente commentate dalla tradizione della Chiesa, queste brevi frasi, o «parole», a volte sommesse altre volte gridate, sono come delle «luci nella notte», cioè una sorgente di senso all’interno del contesto di sofferenza, incomprensibilità e insensatezza della passione del Figlio di Dio, ma anche di quella di ogni persona umana.
Il libro è interessante soprattutto per la prospettiva ermeneutica seguita nell’interpretazione delle parole di Gesù. L’autore ha utilizzato i contributi dell’esegesi biblica, le riflessioni dei Padri della Chiesa e anche le suggestioni delle composizioni musicali, ma li ha integrati con le considerazioni della letteratura e della poesia, aprendo così un orizzonte di senso in cui la dimensione antropologica si coniuga con la rivelazione divina e permette di raggiungere il cuore filiale di Cristo.
Tra altro, l’autore fa notare che la prima e l’ultima delle sette parole si rivolgono direttamente al Padre e manifestano la relazione filiale che ha fondato la vita di Cristo, il suo insegnamento e le sue azioni. La prima è una parola di intercessione per il perdono, mentre l’ultima è di affidamento e di consegna di se stesso; entrambe sono parole di intimità e di amore: «Il perdono è come uno specchio, nel quale possiamo riconoscere il nostro volto, vedere il male che abbiamo fatto, misurarne la portata che sempre supera la nostra immaginazione» (p. 49), ma nello stesso tempo anche riconoscere il volto misericordioso del Padre.
Al centro delle sette parole, che formano un settenario che ricorda i giorni della creazione e le braccia del candelabro ebraico, Borsotti illustra il significato della quarta parola, costituita dal grido altissimo e umanissimo di Gesù, ripetuto due volte. Citando il racconto della prigionia di B. Keenan, le riflessioni poetiche di Ch. Bobin e le domande di E. Jabès, l’autore ritiene che la domanda sul «perché» sia profondamente umana, che possa incontrare anche il silenzio della risposta, ma che, in quanto domanda, è già manifestazione di senso e orientamento alla trascendenza: «Quel “perché” urlato è il grido di un’umanità derelitta e schiacciata, e – insieme – l’ululato di una disumanità eretta a sistema» (p. 132).
Le ultime parole di Gesù in croce, rilette alla luce della letteratura e della poesia contemporanee, manifestano una nuova dimensione di senso, anche se, come ricorda l’autore nell’Epilogo, in realtà esse non sono le ultime parole di Gesù, perché saranno seguite da quelle della risurrezione, che annunceranno la pace e la gioia.
EMANUELE BORSOTTI
Nudità della Parola. Le sette parole di Gesù in croce
Magnano (Bi), Qiqajon, 2018, 258, € 24,00.