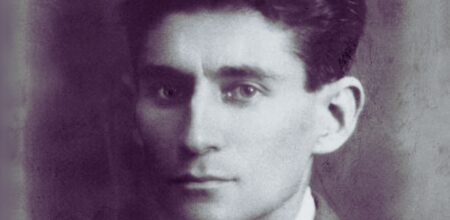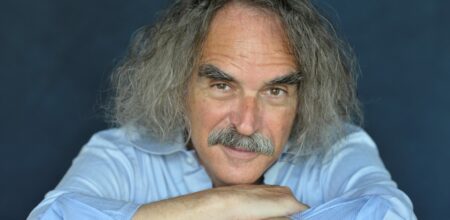|
|
L’incanto di questa storia e delle sue illustrazioni non è impallidito da 43 anni a questa parte. La ragione per cui Sendak mette d’accordo tutti – editori encomiabili che lo ristampano in continuazione, lettori vecchi e nuovi – non sta solo nell’esuberante bellezza delle sue tavole, ma nello squisito talento di narratore e nella sublime economia di mezzi espressivi, soprattutto linguistici, molto ben resi in italiano dalla traduttrice Lisa Topi. Non un tratto, non una parola sono mai di troppo o fuori posto: l’americano di stirpe ebreo-polacca Maurice Sendak (1928-2012) è un vero Flaubert dell’illustrazione.
Si passano minuti con gli occhi incollati a una sola tavola – non c’è riproduzione digitale che tenga, è indispensabile il libro di carta –, magari con solo una o due frasi di narrazione; si resiste al girare la pagina, ma ecco che, appena compiutamente assorbiamo testo e immagini, si dispiega la vista di un mondo fantastico e umbratile, si risvegliano nostre emozioni sopite, memorie latenti, paure riposte. È un libro-grimaldello, come i migliori libri di fiabe; e come ogni classico – ce lo ricorda Harold Bloom –, i libri di Sendak possono essere letti e goduti dai cinque anni in su, fino alla fine della vita.
La fiaba comincia con un’assenza, quella del padre, lontano sul mare; la madre, sprofondata in una melanconica inerzia, è una vaga presenza tutelare. C’è una distrazione fatale di Ida, la ragazzetta grande di casa, e in quel vuoto irrompono i folletti, che rapiscono la sorellina, mettendo al suo posto un changeling di ghiaccio! Non diremo altro degli eventi che seguono, se non che la caccia ai malfattori si innesca con «un grave errore», che è poi lo scardinamento di ogni coordinata spazio-temporale, cristallizzato dall’A. con un suo tipico florilegio linguistico-immaginifico: Ida «saltò dalla finestra lanciandosi all’indietro nel mondo là fuori».
La danza di incantesimi a seguire ha elementi circensi, ginnici e musicali, una coreografia di magia bianca e magia nera, che dà vita a una gioiosa battaglia per ristabilire l’elementare ordine del mondo, così che gli incubi vengano ricacciati al loro posto e i piani malefici dei folletti siano sventati. Prevalgono fantasmagoria e gioco, ma la battaglia tra il bene e il male rimane una cosa seria.
Come l’A. sapeva sparigliare sull’asse narrativo, così i suoi personaggi non sono eroi in miniatura, figurine confortanti di buone virtù, vittime da salvare: sono invece creature umanissime, e i loro cimenti scaturiscono da errori commessi, da debolezze, distrazioni e incaponimenti. Solo il capitombolo e la deviazione dalla retta via aprono la soglia del fantastico, e solo con la grazia del cuore e della mente si esorcizzano i mostri, ci si allea con loro, si superano le prove del fuoco, facendo ritorno a una casa ancora più dolce, ancora più sicura. Si pensi a Max, il bambino cocciuto e tirannico dell’altro capolavoro di Sendak, e alla menagerie di creature alate, zannute e artigliate di Where the Wild Things are.
E la ricerca di Ida ha bisogno di aiuto, per strappare ai terribili goblin la sorellina destinata a diventarne sposa-bambina; dal mare giunge, in improbabile ma determinante soccorso, la voce paterna, una voce di amore, di incoraggiamento e di indispensabili consigli: «Se la mia Ida, sotto la pioggia, potesse girarsi una buona volta, con il suo corno stregherebbe il demonio, guastando la festa di matrimonio» e rendendo innocui i maligni folletti, che si fonderebbero «in una marea danzante».
E dopo il salvataggio miracoloso e il rituale ritorno a casa, Ida cresce con nuova forza e accortezza, maturata nel ruolo che le è proprio, quello di protettrice di mamma e sorella, e il lettore è certo che non ci saranno più distrazioni: il male è almeno temporaneamente bandito da quel giardino, e quelle creature maliziose e demoniache che vogliono intrufolarsi tra noi non scorderanno tanto presto la lezione. La Ida di Sendak è un’alleata di tutti i bambini, la paladina di tutti noi.