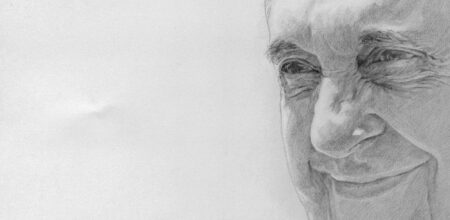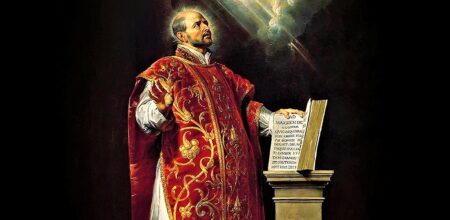|
|
Il volume presenta una rigorosa riflessione filosofica sui fondamenti dell’etica delle relazioni umane e ambientali, definite «oggettuali» e comprese alla luce dei contributi dell’idealismo hegeliano, della fenomenologia husserliana e della psicanalisi relazionale. L’autore ha elaborato in precedenti pubblicazioni i fondamenti metafisici e antropologici dell’etica delle relazioni; in questo libro sviluppa alcuni temi di fondo, come malvagità e bontà, invidia e gratitudine, accoglienza e respingimento, distruzione e riparazione, che confermano la necessità della riflessione etica e ne dimostrano l’attualità.
Il punto di partenza della sua riflessione è che «il mondo mi appare. Ossia: il mondo appare a me» (p. 13). L’attenzione è posta sull’oggettività del reale, visto però in relazione al soggetto che ne fa esperienza. L’autore riconosce che l’idealismo hegeliano ha rappresentato un momento di svolta nella problematica moderna del rapporto tra soggetto e oggetto e che il suo sviluppo nell’attualismo gentiliano ha espresso due verità fondamentali: il rapporto del pensiero con la realtà, e il pensiero come attività dell’Io, mentre la sua deriva nell’idealismo magico di Julius Evola lo ha estremizzato e vanificato.
Pur mettendo l’attenzione sull’Io come possibilità infinita di pensiero, l’autore prende le distanze dall’idealismo: «L’Io di cui parla l’idealismo, specie all’interno del suo ripensamento attualistico, è quel soggetto che pensando produce la realtà, ossia il mondo oggettuale nel suo complesso; l’Io di cui qui si vuol parlare è invece quel soggetto che pensando testimonia la realtà, ossia il mondo oggettuale nella sua verità» (p. 27). Il mondo appare quindi a un «Io» che lo accoglie, lo comprende e lo testimonia, e il pensiero diventa accoglienza e riconoscimento prima del mondo che appare e poi della presenza di un «altro-Io», anch’egli dotato della capacità di pensare e di relazionarsi con rispetto e accoglienza.
La relazione che costituisce la persona umana risulta così basata sul riconoscimento dell’altro-Io come persona che mi appare, mi riconosce e mi accoglie. L’autore afferma che «il lato migliore della fenomenologia novecentesca ha enormemente contribuito a restituire all’esperienza dell’altro-Io il titolo di evidenza che di diritto le compete» (p. 51).
Bettineschi sviluppa poi una riflessione sulla non-neutralità del mondo e sull’esperienza del bene e del male, che fondano la presenza nella persona umana del desiderio e del respingimento. Proprio la presenza del desiderio, quando non è sacralizzata dall’affermazione che esso ha sempre ragione, ma è accompagnata dalla ricerca del bene, costituisce il momento della riflessione etica, intesa come aiuto al desiderio per il meglio.
In tale prospettiva, l’Io e l’altro-Io sono costituiti da pensiero e da desiderio potenzialmente all’infinito, si distinguono dalle cose e pertanto si oppongono alla loro reificazione. Nel passaggio dall’etica personale a quella sociale, l’autore introduce il concetto del «Noi», in cui l’Io e l’altro-Io si riconoscono in un gruppo sociale costituito da una rete di relazioni e da nodi che lo strutturano nell’insieme.
Interessanti sono le riflessioni dell’autore sulla definizione classica di giustizia di Domizio Ulpiano: «dare a ciascuno il suo», in cui si richiedono il riconoscimento del diritto naturale e positivo e la limitazione dell’invidia e dell’avidità, che generano aggressività e ingiustizia. L’autore sostiene che «è necessario che la stessa soggettività sappia giudicare di quel che appare o si manifesta, restando fedele all’apparire o alla manifestazione con cui volta a volta ha effettivamente a che fare» (p. 151).
Sull’apparire dell’oggetto e dell’altro-Io l’autore elabora una riflessione che distingue tra ciò che va accolto e ciò che deve essere respinto, tra ciò che vuole distruggere e ciò che vuole costruire. L’intenzionalità, che guida la conoscenza verso l’essenza di ciò che appare, ritorna qui e permette di distinguere tra l’odio che distrugge, che va rifiutato, e l’amore che costruisce, che è la forma più elevata dell’accoglienza: «Riparare è il modo più forte dell’accogliere» (p. 199). La concezione della filosofia morale come riflessione sull’intenzione del desiderio, al fine di aiutarlo a orientarsi al vero bene, costituisce il nucleo centrale e l’aspetto più significativo di questo percorso.
PAOLO BETTINESCHI
L’oggetto buono dell’Io. Etica e filosofia delle relazioni oggettuali
Brescia, Morcelliana, 2018, 256, € 22,00.