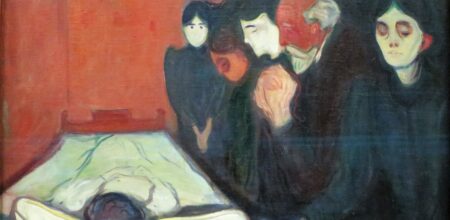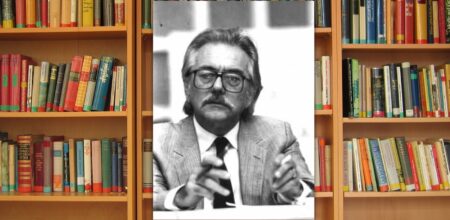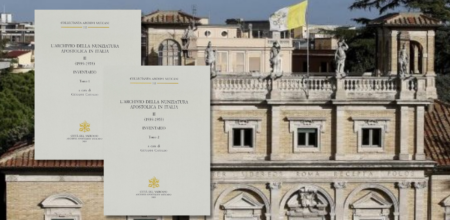|
|
Quattro donne hanno segnato in modo indelebile il Novecento: non solo loro, certamente, perché molte altre sono state protagoniste della battaglia contro il male e l’indifferenza, ma il filosofo Wolfram Eilenberger ha scelto Ayn Rand, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt e Simone Weil per questo suo libro.
Il perché ci viene suggerito fin dal sottotitolo, che parla del «pensiero della libertà», ossia dalla tragica storia in cui guerra e pace, libertà e asservimento ideologico, amore e odio hanno attraversato il Novecento, a partire dalla presa del potere del nazismo fino a quell’agosto del 1943, che vede lo spegnersi di Simone Weil in un sanatorio inglese «a causa delle alterate condizioni mentali». Come aggiunge lo scarno certificato medico: «La paziente rifiutava il cibo» (pag. 318).
Paradossalmente, anche se l’autore non ne parla, quella morte per condizioni fisiche dettate anche dal rifiuto del cibo ricorda da vicino quella di alcuni «perfetti» fra i catari, che si lasciavano morire di inedia o di malattia per abbandonare il mondo della carne e del male.
In realtà, le protagoniste di questo libro fanno i conti con il mostro che ai catari avrebbe fatto pensare alla stagione finale dell’umanità, all’incarnazione di un male assoluto, che nel Novecento è divenuto più laicamente «male di vivere», «non senso».
Solo che per Simone de Beauvoir si trattava di un ostinato, apparentemente inspiegabile sacrificio supremo per l’altro, per chi non ha nulla, per chi muore di fame o di violenza. Una solidarietà estrema che gli altri sono tentati di spiegare con la parola «suicidio».
In ogni caso, tutte e quattro le protagoniste del libro hanno in comune questa capacità di non fermarsi alla superficie della storia, ma di andare molto più in là. Così, dopo aver parlato dell’estrema solidarietà umana di Weil, l’autore mette in luce la volontà di Arendt di sondare le cause del male – in questo caso dell’antisemitismo –, affrontando la banalità «impiegatizia» di quel male; l’interrogarsi sull’esistenza dell’altro, del desiderio oltre le regole e dell’accadere in de Beauvoir; la riscoperta e l’esaltazione dell’io contro tutto e tutti, e soprattutto contro i totalitarismi, di Rand.
Come si vede, tutte e quattro le protagoniste sono di fronte all’enigma di una libertà che però può portare alla sazietà e alla noia, come verrà approfondito dall’esistenzialismo della coppia de Beauvoir-Sartre; alla violenza folle e meschina, nel caso di Arendt; all’anonimato e al conformismo massificato, come temuto da Rand; o all’abisso che separa chi si annoia da chi muore letteralmente di fame, e quest’ultima è la questione che allontanerà per sempre le strade di de Beauvoir e di Weil.
Il libro di Eilenberger consente al lettore di conoscere un personaggio, Ayn Rand, da noi poco noto, ma che negli Usa ha avuto un ampio seguito, influenzando il pensiero economico di Alan Greenspan, presidente della Federal Reserve dal 1987 al 2006, del Tea Party Movement e riscuotendo la simpatia dei presidenti conservatori, Trump incluso.
E anche qui notiamo come cause di partenza, arrivo e uso strategico di un pensiero spesso prendano strane derive. Rand infatti aveva alle spalle la drammatica situazione della Rivoluzione d’ottobre, della rovina economica della propria famiglia, proprietaria di una farmacia, e delle notizie dei massacri che arrivavano dall’Urss di Stalin e dai territori occupati da Hitler: i socialismi, compreso quello nazionale germanico, i comunismi e anche le religioni venivano visti come il trionfo della moltitudine inarticolata, dei molti irragionevoli contro i pochi pensanti e coraggiosi, come nel caso del protagonista del suo romanzo La fonte meravigliosa.
Si tratta, in definitiva, di quattro donne che hanno avuto il coraggio di andare controcorrente, anche rinunciando al benessere e, nel caso di Weil, alla vita stessa.
WOLFRAM EILENBERGER
Le visionarie. 1933-1943. Arendt, de Beauvoir, Rand, Weil
e il pensiero della libertà
Milano, Feltrinelli, 2021, 352, € 22,00.