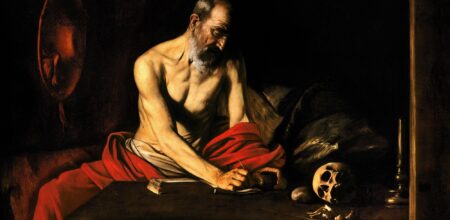|
|
Le «sette parole di Gesù in croce» sono note, elaborate teologicamente e perfino musicate. Invece le parole di Maria, cioè le espressioni da lei pronunciate nei Vangeli, non pare abbiano avuto la stessa eco nella tradizione cristiana. Se si contano, sono «sei», un numero simbolico, quasi un’imperfezione che precede e prepara il «sette». Il «sei» così risulta adatto a Maria, che è colei che dà la vita a Gesù, l’umano che genera il divino.
Eppure le sei parole di Maria non solo hanno ciascuna una propria rilevanza in quanto pronunciate in momenti emblematici della sua vita, ma anche – ed è ciò che risulta dal commento che ne fa l’autrice – tracciano «un itinerario di vocazione e di vita cristiana» (p. 16). Francesca Cocchini, ordinario di Storia del cristianesimo alla «Sapienza» di Roma, applica per l’interpretazione il metodo esegetico già usato dagli stessi agiografi e presente nella tradizione ermeneutica ebraico-cristiana, particolarmente teorizzato da Origene e ripreso da Agostino, secondo cui «la Scrittura si interpreta con la Scrittura» (p. 16). I frutti sono straordinari.
Letto in funzione di un percorso unitario, l’itinerario può essere quello di ogni vocazione cristiana che esige una risposta, un riconoscimento comunitario; presenta anche momenti di crisi; si applica alla relazione con Dio e con il mondo. L’esegesi che ne segue mette in evidenza il rapporto tra il prologo del quarto Vangelo (dove il Logos venne «tra le sue proprie cose [eis ta idia]», Gv 1,11) e le parole di Gesù a Giovanni sulla croce: «“Ecco la tua madre”. E da quell’ora il discepolo la prese con sé (eis ta idia)» (Gv 19,27). Ne deriva che l’itinerario di Maria può essere applicato a ogni credente: accogliendo la madre, si diventa un altro Giovanni, cioè «un discepolo amato». Il credente, chiamato a conformarsi a Cristo, deve accogliere anche sua madre: così diventa figlio di Maria e figlio di Dio.
Nell’Annunciazione viene riportata la prima parola di Maria: l’angelo Gabriele le rivela il «mistero della storia» (cfr Dn 9,21-22), che si deve accogliere, perché esige una risposta. Lei replica: «Come sarà questo? Io non conosco uomo» (Lc 1,34). Di fronte all’impossibile del mistero della storia, Maria vuole conoscere il «come» dell’agire di Dio. L’angelo risponde: «Lo Spirito scenderà su di te […]. Non c’è alcuna parola impossibile per il Signore» (cfr Gen 18,14). Ognuno di noi fa parte del progetto di Dio e deve cercare quale sia la storia che il Signore gli chiede di realizzare.
La seconda parola è il fiat, che indica il compimento del suo desiderio, ma insieme rinvia al fiat della Genesi, il comando che crea. Maria annuncia «il momento in cui l’umanità […] ha potere sulla storia, e ha l’efficacia del comando, […] perché è abitata dallo Spirito, che vive la misericordia e che ha lo stesso desiderio che Dio manifesta con la sua volontà, in ordine alla costruzione del corpo di Cristo» (p. 46).
La visita a Elisabetta e il saluto «Beata colei che ha creduto» confermano Maria «madre del […] Signore» (Lc 1,43). Di qui la gioia del Magnificat. Nell’interpretazione di Origene, Ambrogio e Leone Magno, la vocazione cristiana non si vive solo nell’intimità con Dio, ma anche nella relazione con i fratelli nella storia.
Una pagina originale riguarda il rimprovero di Maria a Gesù ritrovato fra i dottori nel Tempio, dopo «tre giorni». C’è una perdita che provoca angoscia, dolore, e un ritrovamento che avviene «dopo tre giorni»: «Perché ci hai fatto questo?» (Lc 2,48). È il buio di Maria. Si potrebbe ampliare la domanda: perché il male? Perché il dolore? Perché la morte? Dio non ha creato il male e la morte, ma, una volta che essi sono entrati nel mondo, vuole redimerli. È il valore della Pasqua: «Non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 2,49). Maria non capisce, ma conserva quelle parole nel suo cuore.
Alle nozze di Cana, c’è l’intercessione della madre. La vocazione del credente è quella di parlare a Dio degli uomini, e Maria lo fa intercedendo per gli sposi: «Non hanno vino!» (Gv 2,3). Nella Bibbia il vino è il segno dello Spirito Santo. Maria, ricolma dello Spirito, è sensibile alla sua presenza.
L’ultima parola è rivolta ai servi: «Fate quello che vi dirà» (Gv 2,5). È una parola che rinvia alla storia di Giuseppe in Egitto (cfr Gen 41,55). Questa volta è il parlare di Dio agli uomini. Maria è sicura che Gesù «dirà». Gli ricorda quanto lui le aveva detto a 12 anni: deve occuparsi delle cose del Padre.
Conclude il volume «La comunione al calice»: l’autrice nota che lo Spirito Santo è strettamente unito alla menzione del «sangue», cioè alla vita donata di Gesù per la remissione dei peccati. Nell’Eucaristia si riceve il dono del Figlio e dello Spirito; perciò la comunione senza il sangue «tradisce la volontà espressa dal Signore» (p. 110).
FRANCESCA COCCHINI
Le sei parole di Maria
Bologna, EDB, 2020, 116, € 14,00.