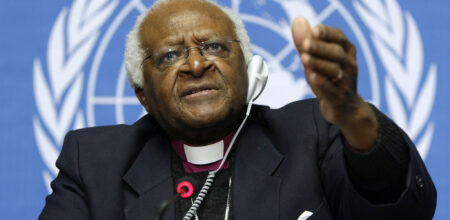|
|
Com’è cominciata la vita? Perché non provare a crearla in laboratorio? Chi furono davvero i nostri antenati? È un libro pieno di domande questo di Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri», uno dei maggiori rappresentanti della ricerca in Italia.
Le nuove tecniche di estrazione, sequenziamento e manipolazione del Dna consentono oggi di capire molto del nostro passato e del nostro presente, offrendo prospettive per alcuni versi inimmaginabili (e talvolta inquietanti). Con l’entusiasmo del ricercatore e la passione del divulgatore, l’autore ci accompagna attraverso gli sviluppi più recenti e affascinanti della scienza moderna, che negli ultimi anni stanno rivoluzionando la conoscenza dell’uomo, della sua storia e del mondo.
Il primo capitolo è dedicato all’origine della vita: dall’ipotesi di una «combinazione superfortuita di reazioni chimiche innescate dal caso» a quella di una serie di «eventi fisico-chimici, capaci di integrarsi con fenomeni biologici che rispondono ai dettami dell’evoluzione». Ma, si domanda l’autore, chi avrà governato questo processo? «Certo è che dal caso alla complessità non si arriva senza un processo definito». Per spiegare come si sia arrivati alla vita a partire da materiale inanimato, si ipotizza «una driving force», una spinta che orienta i sistemi biologici a replicarsi fino a raggiungere un sempre maggiore grado di stabilità. Ma questo processo risulta alla fine unquantifiable, non calcolabile o ricostruibile attraverso modelli matematici: troppe sono le variabili in gioco, e del tutto imprevedibili. «Riuscire a quantificare il processo che ha portato alla vita è quindi ancora un mistero. O potrebbe essere semplicemente fuori dalla nostra portata».
I capitoli successivi sono dedicati ai nostri antenati di Neanderthal e ai loro geni, le loro «impronte», che a distanza di decine di migliaia di anni, in modo sorprendente, grazie alle ripetute migrazioni del passato, sono arrivate fino a noi e continuano a influenzare nel bene e nel male il nostro sistema immunitario, finanche la sua capacità di reagire o meno alla pandemia di questi anni. «Da Neanderthal abbiamo preso geni capaci di difenderci da batteri e virus che l’Homo Sapiens non aveva mai incontrato prima», ma «abbiamo ereditato anche la predisposizione al diabete attraverso geni che prevengono la degradazione dei grassi che a Neanderthal servivano per difendersi da temperature troppo basse che a noi oggi proprio non servono». Insomma, il sistema immunitario ci condanna e ci protegge allo stesso modo, servendosi di geni che arrivano dalla notte dei tempi.
Sono tanti gli argomenti e gli spunti interessanti di questo libro, che indaga anche le origini della nostra creatività – «Cosa c’è nel nostro cervello che ci fa essere curiosi?». La curiosità «è solo nostra e di nessun altro animale» –, della nostra socievolezza, della nostra aggressività, perfino della nostra predisposizione alla corruzione («Se il cervello è disonesto»), fino alle grandi potenzialità offerte dalla genetica nella cura delle malattie (le cellule staminali e la terapia genica).
Ma forse uno degli aspetti più interessanti di questo libro, che è scritto da un autore dichiaratamente laico e con posizioni non di rado discutibili, è la ricerca, anzi, la proposta di un nuovo dialogo, di una nuova alleanza tra scienza e fede («le due forze intellettuali più potenti del Pianeta»), tra gli scienziati e la Chiesa. Non nascondendo nulla dei motivi di contrasto e di disaccordo, Remuzzi riconosce che la Chiesa «ha fatto più di chiunque altro» per la salute e l’assistenza dei più poveri, e vede nell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco un grande riferimento sulla strada di questo nuovo dialogo tra scienza e religione, caratterizzato dall’allarme condiviso per l’ambiente e dalla comune capacità di «analizzare il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose».
GIUSEPPE REMUZZI
Le impronte del signor Neanderthal.
Come la scienza ricostruisce il passato e disegna il futuro
Milano, Solferino, 2021, 256, € 17,00.