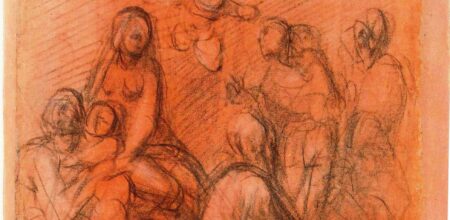|
|
Quest’opera non si deve considerare una mera scrittura odeporica, sebbene l’autore, Nikos Kazantzakis (1883-1957), scrittore, poeta e uomo politico greco, abbia ben incarnato la figura dell’itinerante: Ulisse resta un’amata sua fissazione mentale. Inoltre, il lettore non deve ritenere che il titolo dica in verità quanto si snoda fra le pagine, perché la Grecia altro non è che il Peloponneso, questa «acropoli ancestrale di tutta la Grecia» (p. 110), il regno del mare, quasi a pareggiare l’impero della luce incarnata dall’Attica. E il Peloponneso, altrimenti detto «Morea», come suona il titolo originale del libro, va a fermarsi, stagliandosi alla fine nella «spaventosa porta con le due leonesse ritte all’entrata: Clitemnestra ed Elettra» (p. 142).
Ma a questa finale, tragica scena del viaggio Kazantzakis genialmente accosta e contrappone, a guisa di antico esorcismo, «la dolce e semplice vita del villaggio, fatta di cose reali, le pannocchie, il cotone, le lumache» (p. 143). Questo a dire che il geniale intuito dell’autore, in una ben acquisita tecnica di contrappunto narrativo, lascia che la vita quotidiana del 1937 – anno del viaggio commissionato dal giornale Kathimerini e che diventa fonte di ispirazione per la tragedia Melissa – sorregga il peso di una tragica eredità, il pesante fardello della classicità che la nuova Grecia ha il dovere di trasmettere.
Una galleria, una sequenza di scenari classici e medievali, volutamente intrisi di respiro quotidiano, si snoda da Corinto a Micene nel settembre del 1937. Si visitano così i siti e le fortezze, le città franche – troneggia la figura di Goffredo di Villehardouin, che tanto amò Glarentza, la sua città – e Olimpia e Sparta, sensuale e feroce, sia pure sempre sotto il vigile controllo del terribile Taigesto.
Di altra luce si riempiono le pagine dedicate a Mistrà, «questo sacro colle dove è nata la Nuova Grecia» (p. 99). In questa città tardo-bizantina – come pure a Monemvasia – Kazantzakis vede i personaggi affrescati bizantini mostrare i primi fremiti e sorrisi dopo il tempo truce e spaventoso. Ancora lì l’A. osserva – tale è il desiderio di identificazione nel richiamare il personaggio – fra le pietre della città Giorgio Gemisto Pletone, «questo grande anticipatore del rinascimento greco» (p. 113) e, specchiandosi in lui, trova quiete per la sua anima ribelle, spazi lungimiranti per la sua libertà.
Micene è la città in cui si conclude il suo tour, e Kazantzakis distilla nelle ultime pagine il suo pensiero, i suoi desiderata – quanto provocanti e ironici! – nel foggiare una cultura neogreca. In questa ponderata miscela di antico e di nuovo si gusta il magistrale gioco dell’ironia nella narrativa dell’autore: il mito o l’antico monumento, il mitico personaggio o una Natività affrescata, pregni di pesante responsabilità culturale, sono controbilanciati dal gruppo dei bambini che giocano nel paese, dalla vecchia custode di una chiesa medievale, dalla succosa degustazione di una anguria nel meriggio, dal sarcasmo innocente di un tassista a Micene.
Il libro risponde alla sua natura letteraria, rendendosi avvincente, stimolante e sempre provocante, rispettando così la creatività poliedrica del suo autore. Pur se in esile formato, La mia Grecia intensificava la denuncia e la sfida di un mondo antico a una civiltà nuova che arrancava, e ancora oggi arranca dolorosamente, in un appiattimento culturale pericoloso.
NIKOS KAZANTZAKIS
La mia Grecia
Milano, Crocetti, 2021, 160, € 16,00.