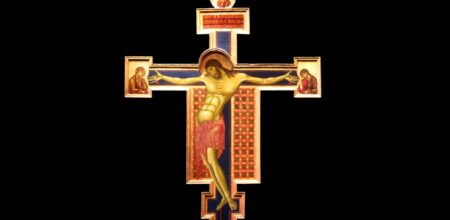|
|
Verso il 415 Girolamo iniziò a commentare il profeta Geremia. In precedenza aveva commentato tutti gli altri profeti, i dodici minori e i tre grandi (Daniele, Isaia ed Ezechiele). Mancava solo Geremia. Ma nel 416 una banda di fanatici, forse sostenitori di Pelagio, avversato da Girolamo, assalì il monastero di Betlemme appiccandovi un incendio. Girolamo si salvò a malapena, ma non si riprese più da quell’evento traumatico. La sua attività si ridusse, e così il commento a Geremia rimase incompleto (fino al c. 32), anche perché lo studioso si spense nel 419.
Secondo il suo solito, Girolamo riporta il testo di Geremia nella sua personale traduzione latina dall’ebraico e, se necessario, cita anche la traduzione dei Settanta o quella degli altri antichi traduttori greci (Aquila, Simmaco e Teodozione).
Aggiunge poi il suo commento, che è in genere molto sobrio e «assume spesso la forma di una semplice parafrasi del testo biblico» (15). Se il passo richiede una spiegazione storica o letterale, basata sui termini ebraici, essa viene esposta, ma in modo molto rapido; altrimenti si passa subito all’interpretazione spirituale, chiamata spesso «anagogia», applicata a Cristo e alla Chiesa.
Non mancano spunti di carattere allegorico, anche se Girolamo è contrario all’uso esagerato di questo tipo di esegesi.
Tra i brani commentati rientra pure il famoso passo di Ger 31,31-34 che annuncia una «nuova alleanza».
L’importanza di questo testo è dovuta non solo al fatto che esso è citato integralmente dalla lettera agli Ebrei (8,8-12), ma soprattutto perché Gesù, nell’istituire l’Eucaristia, parla del sangue della «nuova alleanza» (1 Cor 11,25; Lc 22,20).
Da tempo siamo abituati a questa espressione, ma all’epoca di Girolamo non era così, perché il termine usato era testamentum. Ora, «testamento» non è «alleanza». Basandosi sulla sua conoscenza dell’ebraico, Girolamo spiega così la sua novità: «Abbiamo tradotto [il termine berîth] con pactum (patto) al posto di testamentum, conformemente al genuino testo ebraico, sebbene anche il testamento venga chiamato ben a ragione patto, perché in esso è contenuta la volontà e la dichiarazione solenne di coloro che stringono un patto» (pp. 470-473, con traduzione ritoccata).
Notiamo che qui Girolamo usa pactum (patto) e non foedus (alleanza), anche se i termini sono sinonimi. Tuttavia l’uso di testamentum era allora così tradizionale che Girolamo non riesce a distaccarsene, tanto è vero che nella sua traduzione di Ger 31,31-34 scrive pactum – sive testamentum per ben quattro volte.
Inoltre, nel suo commento, usa insieme i due termini: «Nel Vangelo, dopo la croce, la risurrezione e l’ascensione, promette di concedere un patto (pactum) non in tavole di pietra, ma nelle tavole di carne del cuore, e che quando il testamento (testamentum) del Signore sarà scritto nella mente dei credenti, egli sarà il loro Dio ed essi saranno il suo popolo» (p. 473, con traduzione ritoccata e integrata).
Il presente volume si inserisce nell’edizione latino-italiana delle Opere di Girolamo, in corso di pubblicazione. «Esigenze editoriali hanno imposto di pubblicare il testo contenuto nella Patrologia Latina [vol. 24]; tuttavia questo è stato ampiamente corretto facendo uso dell’edizione di Reiter [Corpus Scriptorm Ecclesiasticorm Latinorum, vol. 59], a partire dalla quale è stata approntata la traduzione» (p. 25).
In un’eccellente introduzione, Giuseppe Caruso mette in luce il contesto storico del Commento, la prassi esegetica seguita in esso e gli elementi di controversia antipelagiana affioranti in tutta l’opera. Non mancano, sotto la penna del mordace polemista, anche spunti critici contro la dottrina origeniana della preesistenza delle anime (cfr pp. 290; 308; 400; 414) e contro i millenaristi (cfr pp. 296; 434; 448). Girolamo ha suddiviso il suo commento in sei libri, dedicandoli al suo amico Eusebio, monaco e presbitero cremonese.
GIROLAMO
Commento a Geremia
a cura di GIUSEPPE CARUSO
Roma, Città Nuova, 2021, 536, € 80,00.