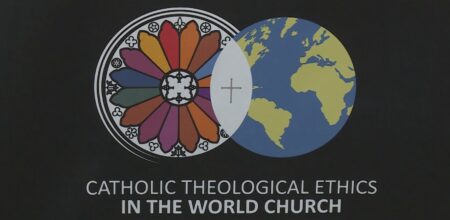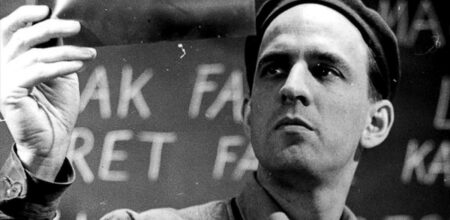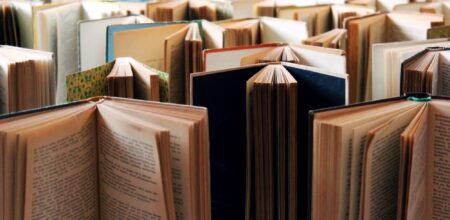|
|
A cinquant’anni dalla pubblicazione della Humanae vitae, l’enciclica di Paolo VI sulla procreazione, il teologo Martin M. Lintner, docente presso lo Studio Teologico Accademico di Bressanone, propone una minuziosa ricostruzione storica delle riflessioni che condussero alla redazione finale, scandendole nelle diverse fasi genetiche.
Si inizia con la Commissione pontificia per lo studio della popolazione, famiglia e natalità, che venne istituita da Giovanni XXIII nel 1963 (poi allargata nel ’64 a tre coppie di coniugi e cinque donne). Si prosegue con la complessa vicenda della nuova Commissione di vescovi, nominata da Paolo VI nel 1966 e incaricata di esaminare la relazione finale della Commissione pontificia, cui si era aggiunto un Rapporto da parte della minoranza. Anche la Commissione episcopale espresse pareri divergenti, che Paolo VI ricevette, ma sui quali non si pronunciò. Vengono infine delineate le intense discussioni in seno al Concilio Vaticano II (cfr Gaudium et spes, nn. 47-52), che superò sia la visione funzionalistica e biologistica della sessualità, sia la nozione di matrimonio come contratto, parlando di comunità d’amore personale tra uomo e donna, il cui donarsi reciproco pervade tutta quanta la loro vita. L’autore tratta quindi della redazione e della pubblicazione dell’Humanae vitae, «frutto di un dibattersi duro e drammatico, alla ricerca delle giuste soluzioni per questioni così delicate» (p. 86).
Il testo di Lintner analizza inoltre i momenti più significativi della controversa ricezione di un pronunciamento magisteriale, identificato troppo spesso e semplicisticamente con la condanna della contraccezione artificiale (la cosiddetta «enciclica della pillola»). Il lavoro di assimilazione del solenne messaggio coinvolse voci successive: anzitutto, la lettura personalistica di Giovanni Paolo II, che aveva esercitato un ruolo molto attivo, da teologo e cardinale (anche attraverso il Memorandum di Cracovia, fatto pervenire a Paolo VI nel 1968), e che, pur sostenendo fermamente l’enciclica, cercò di integrarne i fondamenti biblico-antropologici; i prudenti riferimenti di Benedetto XVI a un testo autorevole e assieme «difficile» (p. 118); le relazioni finali dei Sinodi dei vescovi del 2014 e 2015; e infine l’invito di papa Francesco – contenuto nell’esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia (2016) – a riscoprire il messaggio dell’enciclica, che sottolinea il bisogno di rispettare la dignità della persona nella valutazione morale dei metodi di regolazione della natalità.
La costante apertura generativa della vita sponsale, la responsabilità parentale, la consapevolezza che non ogni atto coniugale può generare una nuova vita, la valorizzazione della coscienza della coppia in merito alle proprie condizioni, ai sentimenti e alle concrete problematiche esistenziali costituiscono i criteri per un valido discernimento etico. Papa Francesco non manca di incoraggiare il ricorso a metodi basati sui ritmi naturali di fecondità, di cui ricorda gli effetti positivi sui coniugi e su tutta la società. Nelle moderne società del benessere la sessualità non deve venire mercificata, né il corpo può essere oggettivato quale substrato materiale di ricerche biomediche o di sperimentazioni tecniche.
Poi l’autore riassume ed esamina le forme argomentative adottate nella strutturazione logica dell’enciclica: il riferimento alla tradizione e all’autorità; la tesi giusnaturalistica dell’unità di amore e procreazione nell’atto sessuale; l’interpretazione di tale atto quale espressione di dedizione reciproca dei partner e quale simbolo di apertura alla vita nascente; l’assioma scolastico della sovranità di Dio sulla vita dell’uomo, e quindi del dovere di conformarsi alla volontà del Creatore.
Per quanto preziosi e meditati fossero quegli strumenti concettuali, essi – a giudizio di vari commentatori – si adattarono faticosamente alla novità delle questioni tecniche e al fermento teorico che animava il dibattito teologico e che determinò negli anni Settanta il sorgere persino di una disciplina specifica, la bioetica.
Riprendendo il pensiero del teologo E. Schockenhoff, Lintner ritiene legittimo domandarsi se l’insegnamento ecclesiale potrebbe svilupparsi verso una posizione per cui il matrimonio come tale – e non necessariamente ogni singolo atto coniugale – debba essere aperto alla generazione dei figli (cfr p. 148). Nel contempo sarebbe da rafforzare tanto l’immagine conciliare della coscienza come voce (e quindi luogo di dialogo tra uomo e Dio) che chiama incondizionatamente ad amare, quanto la responsabilità decisionale dei coniugi, rettamente formati e consigliati, quali cooperatori del Dio creatore e redentore.
Riscoprire l’annuncio custodito nell’Humanae vitae – come recita il sottotitolo del libro di Lintner – significa proseguire uno studio critico dei rapporti tra norma e libertà, tra potenzialità biologiche, novità tecniche e vissuti coscienziali. Significa altresì cercare un linguaggio nuovo, che parli della bellezza del diventare madre o padre e che consenta, all’interno delle comunità cristiane, un’educazione permanente all’amore coniugale. La saggezza del discernimento si avvarrà di una paziente ermeneutica del desiderio dei fedeli, nell’ascolto della loro meditate motivazioni decisionali, attraverso cioè la mediazione pratica, culturale e storica delle valutazioni etiche e delle formulazioni dottrinali.
MARTIN M. LINTNER
Cinquant’anni di «Humanae Vitae». Fine di un conflitto riscoperta di un messaggio
Brescia, Queriniana, 2018, 176, € 14,00.