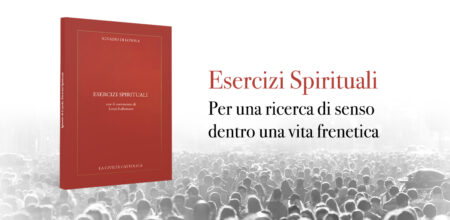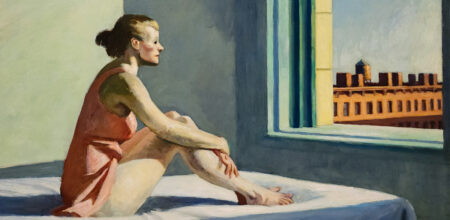Mercoledì 7 maggio inizierà un nuovo conclave, l’antica istituzione della Chiesa nata quasi mille anni fa per garantire la libertà dei cardinali-elettori da ogni ingerenza esterna nella scelta del Papa. Dopo la Messa pro eligendo Pontifice, che sarà celebrata al mattino e presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, e i giuramenti del primo pomeriggio, si rinnoverà una tradizione che — come scriveva Giovanni Sale su La Civiltà Cattolica nel 2013 — si fonda su «segretezza, libertà e sollecitudine per la Chiesa».
Il termine conclave, che significa «luogo chiuso», designa l’assemblea dei cardinali riuniti per eleggere il nuovo Pontefice.
Sorprende che l’istituzione del Conclave sia sopravvissuta, quasi inalterata nei suoi tratti principali, all’usura del tempo e soprattutto ai frequenti sconvolgimenti della storia moderna. Nel XX secolo il conclave ha assunto una caratterizzazione ancora più marcata nei suoi elementi più antichi, come quello della «segregazione» e della «segretezza».
Nel primo millennio del cristianesimo il vescovo di Roma era eletto «dal clero e dal popolo romano». Tuttavia, con l’aumentare del prestigio e del potere del Papato, questa forma di elezione si prestò a essere sfruttata dai potentati locali per imporre uomini a essi favorevoli. Furono gli imperatori tedeschi, in particolare gli Ottoni, a sottrarre l’elezione del Papa ai giochi di potere dei diversi partiti romani, richiedendo come condizione di validità dell’elezione del nuovo Pontefice la «conferma» dell’eletto da parte dell’imperatore.
Fu il papa riformatore Nicolò II a fissare, nel 1059 con il decreto In nomine Domini, una nuova procedura per l’elezione del Pontefice. Egli stabilì che tale compito spettasse soltanto ai cardinali, quali «parte del mantello» del Papa, suoi «senatori» e collaboratori nel governo della Chiesa universale, nonché, secondo la teologia del tempo, eredi e continuatori degli Apostoli.
La costituzione Ubi periculum del 1274, promulgata da Gregorio X durante il II Concilio di Lione, fissò le regole sulla nuova disciplina conclavista. Si affermò il principio che il potere di eleggere il Papa spetta esclusivamente ai cardinali; si impose come sede naturale per l’elezione il luogo in cui il Papa è morto; si fissò un limite massimo (10 giorni) per celebrare il lutto per il Pontefice defunto e dare inizio al «conclave». Tale parola, che presto indicherà l’intero procedimento elettivo, appare per la prima volta espressa in questo importante documento pontificio.
A partire da quel momento, l’elemento della segregazione, insieme a quello della segretezza, ha rappresentato il cardine del procedimento di elezione del vescovo di Roma. Il divieto di comunicare con l’esterno era nato per costringere gli elettori «a fare in fretta», per non lasciare a lungo la Chiesa senza il suo capo, e anche per evitare il pericolo che i cardinali approfittassero della sede vacante per cumulare benefici.
In età contemporanea, invece, il segreto ha lo scopo principale di assicurare la piena libertà dei cardinali-elettori nell’esercizio della loro funzione; per cui essi, entrando in conclave, non soltanto vengono «separati» dal mondo esterno — in modo che le grandi potenze cattoliche e non cattoliche non attentino alla libertà dell’elezione (sebbene ad esse fosse riservato un generico potere di veto) —, ma si impegnano con giuramento a non rivelare nulla di quanto accade in sede elettorale.
La disciplina sulla segretezza del conclave fu resa più severa da Pio X nella costituzione Vacante sede apostolica del 1904; in particolare si fece divieto ai cardinali, sotto pena di scomunica, di farsi latori in sede di conclave di istanze provenienti dal potere secolare. In quell’occasione, l’arcivescovo di Cracovia, card. Jan Puzyna, aveva portato in conclave il veto dell’imperatore d’Austria nei confronti del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, ritenuto eccessivamente filofrancese e quindi non gradito alla corte asburgica.
Ad ogni modo, le nuove riforme sul conclave operate dai Papi del secolo scorso hanno contribuito a conferire un’aura di sacralità all’elezione del Papa, cosicché il «segreto», come indicato nelle nuove costituzioni apostoliche, in realtà espone i cardinali elettori alla curiosità, troppo spesso invadente e imbarazzante, dei media, che nel contesto odierno potrebbero perfino attentare alla libertà dell’elezione. Caso emblematico è quello che si è verificato nel conclave del 1978 dopo la morte di Paolo VI, quando un giornale pubblicò, prima che i cardinali entrassero nel segreto della Cappella Sistina, un’intervista rilasciata giorni prima dal cardinale Giuseppe Siri (e che avrebbe dovuto essere pubblicata soltanto a conclave avviato), che compromise i consensi raccolti intorno all’arcivescovo di Genova.
La segregazione in conclave e la segretezza sono elementi che ci giungono dalla tradizione, e anche oggi si rivelano utili e irrinunciabili per assicurare la libertà dell’elezione del Papa.