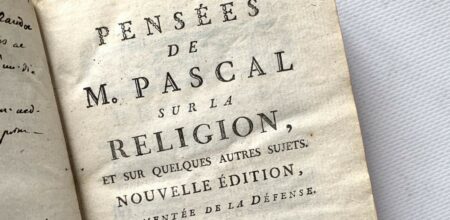|
|
Cinque passi per trasformare il cammino verso Dio
Giobbe, nel pieno della sua battaglia interiore, sopraffatto dalla sofferenza e dallo scoraggiamento, si domanda se in una condizione come quella in cui si trova abbia senso continuare a vivere. Sta attraversando una disintegrazione personale, al punto che gli cresce dentro, sempre più forte, una lacerazione primordiale: «Perisca il giorno in cui nacqui» (Gb 3,3), afferma duramente. E si chiede con evidente amarezza: «Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo?» (3,11).
Giobbe mette in discussione il fatto stesso della sua esistenza, scaglia verso Dio una domanda che in definitiva è retorica, ricorrente in chi soffre. Più ancora, nel corso dei 42 capitoli del libro, si arrabbia con Dio, disputa con lui, lo attacca. Ma anche tace, ascolta, si lascia toccare dalla sua parola, permette al Signore di correggerlo. Insomma, percorre un cammino personale che lo conduce fino a trasformare la relazione di fiducia con Dio che aveva perduto. E in quel percorso non si risparmia le difficoltà che s’incontrano quando si procede avvolti nella nebbia del dolore.
Perciò in questo libro troviamo l’esperienza di un uomo che ci attesta come la sofferenza non sia inevitabilmente condannata a trasformarsi in un ponte minato che, crollando, rende impossibile il viaggio verso Dio.
Anche oggi siamo testimoni delle tante grida che gli esseri umani continuano a rivolgere a Dio dal profondo del loro dolore[1]. Pertanto, rispettosi della complessità insita nel libro di Giobbe, proporremo qui alcuni passi utili al ministero pastorale – e accessibili ai non specialisti –, nell’intento di aiutare a riconfigurare le relazioni con il divino che il dolore ha ferito. Infatti crediamo, con gli occhi della fede, che il nostro è un Dio che non abbandona l’essere umano, ma piuttosto gli risponde quando lui lo chiama e lo ascolta quando lui è nell’afflizione.
Si tratta di semplici piste, che tracciano un possibile cammino di incontro con Dio nelle concrete circostanze in cui molti esseri umani possono trovarsi a vivere la loro esperienza spirituale di relazione con il Signore.
Questi passi non seguono un percorso del tutto lineare, perché a volte si renderanno necessari anche qualche deviazione e qualche cambio di passo. Ma si spera che aiutino a riorientare il cammino e a far comprendere che buona parte di ciò che la sofferenza genera nell’intimo «è normale» e non dà motivo di allontanarsi irrimediabilmente da Dio.
Intraprendiamo questo cammino con l’autore del libro, il quale, concependo Giobbe come un personaggio non israelita – «Viveva nella terra di Us un uomo chiamato Giobbe» (1,1), si dice all’inizio del libro –, ci consente di correre qualche rischio teologico per affrontare la sofferenza in tutta la sua crudezza. Infatti, giungendo ai limiti della bestemmia, «Giobbe pronuncia molte affermazioni ardite e certamente non molto ortodosse, alle quali probabilmente soggiacciono importanti quesiti teologici»[2].
Primo passo: accettare che c’è angoscia
Giobbe è talmente angosciato che non solo maledice il giorno in cui è nato – «Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno» (3,1) –, ma dilata la sua sofferenza fino a una dimensione cosmica: «Quel giorno divenga tenebra, non se ne curi Dio dall’alto, né brilli mai su di esso la luce» (3,4); «Si oscurino le stelle della sua alba, aspetti la luce e non venga né veda le palpebre dell’aurora» (3,9).
Espone quindi non soltanto la propria lacerazione interiore, ma anche il dubbio che nel cosmo, inteso come un tutto, non esista alcun senso. Questo dolore è così grande che supera l’esistenza concreta, perché «Giobbe vive la sua sofferenza come un abbandono da parte di Dio»[3].
Così come tante volte accade nel ministero pastorale, il testo presenta la sofferenza di Giobbe – soprattutto nel capitolo 6 – come schiacciante, indescrivibile: «Se ben si pesasse la mia angoscia e sulla stessa bilancia si ponesse la mia sventura, certo sarebbe più pesante della sabbia del mare! Per questo le mie parole sono così avventate» (6,2-3). Giobbe vive con grande angoscia la situazione che lo perseguita. E, d’altra parte, non ha coscienza di essere stato negligente o di aver fatto qualcosa di male.
Ed è appunto per questo che i discorsi dei suoi amici, aggiungendosi all’apparente silenzio di Dio, lo fanno arrabbiare e all’inizio spingono quanto di buono c’è in lui in un vicolo cieco. Infatti, per costoro le risposte – e la conoscenza – a partire dalle quali questa situazione di sofferenza va compresa e affrontata devono essere trovate nella tradizione degli antenati.
E tuttavia per Giobbe l’esperienza concreta che sta attraversando non combacia affatto con la cornice proposta da tale tradizione. Elifaz, Bildad e Sofar sembrano insensibili alla sofferenza dell’amico. Per 22 capitoli (dal 4 al 25) essi fanno dipendere quasi per intero la salvezza dal riconoscimento di un presunto peccato.
E qualcosa di assai simile accade anche per i quattro discorsi che compongono l’intervento di Eliu (capitoli 32–37). Come rileva Gustavo Gutiérrez, «Giobbe ha anche quel riferimento teorico, ma la sua esperienza e la sua fede in Dio finiscono per fare a brandelli quella teologia. La consapevolezza della sua integrità non si accorda con essa. Giobbe comincia a intravedere un cammino, un metodo, per parlare di Dio»[4].
Tuttavia Giobbe, per quanto all’inizio faccia fatica a esternarlo, a partire da un certo momento appare ormai preparato ed è capace di riconoscere la sua angoscia e la sua devastazione: «Ma io non terrò chiusa la mia bocca, parlerò nell’angoscia del mio spirito, mi lamenterò nell’amarezza del mio cuore!» (7,11). Quante persone in questo stesso momento staranno provando, in silenzio, la prostrazione, la paura, l’angoscia o la solitudine? Quante staranno piangendo di nascosto, annegando in un inesprimibile vortice di impotenza, tristezza e desolazione? Quante di esse conosciamo? Quante altre non riusciamo nemmeno a immaginare? Quanti, come Giobbe, gridano tragicamente affinché si ponga fine alla loro angoscia e, una buona volta, possano avere pace?
«Così, ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo» (3,13), desidera Giobbe. E «non ho tranquillità, non ho requie, non ho riposo ed è venuto il tormento!» (3,26), finisce per riconoscere.
Secondo passo: permettersi di arrabbiarsi
«Se fosse capitato di pensare che [la reazione di Giobbe] sia improntata a una mera rassegnazione, il processo che Giobbe segue mostrerà che non è così. L’incontro pieno con il suo Dio passa attraverso il lamento, la perplessità e il confronto»[5].
Fin dal primo intervento di Elifaz (capitoli 4–5), Giobbe comincia a dolersi del fatto che le risposte dei tre amici non gli sono affatto di aiuto, perché essi non lo ascoltano: «I miei fratelli sono incostanti come un torrente, come l’alveo dei torrenti che scompaiono» (6,15). E alla fine del primo ciclo di dialoghi (capitoli 12–14), la sua indignazione nei loro confronti è palese, scatenata dalla falsa sapienza che essi manifestano nei suoi confronti.
E, sebbene all’inizio l’entrata in scena di Eliu sembri promettente, anche con lui succede qualcosa di simile. I rapporti tra Eliu e Giobbe si fanno tesi, come ci viene raccontato all’inizio del capitolo 32: «Allora si accese lo sdegno di Eliu, figlio di Barachele, il Buzita, della tribù di Ram. Si accese di sdegno contro Giobbe, perché si considerava giusto di fronte a Dio» (32,2).
In questo senso, afferma Gutiérrez: «Eliu la mette sul personale e si rivolge in tono di sfida a Giobbe chiamandolo varie volte per nome. Nel farlo, mostra una certa arroganza, è molto sicuro delle proprie idee. Non tiene conto né della situazione di Giobbe né delle sue sofferenze; non ne coglie affatto nemmeno la dura esperienza, né gli angosciati interrogativi; la preoccupazione di Eliu va per un’altra strada e obbedisce ad altre motivazioni: difendere quella che considera la dottrina corretta»[6].
Giobbe biasima i suoi amici. E maledice non soltanto il giorno in cui è nato, ma il cosmo intero. Inoltre – diversamente da ciò che accadeva nel capitolo 3 – comincia ad attaccare duramente e direttamente Dio, a contestarlo, a interrogarlo, a dargli la colpa di ciò che, secondo lui, gli sta facendo passare: «Io sono stanco della mia vita! Darò libero sfogo al mio lamento, parlerò nell’amarezza del mio cuore» (10,1).
Nulla, nei discorsi dei tre compagni, ha indotto Giobbe a cambiare il suo punto di vista. Per lui, Dio è l’autore della sua sofferenza: «Chi non sa, fra tutti costoro, che la mano del Signore ha fatto questo?» (12,9). Se Giobbe soffre, non è perché Dio sia sparito, ma perché gli sta addosso con esasperata ingiustizia: «È forse bene per te opprimermi, disprezzare l’opera delle tue mani e favorire i progetti dei malvagi?» (10,3).
Pertanto, per Giobbe Dio non è il giudice giusto, il consolatore degli afflitti: è piuttosto un aggressore, che «toglie la ragione ai capi di un paese e li fa vagare nel vuoto, senza strade» (12,24). In sostanza, Dio usa la sua forza e il suo potere distruttivo contro l’essere umano: «Non condannarmi! Fammi sapere di che cosa mi accusi» (10,2).
Oppresso da questa situazione, Giobbe non esita a gridare tutta la sua rabbia, la sua indignazione. Infatti sembra in qualche modo attendersi che Dio si renda presente e gli spieghi il senso di tutta quella sofferenza. Tuttavia, la bestemmia di Giobbe qui non è un ostacolo alla ricerca del volto del Signore, bensì è il filo che mantiene la relazione di Giobbe con il divino e che più avanti gli consentirà di rivolgersi a Dio in maniera nuova e trasformata.
Quindi, quando irrompe il dolore, non è proibito prendersela con Dio. Infatti l’ira – che presuppone sempre il previo riconoscimento di una relazione – si può trasformare nel catalizzatore che mette in moto un incontro genuino con il volto del Signore. Fatto sta che «nella Bibbia il lamento non esclude la speranza. Più ancora, essi vanno assieme»[7]. Di fatto, «il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato» (42,12).
Terzo passo: fare spazio al silenzio
La linea temporale della vita di Giobbe entra in crisi nel momento presente, quando la sua sofferenza si è trasformata in presenza che lo invade e lo inonda. Perciò l’avvicinarsi di Elifaz, sebbene benintenzionato, è di danno a Giobbe.
Il primo amico gli intima di riflettere sulla sua identità al di là della crisi in cui si trova; lo esorta a guardare a un passato di forza e di prosperità (cfr capitolo 4), che può dare un senso alla situazione presente (cfr capitolo 5) e fa un ricorso fiducioso a un futuro in cui Giobbe non soffrirà più come adesso (cfr capitolo 6).
Fa notare Carol Newsom: «Il programma terapeutico degli amici, specie così come lo espone Elifaz nel capitolo 5, cerca di rimediare al disordine imponendo alla vittima di partecipare a esercizi spirituali indirizzati a riorientarla verso la fiducia basilare nella natura della sua esistenza»[8].
Quindi la sua carenza – la stessa di Bildad e di Sofar – sta nel non concedere alla guarigione il tempo necessario. Inoltre, nessuno dei tre amici sembra comprendere la tremenda sofferenza attuale di Giobbe, anzi essi la accrescono, perché le loro affermazioni non sono centrate su ciò che lui sta soffrendo, bensì nel rispondere alle sue blasfemie.
Per esempio, Sofar dice per due volte: «Ho ascoltato un rimprovero per me offensivo, ma uno spirito, dal mio interno, mi spinge a replicare» (20,3); «A tante parole non si dovrà forse dare risposta? O il loquace dovrà avere ragione? I tuoi sproloqui faranno tacere la gente? Ti farai beffe, senza che alcuno ti svergogni?» (11,2-3).
Ma alla fine, nonostante l’angoscia che prova, Giobbe non si isola, né Dio gli rinfaccia – sebbene in vari momenti lo corregga – la sua irritazione. Infatti, resta vivo il desiderio autentico di stabilire una nuova relazione con il Signore. Perciò nei capitoli 38–41 è lo stesso Giobbe a darsi per vinto e a tacere, quando si rende conto che proprio la sua sofferenza – non il suo peccato, né il suo errore – gli ha fatto sfuggire qualcosa di importante: gli ha impedito di aprirsi alle desiderate parole di Dio, che all’essere umano parla in modo speciale nel suo dolore.
È per questo che, nel nostro ministero pastorale, affinché Dio possa parlare, dobbiamo innanzitutto aiutare le persone a fare silenzio tra i tanti rumori – dentro e fuori – da cui si sentono sommerse nel dolore. Eliu lo aveva già accennato nel suo primo discorso, sebbene con intenzioni diverse: «Ascolta dunque, Giobbe, i miei discorsi, porgi l’orecchio ad ogni mia parola» (33,1).
Nel nostro avvicinamento pastorale a chi soffre, il silenzio è necessario per scoprire chi è Dio e chi è, in effetti, ciascuno di noi; quali sono i nostri moventi e i nostri timori; che cosa ci spinge e che cosa paralizza la nostra motivazione; che cosa ci dà senso e come ci assale l’ansia; a che cosa aspiriamo e quali cose ci fanno soffrire.
Quarto passo: lasciarsi decentrare
Il libro di Giobbe a questo punto constata che Dio può raggiungere il credente anche nella difficoltà e nella desolazione. Ma in che modo possiamo aiutare una persona a disporsi ad accoglierne la rivelazione? Ignazio di Loyola, nella «meditazione sui peccati», al n. 58 dei suoi Esercizi spirituali (ES), propone una chiave che è in armonia spontanea con il testo di Giobbe.
Si nota che entrambi invitano, in un primo momento, a volgere lo sguardo su sé stessi per guardare chi ciascuno di noi è. Giobbe lo fa nei capitoli 29–31: lui – con il suo mondo – si pone al centro e fa sì che tutti gli altri – i vicini, i poveri – debbano collocarsi attorno a lui, ascoltando «la testimonianza con cui ha cercato di riabilitarsi agli occhi dei suoi compagni e della comunità in generale, una comunità che ha già tratto conclusioni provvisorie su di lui a partire dalla propria interpretazione del suo terribile destino»[9].
Ma né la proposta di Ignazio di Loyola né il discorso divino del libro di Giobbe (cfr capitoli 38–42), provocato dal protagonista nel capitolo 33, fanno sì che il soggetto si rinchiuda in sé, e nemmeno lo confinano nelle circostanze che attraversa, nei suoi condizionamenti o nella sua situazione.
Di fatto, in quei capitoli «Giobbe ha colto il senso del discorso divino. Anziché continuare a imporre a Dio la sua personale e ristretta concezione della giustizia, egli ora guarda il mondo e la sua stessa vita dalla prospettiva di Dio. Ha compreso che la giustizia divina non può essere misurata con gli angusti criteri della giustizia umana»[10].
Fino ad allora, «essendosi tanto rinchiuso in sé, così concentrato sulla propria vita, Giobbe non aveva compreso né come funziona la creazione né chi e come è la creatura per antonomasia: l’essere umano. Nei capitoli 38–42, grazie all’iniziativa di Dio, che lo prende per mano affinché intraprenda un viaggio decisivo, Giobbe trova il posto che occupa nel mondo (è creatura e non creatore), rinunciando alle pretese illusorie di conoscere tutta la creazione (solo il creatore ne ha le prerogative), e questo lo aiuta a riconciliarsi anche con la sua sofferenza»[11].
In altre parole, il credente scopre la sua identità profonda quando considera chi è Dio, cioè quando si decentra da sé e alza gli occhi verso il cosmo e verso il Signore. Questo è il modo per recuperare la relazione con Dio. E questo è, pertanto, il conforto divino che propone il libro di Giobbe, vale a dire che Dio si manifesta come il Signore di una creazione in cui è presente anche il male. Un Dio pieno di sapienza, onnipotenza, giustizia e, soprattutto, bontà.
Ciò implica che «il Dio che con tanto impegno Giobbe aveva cercato non è il Dio che lo perseguita e lo controlla, che gli scaglia frecce, che lo giudica in modo arbitrario e crudele, che lo sballotta con un potere travolgente, ma il Dio creatore, il Dio buono»[12].
O, in altre parole, che «il Signore risponde a Giobbe, sia pure in modo indiretto: lo sottrae al suo egocentrismo, alla profondità del suo io torturato, e gli fornisce una prospettiva più ampia, cosmica e creazionale, nella quale potrà soppesare più obiettivamente il proprio caso personale»[13].
In definitiva, la voce di Dio – all’interno della polifonia presente nel libro di Giobbe – conduce al decentramento sia dalla sapienza tradizionale sia rispetto a sé stessi. Giobbe è così incentrato su di sé e sulla sua rivendicazione, che arriva a condannare Dio. Per questo il Signore lo mette a confronto con l’insufficienza della sua immagine divina e lo spinge a espandere la sua teologia, affinché essa non sminuisca il Mistero di Dio.
Né Giobbe né alcuno di noi – e tantomeno le nostre motivazioni personali – è il centro del creato. Pertanto, l’essere umano sofferente, aprendosi a questo incontro con il divino – che è una relazione di cura e di amore – può pronunciare un’esclamazione di gratitudine davanti al conforto che riceve da parte del suo creatore.
Infatti, «allo stesso modo in cui il riconoscimento della struttura tragica dell’esistenza segnala i limiti dell’autosufficienza umana, per contro segnala la preziosità dell’essere, ma stavolta a mo’ di dono»[14].
Quinto passo: collaborare al compito della guarigione
In ultimo, il cammino spirituale che rende possibile la trasformazione della relazione di Giobbe con Dio lo porta a intercedere per i suoi amici presso il Signore: «Il mio servo Giobbe pregherà per voi» (42,8). Giobbe non tiene per sé il conforto ricevuto, ma ora, grazie al decentramento a cui Dio lo induce, è capace di trasmetterlo e di operare per la riconciliazione.
Scrive Enrique Sanz: «Anche questa è la grande verità di Giobbe, dello stesso e del nuovo Giobbe, che intercede per i suoi nemici (Bildad, Sofar, Elifaz) e prega per i suoi persecutori (cfr Mt 5,44; Lc 6,28); di colui che è reintegrato socialmente e genera vita, nonostante sia malato; di colui che agisce con gratuità, come Dio stesso, stabilendo come eredi le figlie e i figli (qualcosa di inedito in Israele, dove le figlie non ereditano quando i figli sono ancora in vita); di colui che riceve altresì con gratuità ciò che non aveva chiesto (figli, ricchezza, lunga vita). È Gb 42,7-17, l’epilogo del libro di Giobbe, a raccontare tutto ciò brevemente»[15].
Infatti, sebbene Dio offra più domande che risposte, il suo intervento smonta le difese e le barriere che Egli stesso aveva costruito a Giobbe. Afferma Víctor Morla: «Una palizzata divina di benedizioni e di prosperità proteggeva Giobbe. Poiché la palizzata era assai alta, al nostro eroe era assai difficile contemplare un altro tipo di realtà che pure abbondava dall’altra parte: povertà, disgrazie, morte…, il male, in definitiva. Ma per un satanico (e divino!) manrovescio, quella palizzata di sicurezza e di autocompiacimento crolla drammaticamente, e Giobbe si vede trascinato senza misericordia nella più crudele tempesta fisica e psicologica»[16].
In questo grande passo compiuto da Giobbe «non si trattava di negare la sofferenza personale, ma di aprirsi all’afflizione degli altri, impegnandosi a eliminarla»[17]. Sotto il profilo pastorale, riconosciamo qui un appello a prendersi cura di quanti si trovano nella necessità di incontro e di relazione, e a confortarli.
Un appello, questo, in definitiva alla giustizia: «L’intuizione del poeta continua a valere per noi: la gratuità dell’amore di Dio è la cornice in cui s’inscrive l’esigenza di praticare la giustizia […]. L’esigenza di operare la giustizia come una maniera di riconoscere Dio e di parlarne»[18].
Al di là del grido: trasformare la relazione con Dio
Sebbene Giobbe giunga al limite della bestemmia, la sua relazione con Dio – proprio per questo – non è mai scomparsa del tutto. Pertanto, il compito pastorale nel quale questo libro può spingerci non va tanto nella direzione di rifondare la relazione dell’individuo sofferente con Dio, quanto di trasformarla e di ricalibrarla in modo che possa crescere, facendo posto alla nuova esperienza vissuta.
Come osserva Gutiérrez, «il libro di Giobbe non cerca di trovare una spiegazione razionale e definitiva al problema della sofferenza»[19], ma piuttosto «lascia ai lettori di compiere una trasformazione spirituale, nel senso che cerchino di vedere la vita dalla prospettiva di Dio e non dalla loro»[20].
In termini simili si esprime Sanz quando dice che Giobbe afferma «che il male, il dolore non hanno una spiegazione, ma invece hanno un fine; che il male, il dolore non hanno una logica, ma hanno una maniera per superarli, un cammino per viverli con molta dignità»[21].
Infatti, a trasformare Giobbe non è una spiegazione, ma un incontro, l’incontro con Dio. In altre parole, «la relazione e l’incontro personale che Dio gli ha donato lo hanno del tutto cambiato, gli hanno fatto lasciare alle spalle il passato e lo hanno aperto a un nuovo futuro. Grazie a essi ha potuto riconoscere Dio e conoscere la sua verità, la coerenza della sua parola»[22].
Non si tratta di idee, ma di azioni. È l’azione che permette a Giobbe di uscire dalla sua sofferenza. Ebbene, questo è un messaggio con profonde implicazioni pastorali, perché annuncia che l’essere umano può fare qualcosa nelle situazioni di dolore, può far fronte alla sofferenza. E, più ancora, può aiutare anche altri a fare altrettanto.
L’essere umano sofferente può rivolgersi a Dio – anche con rabbia e gridando – e trasformare la sua relazione con Lui quando si riconosce come creatura davanti al suo Signore. È quanto giunge a dire Giobbe nel secondo ciclo di dialoghi con i suoi amici: «Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro» (19,27).
Nel pieno della sofferenza resta possibile riconfigurare la relazione con Dio, che si mantiene presente in mezzo al dolore, anche se non se ne trova il senso. In altri termini, Giobbe può percepire la completezza della sua vita nel momento stesso in cui si sente frantumato, poiché «i discorsi divini favoriscono un’altra lettura […] in cui si abbraccia la bontà della vita in tutta la sua fragilità»[23]. O, secondo un’altra formulazione, sentirsi frantumato è il modo concreto di Giobbe di essere completo.
Perché «letti in relazione dialogica, la sublimità dei discorsi divini e la bellezza dell’epilogo in prosa additano l’inserimento umano della tragedia nei potenti imperativi del desiderio: vivere e amare»[24]. E anche Giobbe è raggiunto da questa integrità o perfezione, perché è onesto con quanto gli accade; infatti, «man mano che la discussione procede, Giobbe prende coscienza del fatto che la linea di demarcazione tra lui e i suoi interlocutori si trova nel terreno dell’esperienza personale e nella riflessione che ne consegue.
Giobbe non ci vede chiaro, ma ha l’onestà e il coraggio di cercare. I suoi amici preferiscono ripetere i concetti che hanno appreso in un certo momento, anziché accostarsi alla vita concreta delle persone, porsi domande e aprirsi così a una migliore comprensione di Dio e della sua parola»[25].
Questo non vuol dire che la sofferenza non faccia male, che l’impotenza non ferisca o che la paura perda la sua capacità di turbare. Niente affatto. Piuttosto, implica che Dio possa emergere dalle profondità della sofferenza degli esseri umani come anelito, opportunità e dono.
Infatti, chi è capace di sentirsi bisognoso trova già dentro di sé la disposizione a riporre la sua fiducia nelle mani consolatrici di Dio. «Nell’impiegare in forma innovativa le risorse del linguaggio morale ereditato, Giobbe ha riabilitato efficacemente sé stesso»[26].
Tuttavia questo incontro non cancella le sofferenze che continuano a patire tanti esseri umani, sicché la relazione che essi ristabiliscono con Dio dovrà essere ora nuova e diversa. Perciò si può sperare che, nel nostro ministero pastorale, possiamo aiutare a far sì che la sofferenza e il dolore siano anche – come abitualmente lo sono la gioia e la salute – cammini aperti – e non soltanto minacce – che conducono all’incontro complesso, paradossale e polifonico con Dio.
Sta qui la sapienza (cfr Gb 28,12.20). «La lezione è chiara: soltanto nello svuotamento e nella tempesta, senza alcuna realtà che interferisca nell’incontro di Giobbe con il Signore, il nostro eroe è capace di lasciare che la luce filtri attraverso il groviglio mortale che lo torturava. Per questo Giobbe passa dall’accusa alla lode. Infatti l’esistenza è gratuità; non va vissuta nell’ottica mercantilistica della dottrina della retribuzione. L’uomo dev’essere religioso senza cercare ricompense. Qui inizia il cammino della sapienza religiosa»[27].
Copyright © La Civiltà Cattolica 2023
Riproduzione riservata
***
-
. L’esperienza degli operatori sanitari durante la pandemia di Covid-19 è un recente esempio di sofferenza umana e spirituale. Un approccio a questo fenomeno, anche attraverso la lettura del libro di Giobbe, si trova in A. Cano, «“¿Quién hará que se me escuche?”. El grito de los sanitarios a Dios», in Sal Terrae 109 (2021) 349-359. ↑
-
. E. Sanz, «Viajar y Reconocer: Dios, Job y los Discípulos de Emaús», in Sal Terrae 97 (2009) 900. ↑
-
. G. Gutiérrez, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, Salamanca, Sígueme, 1986, 41 (in it. Parlare di Dio a partire dalla sofferenza dell’innocente, Brescia, Queriniana, 1992). ↑
-
. Ivi, 62. ↑
-
. Ivi, 111. ↑
-
. Ivi, 98. ↑
-
. Ivi, 177. ↑
-
. C. A. Newsom, The Book of Job: A Contest of Moral Imaginations, New York, Oxford University Press, 2009, 127. ↑
-
. Ivi, 185. ↑
-
. D. Harrington, Why Do We Suffer? A Scriptural Approach to the Human Condition, Franklin, Sheed & Ward, 2000, 47. ↑
-
. E. Sanz, «Viajar y Reconocer, cit., 902. ↑
-
. E. Sanz, «Hablar, Escuchar y Contemplar: Job e Ignacio de Loyola», in J. García – S. Madrigal (edd.), Mil Gracias Derramando. Experiencia del Espíritu ayer y hoy, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2011, 114. ↑
-
. V. Morla, Job 1-28, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2007, 25. ↑
-
. C. A. Newsom, The Book of Job…, cit., 256. ↑
-
. E. Sanz, «Sufrimiento y Heridas en el Antiguo Testamento», in Sal Terrae 99 (2011) 220 s. I corsivi sono nell’originale. ↑
-
. V. Morla, Job 1-28, cit., 64 s. ↑
-
. G. Gutiérrez, Hablar de Dios, cit., 161. ↑
-
. Ivi, 162 s. ↑
-
. Ivi, 169. ↑
-
. D. Harrington, Why Do We Suffer?…, cit., 48. ↑
-
. E. Sanz, «Intercedió por sus Amigos. La Justicia en el Libro de Job», in Sal Terrae 102 (2014) 11. ↑
-
. Ivi. ↑
-
. C. A. Newsom, The Book of Job…, cit., 257. ↑
-
. Ivi, 258. ↑
-
. G. Gutiérrez, Hablar de Dios…, cit., 70. ↑
-
. C. A. Newsom, The Book of Job…, cit., 197. ↑
-
. V. Morla, Job 1-28, cit., 27. ↑