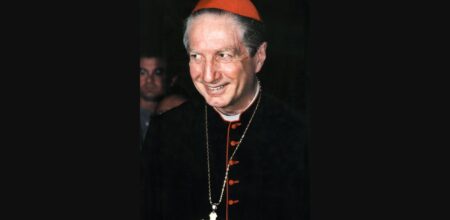|
|
A un anno dalla sua apertura, avvenuta a ottobre 2021, il Sinodo «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione» fa un deciso passo avanti, e anzi addirittura «raddoppia». All’ Angelus di domenica 16 ottobre, papa Francesco ha annunciato che «la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi si svolgerà in due momenti»[1]: alla sessione già prevista a ottobre 2023 se ne aggiunge una seconda a ottobre 2024. «Tale decisione – spiega la Segreteria generale del Sinodo – scaturisce dal desiderio che il tema della Chiesa sinodale, per la sua ampiezza e importanza, possa essere oggetto di un discernimento prolungato non solo da parte dei membri dell’Assemblea sinodale, ma di tutta la Chiesa. […] Pertanto, l’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi assumerà anch’essa una dimensione processuale, configurandosi come “un cammino nel cammino”, allo scopo di favorire una riflessione più matura per il maggior bene della Chiesa»[2].
La Chiesa è già in movimento verso quegli appuntamenti, e il cammino è entrato nella sua Tappa Continentale[3], una novità del Sinodo in corso: il 27 ottobre 2022, infatti, è stato ufficialmente presentato il Documento di lavoro per la Tappa Continentale (DTC), il cui titolo, «Allarga lo spazio della tua tenda», riprende un’espressione del libro di Isaia (54,2) che ne costituisce l’icona di riferimento. Alla presentazione di questo documento sono dedicate queste pagine[4].
Un grande amore per la Chiesa
Il DTC raccoglie i frutti del primo anno del percorso sinodale svoltosi in tutto il mondo[5] e li rilancia, con l’obiettivo di facilitare un dialogo tra le Chiese locali. Per questo, come vedremo, è intessuto di citazioni dei materiali da queste inviati. Così, prima ancora che le posizioni su specifici problemi e interrogativi, consente di misurare il tono emotivo del popolo di Dio in cammino lungo il percorso sinodale. Con parole che arrivano dallo Zimbabwe: «Ciò che emerge dall’esame dei frutti, dei semi e delle erbe cattive della sinodalità sono voci di grande amore per la Chiesa, voci che sognano una Chiesa capace di una testimonianza credibile, una Chiesa che sappia essere una famiglia di Dio inclusiva, aperta e accogliente» (n. 16).
Il primo segno di questo amore sono la gioia e l’entusiasmo di coloro che si sono lasciati coinvolgere: a livello globale, sono milioni di persone, che hanno partecipato agli incontri, che hanno accompagnato il processo con la preghiera e che si sono dati da fare per animarlo e coordinarlo. Insieme hanno affrontato l’interrogativo di fondo che muove e guida l’intero percorso sinodale, così espresso dal Documento preparatorio (DP), pubblicato il 7 settembre 2021: «Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale), quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata? E quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale?» (DP 2).
I frutti di questo lavoro, svoltosi assai spesso a livello delle singole parrocchie, sono stati inviati alle équipe sinodali diocesane, che li hanno sintetizzati e trasmessi alle Conferenze episcopali. A loro volta, queste hanno redatto una sintesi sulla base della traccia contenuta nel DP e l’hanno inviata alla Segreteria generale del Sinodo. Queste sintesi riflettono il lavoro fatto «alla base» della compagine ecclesiale, ma al tempo stesso sono state ufficialmente approvate, con modalità diverse, dalle singole Conferenze episcopali.
La risposta ha superato le più rosee aspettative: a Roma sono giunti contributi delle Chiese locali di ogni angolo del Pianeta, comprese quelle che vivono la persecuzione e la guerra. Le difficoltà non le hanno scoraggiate, anzi esse hanno scelto con decisione di far sentire la propria voce. Anche in confronto all’esperienza dei Sinodi precedenti, i numeri sono strabilianti: «Sono pervenute le sintesi di 112 su 114 Conferenze episcopali e di tutte le 15 Chiese orientali cattoliche, a cui si aggiungono le riflessioni di 17 su 23 dicasteri della Curia Romana, oltre a quelle dei superiori religiosi (Usg/Uisg), degli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, di associazioni e movimenti di fedeli laici. Inoltre sono arrivati più di mille contributi di singoli e di gruppi, e gli spunti raccolti attraverso i social media grazie all’iniziativa del “Sinodo digitale”» (n. 5).
Il DTC è stato elaborato a partire da questi materiali – complessivamente quasi 2.000 pagine –, grazie al lavoro di un gruppo di esperti (vescovi, sacerdoti, consacrati e consacrate, laici e laiche, provenienti da tutti i continenti). Dopo averli letti, essi si sono riuniti per quasi due settimane, in clima di preghiera e discernimento, «insieme al gruppo di redazione, composto dal Relatore Generale, dal Segretario Generale del Sinodo, dai Sottosegretari e da alcuni officiali della Segreteria del Sinodo, più i membri del Comitato di coordinamento, a cui si sono infine aggiunti i membri del Consiglio [ordinario del Sinodo]» (ivi).
Il DTC dà voce alla gioia prodotta dagli incontri in cui, a partire dalla parola di Dio, le persone si sono confrontate sul futuro della Chiesa, e registra l’emozione di tanti che dichiarano come si sia trattato della prima volta che la Chiesa ha chiesto il loro parere. Questo entusiasmo non si traduce in un ottimismo ingenuo e acritico. Il DTC è ben consapevole delle difficoltà incontrate: «Alcune sono legate alla coincidenza della fase della consultazione con la pandemia, altre derivano dalla difficoltà di comprendere che cosa significa sinodalità, dalla necessità di un maggiore sforzo di traduzione e inculturazione dei materiali, dalla mancata organizzazione di appuntamenti sinodali in alcuni contesti locali o dalla resistenza di fronte alla proposta» (n. 18). Sono segnalati anche dubbi in merito alle reali intenzioni e alla efficacia del processo, paure per il rischio che la sinodalità conduca al ricorso al principio di maggioranza, a imitazione dei regimi democratici, e anche segnali di separazione tra il clero e il resto del popolo di Dio, con resistenze al coinvolgimento da parte dei sacerdoti e fatiche ad articolare il ruolo dei pastori con la dinamica sinodale. In molti Paesi, poi, il percorso sinodale deve fare i conti con le conseguenze dello «scandalo degli abusi compiuti da membri del clero o da persone con un incarico ecclesiale […]. Si tratta di una ferita aperta, che continua a infliggere dolore alle vittime e ai superstiti, alle loro famiglie e alle loro comunità» (n. 20), oltre a minare seriamente la credibilità della Chiesa.
Al servizio della Tappa Continentale
Prendere coscienza della ricchezza dei doni che Dio ha elargito al suo popolo lungo il primo anno del processo sinodale è un risultato di grande importanza, ma non è lo scopo principale del DTC, che è piuttosto orientato al futuro, e in particolare alla prosecuzione della fase dell’ascolto, attraverso lo svolgimento della Tappa Continentale del Sinodo, al servizio della cui dinamica si pone.
In particolare, dopo la sua pubblicazione, il DTC è stato inviato a tutti i vescovi del mondo, che sono invitati a organizzare nelle loro diocesi un processo ecclesiale di discernimento, identificando, a partire dalla prospettiva di ciascuna Chiesa locale, quali intuizioni risuonano come più promettenti, nuove o illuminanti, e quali sono le tensioni e gli interrogativi emergenti, così da formulare «le priorità, i temi ricorrenti e gli appelli all’azione che possono essere condivisi con le altre Chiese locali nel mondo e discussi durante la Prima sessione dell’Assemblea sinodale nell’ottobre 2023» (n. 106). Le riflessioni delle diocesi confluiranno nuovamente alle Conferenze episcopali, che le sintetizzeranno per predisporre il proprio contributo all’Assemblea continentale a cui parteciperanno. Nel primo trimestre del 2023 ne sono previste sette: Medio Oriente, che vedrà in particolare il contributo delle Chiese cattoliche orientali; Africa e Madagascar; Asia; Oceania; America Latina e Caraibi; America settentrionale; ed Europa. Le Assemblee continentali saranno ecclesiali e non solo episcopali: la loro composizione rispecchierà la varietà del popolo di Dio, prevedendo la presenza di vescovi, presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, laici e laiche. «Rispetto ai partecipanti alle Assemblee continentali è importante porre una particolare attenzione alla adeguata presenza di donne e giovani (laici e laiche, consacrate e consacrati in formazione, seminaristi); persone che vivono condizioni di povertà o emarginazione, e coloro che hanno un contatto diretto con queste; delegati fraterni di altre confessioni cristiane; rappresentanti di altre religioni e tradizioni di fede e alcune persone senza affiliazione religiosa» (n. 108). Al loro interno i vescovi sono chiamati a incontrarsi per rileggere l’esperienza dal punto di vista del loro carisma e ruolo e «svolgere il loro compito di convalida e approvazione del Documento Finale, assicurandosi che sia il frutto di un percorso autenticamente sinodale, rispettoso del processo che si è svolto e fedele alle diverse voci del Popolo di Dio in ogni continente» (ivi). I Documenti finali delle sette Assemblee continentali saranno la base per la redazione dell’Instrumentum laboris, in vista dell’Assemblea sinodale di ottobre 2023.
Questa dinamica della Tappa Continentale intreccia il perseguimento di due obiettivi, ugualmente importanti. Da un lato, opera una restituzione di quanto ascoltato lungo il primo anno alle comunità ecclesiali che hanno preso la parola e che possono così verificare se sono state comprese. Dall’altro lato, facilita un dialogo tra le Chiese locali, permettendo di realizzare un’esperienza di sinodalità a livello continentale, finora sostanzialmente inesplorato, a parte alcune regioni segnate da precise specificità. Come spiega il DTC, nel «quadro di un mondo al tempo stesso globalizzato e frammentato, ciascun continente, in ragione di radici storiche comuni, di una tendenziale comunanza socioculturale e del fatto di presentare le stesse sfide per la missione di evangelizzazione, costituisce un ambito privilegiato per suscitare una dinamica sinodale che rinforzi i legami tra le Chiese, favorisca la condivisione di esperienze e lo scambio di doni e aiuti a immaginare nuove opzioni pastorali» (n. 73).
La struttura del DTC
La considerazione della genesi e dello scopo del DTC consente anche di esplicitarne la natura: «Non si tratta di un documento conclusivo, perché il processo è ben lontano dall’essere terminato; non è un documento del Magistero della Chiesa, né il report di una indagine sociologica; non offre la formulazione di indicazioni operative, di traguardi e obiettivi, né la compiuta elaborazione di una visione teologica, pur essendo carico del tesoro squisitamente teologico contenuto nel racconto dell’esperienza di ascolto della voce dello Spirito da parte del Popolo di Dio, consentendo di far emergere il suo sensus fidei. Ma si tratta di un documento anche teologico, nel senso che è orientato al servizio della missione della Chiesa: annunciare Cristo morto e risorto per la salvezza del mondo» (n. 8).
In questa luce, trova senso anche la sua struttura, che è funzionale a formulare e rendere accessibile una rilettura dell’esperienza del primo anno sulla base della traccia a suo tempo fornita alle Conferenze episcopali per l’elaborazione delle loro sintesi, e da queste liberamente adattata. Vi è dunque uno sforzo per sintonizzarsi con il dinamismo interno dei contributi ricevuti, anziché limitarsi a utilizzarli come fonti di tematiche da trattare o di citazioni da inserire in un diverso impianto.
Per questo il DTC «si apre con un capitolo che offre non una semplice cronaca, ma una narrazione alla luce della fede dell’esperienza di sinodalità vissuta fin qui, con la consultazione del Popolo di Dio nelle Chiese locali e il discernimento dei Pastori nelle Conferenze episcopali» (n. 9).
Prosegue offrendo, nel secondo capitolo, un’immagine biblica, quella della tenda, richiamata nel titolo e tratta dal capitolo 54 del libro di Isaia. Questa icona è in dialogo con le molte immagini della Chiesa presenti nelle sintesi delle Conferenze episcopali, in primis la famiglia e la casa, e «offre una chiave per una interpretazione dei contenuti del DTC alla luce della Parola, inserendoli nell’arco di una promessa di Dio che diventa una vocazione per il suo Popolo e la sua Chiesa» (n. 10). In particolare, si sofferma sull’articolazione tra gli elementi strutturali della tenda a cui il profeta fa riferimento: «Il primo sono i teli, che proteggono dal sole, dal vento e dalla pioggia, delineando uno spazio di vita e di convivialità. Occorre dispiegarli, in modo che possano proteggere anche coloro che ancora si trovano al di fuori di questo spazio, ma che si sentono chiamati a entrarvi» (n. 26). Poi ci sono le corde, che tengono insieme i teli, ma soprattutto devono avere la giusta tensione per evitare che la tenda si afflosci e al tempo stesso per ammortizzare le spinte a cui è sottoposta, soprattutto per l’azione del vento. Questa metafora richiama la necessità di un continuo discernimento. Infine ci sono i paletti, che ancorano la tenda al suolo, ma restano mobili. Rappresentano «i fondamenti della fede che non mutano, ma possono essere spostati e piantati in terreni sempre nuovi, in modo che la tenda possa accompagnare il popolo che cammina nella storia» (n. 27).
Il terzo capitolo riprende l’immagine della tenda come «uno spazio di comunione, un luogo di partecipazione e una base per la missione» (n. 11), e su di essa articola i frutti dell’ascolto del popolo di Dio con le parole chiave del titolo del Sinodo, appunto «comunione», «partecipazione» e «missione». Ne emergono cinque cardini generativi, attorno ai quali è possibile raccogliere le molte tensioni dinamiche emerse lungo il processo, su cui torneremo fra breve con maggiori dettagli.
Infine, il quarto capitolo getta uno sguardo sul futuro del processo sinodale, componendo due orizzonti temporali ugualmente indispensabili. Il primo è quello «di lungo periodo, in cui la sinodalità prende la forma di una perenne chiamata alla conversione personale e alla riforma della Chiesa. Il secondo, chiaramente al servizio del primo, è quello che concentra la nostra attenzione sugli appuntamenti della Tappa Continentale che stiamo vivendo» (n. 98).
I cinque cardini generativi
Il discernimento operato sui materiali ricevuti dalla Segreteria generale del Sinodo ha fatto emergere cinque cardini, attorno a cui si intreccia un’ampia serie di tensioni, talvolta evidenti e talvolta latenti. Queste da una parte possono rappresentare fonti di energia per la prosecuzione del processo sinodale, dall’altra lasciano intravedere alcuni punti caldi su cui proseguire il lavoro.
Per questo, occorre continuare a fare i conti con «due delle principali tentazioni che si presentano alla Chiesa di fronte alla diversità e alle tensioni che essa genera. La prima è quella di rimanere intrappolati nel conflitto: gli orizzonti si restringono, si perde il senso dell’insieme e ci si frammenta in sotto-identità. È l’esperienza di Babele e non di Pentecoste, ben riconoscibile in molti tratti del nostro mondo. La seconda è quella di distaccarsi spiritualmente e di disinteressarsi delle tensioni in gioco, continuando a percorrere la propria strada senza coinvolgersi con chi ci è vicino nel cammino» (n. 30). I cinque cardini sono uno strumento in questa direzione, perché consentono di articolare le tensioni, andando oltre la semplice elencazione dei problemi, e aiutano a focalizzare le connessioni.
Il primo cardine, che emerge con forza dalle sintesi ricevute, è «l’ascolto come apertura all’accoglienza a partire da un desiderio di inclusione radicale – nessuno escluso! –, da intendersi in una prospettiva di comunione con le sorelle e i fratelli e con il Padre comune. L’ascolto appare qui non come una azione strumentale, ma come l’assunzione dell’atteggiamento di fondo di un Dio che ascolta il suo Popolo, e la sequela di un Signore che i Vangeli ci presentano costantemente in ascolto delle persone che gli si fanno incontro lungo le strade della Terra Santa; in questo senso l’ascolto è già missione e annuncio» (n. 11). Questa spinta all’inclusione traduce l’invito di Isaia ad «allargare la tenda» e si dirige verso un’ampia platea di persone e gruppi che per le ragioni più diverse vivono una condizione che il DTC descrive attraverso la categoria biblica di «un esilio, le cui conseguenze riguardano l’intero Popolo di Dio: se la Chiesa non è sinodale, nessuno può davvero sentirsi a casa» (n. 24). Trova qui spazio l’attenzione a «donne e giovani che non sentono riconosciuti i propri doni e le proprie capacità» (n. 38), a «molti membri del clero, che non si sentono ascoltati, sostenuti e apprezzati» (n. 34), così come a «coloro che per diverse ragioni avvertono una tensione tra l’appartenenza alla Chiesa e le proprie relazioni affettive, come ad esempio: i divorziati risposati, i genitori single, le persone che vivono in un matrimonio poligamico, le persone LGBTQ, ecc.» (n. 39). La richiesta di accoglienza interpella profondamente le comunità cristiane, ma emergono anche incertezze sul modo di darvi risposta: occorre un più approfondito discernimento da parte della Chiesa intera. In ogni caso, l’ascolto costituisce con chiarezza una urgenza su cui impegnarsi da subito, senza attendere la conclusione del processo sinodale.
Il secondo cardine è costituito dalla spinta all’uscita verso la missione, da attuare ricomponendo in modo originale due tensioni che da sempre accompagnano l’azione della Chiesa: quella tra proclamazione del kerygma e dialogo con il mondo, così come quella tra annuncio della fede e servizio dello sviluppo umano integrale. Sono tensioni strutturali, che non possono essere risolte, né diventare la base per dividersi in fazioni. Questa spinta alla missione è espressa con il linguaggio della Laudato si’ («Il Popolo di Dio esprime il profondo desiderio di ascoltare il grido dei poveri e quello della terra», n. 45) e della Fratelli tutti, e dunque con una particolare attenzione al dialogo interreligioso e interculturale: «La sinodalità è una chiamata di Dio a camminare insieme a tutta la famiglia umana. In molti luoghi, i cristiani vivono in mezzo a persone di altre fedi o non credenti e sono impegnati in un dialogo fatto di quotidianità e comunanza di vita» (n. 43). Ma soprattutto rimette al centro l’ecumenismo: «Molte sintesi sottolineano che non c’è sinodalità completa senza unità tra i cristiani» (n. 48). In materia di dialogo con le religioni e le culture, il DTC non manca di sottolineare alcuni punti problematici, quali una cultura sempre più segnata da secolarizzazione, individualismo e consumismo, e ricorda soprattutto come ci siano contesti in cui «la testimonianza della fede è vissuta fino al martirio» (n. 52), che assai spesso unisce i cristiani di tutte le confessioni.
Il terzo cardine è quello dello stile che una Chiesa sinodale è chiamata ad assumere, «basato sulla partecipazione, che corrisponde alla compiuta assunzione della corresponsabilità di tutti i battezzati per l’unica missione della Chiesa derivante dalla comune dignità battesimale» (n. 11). La riconfigurazione della missione fa uscire dal dualismo ad intra/ad extra, che vari contributi invitano a superare, e permette di rifocalizzare tutta la vita della Chiesa attorno alla responsabilità missionaria di tutti e di ciascuno. Si tratta di un elemento chiave per una corretta comprensione della sinodalità, che non è un espediente organizzativo per la ripartizione di ruoli e poteri, ma va anche oltre la prospettiva del rovesciamento della piramide, attraverso una riconversione dell’immaginario. Vocazioni, carismi e ministeri – incluso il ministero ordinato – vanno compresi a partire dalla logica della missione, non delle dinamiche organizzative interne alla comunità ecclesiale, che della missione sono uno strumento. Ad esempio, il DTC segnala «l’importanza di liberare la Chiesa dal clericalismo, in modo che tutti i suoi membri, sia sacerdoti sia laici, possano adempiere alla comune missione» (n. 58). In questa luce, si pone anche la questione dei ministeri laicali e soprattutto del posto delle donne all’interno della Chiesa, anche rispetto alla partecipazione ai processi decisionali e all’accesso alle strutture di governo: «Da tutti i continenti arriva un appello affinché le donne cattoliche siano valorizzate innanzi tutto come battezzate e membri del Popolo di Dio con pari dignità» (n. 61).
Per costruire possibilità concrete di vivere comunione, partecipazione e missione – è questo il quarto cardine – «la Chiesa ha bisogno di dare una forma e un modo di procedere sinodale anche alle proprie istituzioni e strutture, in particolare di governo» (n. 71), prevedendo anche le opportune innovazioni del diritto canonico. Il percorso finora seguito ha già permesso di identificare alcuni nuclei strutturali di grande rilevanza, su cui continuare a lavorare: dalla «sintonia tra le modalità ordinarie di esercizio del ministero episcopale e l’assunzione di uno stile pienamente sinodale» (n. 76) all’articolazione tra sinodalità ecclesiale e collegialità episcopale, fino alla rivitalizzazione degli organismi di partecipazione affinché possano essere autentici luoghi di discernimento comunitario. Tuttavia, le «strutture da sole non bastano: c’è bisogno di un lavoro di formazione continua che sostenga una cultura sinodale diffusa» (n. 82). Infine, questa «nuova visione avrà bisogno di essere sostenuta da una spiritualità che fornisca strumenti per affrontare le sfide della sinodalità senza ridurle a questioni tecnico-organizzative, ma vivendo il camminare insieme a servizio della comune missione come occasione di incontro con il Signore e di ascolto dello Spirito. Perché ci sia sinodalità è necessaria la presenza dello Spirito, e non c’è lo Spirito senza la preghiera» (n. 72). In particolare, il metodo della conversazione spirituale, che molti identificano come un fattore chiave della fecondità del primo anno del processo sinodale, deve diventare «prassi ordinaria della vita della Chiesa, come è richiesto da più parti, [ed …] evolvere […] nella direzione del discernimento comunitario» (n. 86), che peraltro ne rappresenta l’autentico orizzonte di senso.
Infine, il quinto cardine – ultimo, perché più fondamentale – è costituito dalla «liturgia, in particolare quella eucaristica, fonte e culmine della vita cristiana, che riunisce la comunità, rendendo tangibile la comunione, consente l’esercizio della partecipazione e nutre con la Parola e i Sacramenti lo slancio verso la missione» (n. 11). È nella liturgia che le tre parole chiave del processo sinodale trovano la loro piena sintesi non solo nella comprensione, ma nel vissuto profondo della comunità cristiana. La celebrazione eucaristica è il motore del dinamismo apostolico e il luogo di formazione di una comunità sinodale missionaria. Per questo è così fondamentale «l’attuazione di uno stile sinodale di celebrazione liturgica che permetta la partecipazione attiva di tutti i fedeli nell’accoglienza di tutte le differenze, nella valorizzazione di tutti i ministeri e nel riconoscimento di tutti i carismi» (n. 91). A questo riguardo, il DTC non manca di evidenziare alcuni limiti e ostacoli: da un eccesso di protagonismo del celebrante alla passività dei fedeli; da una qualità delle omelie quasi unanimemente segnalata come problematica al rapporto con i riti preconciliari; dalle forme di deprivazione sacramentale patite da comunità che vivono in aree molto remote o conseguenti all’«uso di prevedere tariffe per l’accesso alle celebrazioni, che discrimina i più poveri» (n. 94), fino al dolore di quanti non possono accedere ai sacramenti in relazione alla disciplina del matrimonio. Al tempo stesso il DTC sottolinea che «il processo sinodale ha rappresentato l’opportunità di sperimentare nuovamente la diversità nelle forme di preghiera e celebrazione, accrescendo il desiderio di renderla più accessibile nella vita ordinaria delle comunità» (n. 95) e valorizza la «varietà delle tradizioni rituali della preghiera liturgica, come anche delle forme simboliche con cui si esprimono le diverse culture» (n. 97).
Molte voci per costruire armonia
Delineando l’orizzonte della conversione personale dei credenti e della riforma, il DTC afferma: «Le sintesi non invocano l’uniformità, ma chiedono di imparare a crescere in una sincera armonia, che aiuti i credenti a compiere la loro missione nel mondo, creando i legami necessari per camminare insieme con gioia» (n. 102). Esprime così la direzione su cui il popolo di Dio intende proseguire il cammino, ma racconta anche quanto vissuto lungo il primo anno del processo sinodale.
Molte sono le voci che hanno parlato, alcune per la prima volta. Ma, in fondo, questa molteplicità non è una novità, e talvolta ha generato polarizzazione all’interno della comunità. Il processo sinodale, attraverso il metodo che utilizza, si propone come l’esperimento di una modalità che permetta di cominciare ad articolare il pluralismo delle voci, senza uniformarle, ma favorendo l’incontro e il dialogo.
In particolare, attraverso il dinamismo di presa di parola, ascolto e restituzione di quanto ascoltato, in cui anche il DTC si colloca, il metodo su cui è impostato il processo sinodale prova a costruire delle mediazioni – sono inevitabili quando si lavora a scala globale – che sfuggano al rischio di rimanere imprigionate in particolarismi e idiosincrasie, riconoscendo a tutti un ruolo nel rispetto delle differenze interne alla compagine ecclesiale: il processo non è acefalo o anarchico, senza nemmeno diventare verticistico o piramidale.
Si è trattato anzitutto di un tentativo, di cui sono evidenti i limiti e soprattutto i margini di possibile miglioramento, su cui investire fin da subito. Ma ha funzionato, almeno per coloro che hanno scelto di buttarsi e lasciarsi coinvolgere: «La sinodalità ha smesso per loro di essere un concetto astratto e ha preso il volto di una esperienza concreta; ne hanno assaporato il gusto e vogliono continuare a farlo: “Attraverso questo processo – si legge in una sintesi – abbiamo scoperto che la sinodalità è un modo di essere Chiesa; anzi, il modo”» (n. 3).
Il Sinodo continua, con le tappe previste, ma, al di là di queste, prosegue soprattutto la ricerca dei modi per essere una Chiesa sempre più sinodale. A tutto il popolo di Dio auguriamo buon Sinodo, cioè buon «cammino insieme»!
Copyright © La Civiltà Cattolica 2022
Riproduzione riservata
***
«FOR A SYNODAL CHURCH». The Working Document for the Continental Stage
The Working Document for the Continental Stage is the fruit of the syntheses resulting from the consultation of the People of God in the first phase of the synodal process and will be the focus of the time dedicated to the reading, dialogue and discernment of the Continental Synod Assemblies (January-March, 2023). The first part of the Document is dedicated to the fruits of the experience of walking together; a second part, which is more developed, deepens intuitions, questions, and issues that emerged during the reading; a third part indicates the steps identified to move forward as a local Church in a synodal style.
***
[1]. Nuove date per il Sinodo sulla Sinodalità. Comunicato della Segreteria Generale del Sinodo, 16 ottobre 2022
[2]. Ivi.
[3]. Per maggiori informazioni sulle tappe che scandiscono il processo del Sinodo 2021-24, rinviamo al sito ufficiale www.synod.va/. Per la Tappa Continentale, si veda in particolare www.synod.va/it/synodal-process/la-fase-continentale.html
[4]. Si farà qui riferimento alla versione italiana, che è quella originale insieme all’inglese, rimandando alla numerazione dei paragrafi (= i numeri indicati tra parentesi nel testo dell’articolo) e non delle pagine. Il DTC è scaricabile gratuitamente in varie lingue dal sito del Sinodo: www.synod.va
[5]. Si fa qui riferimento unicamente al percorso del Sinodo universale 2021-24 e non al «Cammino sinodale delle Chiese in Italia», articolato in tre fasi dal 2021 al 2025, che comunque si intreccia con il primo. A questo riguardo, si veda il sito