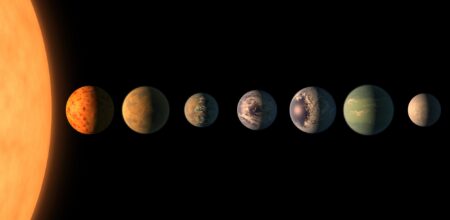|
|
Celebriamo a Pasqua l’evento della risurrezione di Gesù di Nazaret. La Chiesa ci dice che in questa commemorazione riconosciamo e accogliamo uno dei dogmi centrali della nostra fede, una verità dunque decisiva per la nostra salvezza, ma, al tempo stesso, un fatto difficile da credere, qualcosa che chiamiamo «mistero». Se infatti interroghiamo con sincerità la nostra coscienza, percepiamo, forse con un brivido di turbamento, che non abbiamo prove che Gesù crocefisso sia tornato a vivere. Ci basiamo sulle dichiarazioni di testimoni oculari, trasmesse di generazione in generazione, ripetute da persone per bene, senza però essere stati presenti nel momento in cui Gesù si è mostrato ai suoi discepoli per avere la certezza della risurrezione. Vorremmo che anche a noi fosse dato di mettere il dito nel segno dei chiodi e la mano nel fianco squarciato del Signore, così che, come Tommaso, da increduli possiamo diventare veri credenti (Gv 20,27).
Il cammino del credere
Il passaggio dal dubbio alla fede sicura, appena evocato, ci appare essere stato quello dei testimoni oculari, che riteniamo privilegiati e fortunati, perché immaginiamo che per loro sia stato facile, rapido e quasi automatico il credere. E dimentichiamo che gli apostoli avevano assistito a miracoli eclatanti, avevano visto lebbrosi guarire e ciechi recuperare la vista, erano là quando Lazzaro uscì dal sepolcro, e con i loro occhi videro Gesù venire incontro a loro camminando sulle acque. Eppure il Maestro li rimproverò più volte per la loro poca fede (Mt 6,30; 8,26; 14,31; 16,8; 17,20; ecc.); e, nonostante tanti segni della sovrumana potenza del Cristo, al momento della Passione fuggirono e rinnegarono colui che avevano confessato essere il loro Signore (Mt 16,16; Gv 6,68-69).
Tutto ciò dimostra che nessun segno, per quanto limpido e sconvolgente, è capace di produrre automaticamente l’assenso perseverante del cuore. La perplessità e il sospetto di fronte a ciò che risulta inspiegabile rimangono latenti nella coscienza e sfociano facilmente nello scetticismo, nella diffidenza e nel rifiuto. Ecco perché, di fronte a un muto che, per il gesto di Gesù, si mette improvvisamente a parlare, alcuni diranno che quel Rabbi è dotato di spirito diabolico (Mt 12,24); e quando un cieco noto a tutta la città diventa capace di vedere perché qualcuno gli ha detto di lavarsi gli occhi, gli astanti si domanderanno se non c’è di mezzo un qualche imbroglio, come lo scambio di persona (Gv 9,18). Le autorità religiose di Gerusalemme dovettero constatare che la tomba da loro sigillata era ormai vuota; cominciarono allora a far circolare l’idea che il cadavere era stato trafugato (Mt 28,11-15). E molti secoli dopo, chi era mosso da spirito razionalista sostenne che il Crocefisso aveva subìto solo una morte apparente, e che le cosiddette apparizioni del Risorto non erano altro che allucinazioni collettive o manifestazioni isteriche senza fondamento reale. La risurrezione veniva così liquidata come una favola, bella, ma irreale.
Noi, per consolarci, ci diciamo che questi ultimi discorsi sono quelli dei miscredenti, che chiudono gli occhi di fronte a fatti accertati e a testimonianze attendibili; i detrattori del mistero della risurrezione sarebbero paragonabili agli ateniesi del tempo di san Paolo, che, rifiutando a priori ogni evento di carattere soprannaturale, si allontanarono con disprezzo appena venne evocato l’evento della risurrezione dai morti (At 17,32). Tuttavia, se stiamo ai racconti evangelici, nemmeno per gli apostoli, nemmeno per chi ebbe la «visione» del Risorto fu cosa scontata il credere. Scorriamo i testi evangelici.
Secondo il Vangelo di Matteo, «gli Undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono» (Mt 28,17). Quest’ultima frase deve sorprenderci; non abbiamo infatti solo la dichiarazione che gli apostoli non credettero alla testimonianza di altri, né a Maria di Magdala (Mc 16,11), né alle donne tornate dal sepolcro (Lc 24,11), né ai due discepoli a cui Gesù apparve «mentre erano in cammino verso la campagna» (Mc 16,12-13). Matteo situa il dubbio nel momento stesso della visione, e non solo come denuncia nei confronti di qualcuno dei presenti, ma come il vissuto dell’intero gruppo apostolico.
Il Vangelo di Luca, dal canto suo, ci mostra la difficoltà che ebbero i testimoni nel «riconoscere» il Risorto. Due discepoli fanno un lungo percorso di strada, discutendo con qualcuno che pensano sia un forestiero e non immaginano che sia il loro Maestro (Lc 25,15-24); e gli apostoli, quando «Gesù in persona stette in mezzo a loro», «sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma» (Lc 24,36-37). Constatando il loro turbamento e i loro dubbi (dialogismoi) (v. 38), Gesù si fece toccare, ma, dice l’evangelista, «per la gioia non credevano ancora» (v. 41), e quindi il Risorto mangiò una porzione di pesce arrostito davanti a loro (vv. 42-43). Non ci viene confermato se, finalmente, di fronte a quest’ultima dimostrazione, gli apostoli credettero; forse lo si può supporre, ma, come diremo più avanti, la fede non scaturisce solo da una esperienza corporea.
Nel Vangelo di Giovanni leggiamo qualcosa di simile. Maria di Magdala «vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù» (Gv 20,14). La donna vede in lui il custode del giardino (v. 17), gli parla, ne ascolta la voce, ma non riconosce Gesù. Durante l’apparizione al lago di Tiberiade, dice l’evangelista: «Nessuno dei discepoli osava domandargli: “Chi sei?”, perché sapevano bene che era il Signore» (Gv 21,12): una constatazione questa sorprendente, perché la domanda «Chi sei?» suggerisce un divario tra l’immagine che si vede e ciò che la persona è realmente. Il dubbio, l’esitazione, la perplessità e la resistenza di fronte a qualcosa di «incredibile» appartiene in realtà alla natura dell’evento, ne esprime l’aspetto inaudito e inimmaginabile (Is 48,6-7; 52,15), non solo inaspettato, ma, come si esprime la stessa Sacra Scrittura, addirittura «impossibile», simile al miracolo di generare da parte di una coppia di vecchi (Gen 18,13-14), o al parto verginale (Lc 1,34-37), oppure al ripristino dell’agricoltura dopo una totale devastazione (Ger 32,27), o alla nascita di un intero popolo in un solo giorno (Is 66,8).
Non basta dunque vedere per credere. Saulo di Tarso attesta di aver avuto la visione del Risorto mentre si recava a Damasco; ora, leggendo la descrizione dell’evento negli Atti degli Apostoli, constatiamo che in realtà in quel momento egli fu colpito da cecità, e solo dopo l’incontro con Anania riacquistò la vista, simbolo della sua avvenuta capacità di riconoscere e accettare il Signore (At 9,1-19; 22,6-16).
Ricordiamo infine la conclusione della parabola di Lazzaro e dell’uomo ricco. La richiesta di quest’ultimo di mandare il povero che sta nel seno di Abramo ad ammonire i fratelli (perché ciò garantirebbe la loro conversione), ottiene come risposta: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti» (Lc 16,27-31). Una tale dichiarazione denuncia con chiarezza l’inganno di un’esperienza sensoriale che avrebbe un’efficacia incontrovertibile.
Da tutte queste considerazioni traiamo dunque la conclusione che la nostra condizione di discepoli del Signore non è così radicalmente diversa da quella di coloro che furono testimoni oculari della risurrezione di Gesù. Certo, non neghiamo l’importanza della testimonianza che conseguì a quell’evento storico, ma precisiamo che noi non siamo affatto sfavoriti, anzi proprio a noi, che non eravamo presenti quando il Risorto si mostrò ai suoi discepoli, è stata rivolta una parola di grande importanza. Infatti, secondo il Vangelo di Giovanni, il Signore affermò, come un paradosso, nel momento stesso in cui Tommaso mise il dito nelle piaghe del Crocefisso: «Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto» (Gv 20,29).
Non è questa una magra consolazione. Per la nostra intima gioia ci viene invece indicato il vero cammino della fede, il cammino di chi accede alla verità e vi aderisce perché rinuncia alla pretesa degli occhi, per affidarsi alla penetrante forza persuasiva della Parola. Già i nostri padri, al Sinai, fecero l’esperienza che il contatto diretto con Dio, nel fuoco, risultava pericoloso, anzi distruttivo della vita, e chiesero di accogliere la rivelazione del Signore mediante la parola del mediatore Mosè. E Dio approvò questa decisione, dicendo: «Oh, se avessero sempre un tal cuore, da temermi e osservare tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre!» (Dt 5,29). La via della vita e della felicità suppone e impone il cammino del credere, che si esprime come obbedienza alla Parola, un’esperienza questa di comprensione, di spirituale intelligenza, una acquisizione personale, libera e creativa, della verità.
Nei racconti delle apparizioni del Risorto la componente della Parola (e quindi dell’ascolto) non solo accompagna, in modo complementare, l’esperienza della visione, ma costituisce il fattore più decisivo per il credere. Quando Pietro e il discepolo amato arrivano al sepolcro, constatano l’assenza del corpo di Gesù, in piena conformità a quanto aveva comunicato loro Maria di Magdala (Gv 20,1-2); vedono anche che i teli e il sudario erano rimasti nella tomba, e notano che il sudario era «avvolto in un luogo a parte» (Gv 20,6-7). L’evangelista (Giovanni) dice che il discepolo amato «vide e credette» (v. 8), perché – deduciamo noi – intuì il significato di quei particolari intriganti, ma va notato il commento del narratore: «Infatti, non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti» (v. 9). I segni dunque rimangono indizi: possono suscitare perplessità, stupore (Lc 24,12) e forse interrogazione, ma il loro significato viene svelato solo quando si «comprende» la Scrittura, nella quale è annunciato il mistero della risurrezione.
Questo fatto viene chiaramente confermato dalla tradizione lucana. La manifestazione del Signore risorto, nel Vangelo di Luca, si esprime nel dare ai discepoli segni «tangibili» del suo essere vivo (come abbiamo indicato in precedenza: Lc 24,39-43); tuttavia Gesù, per renderli edotti del senso della sua vicenda e per farli testimoni del suo mistero, ricorda ai discepoli le «parole che aveva detto loro quando era ancora con loro» (prima della Passione), parole che, a loro volta, si fondavano sull’antica Scrittura: «Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi» (Lc 24,44).
L’evento della risurrezione è «compreso» dunque nel suo senso ed è accolto con un consenso autentico solo se è «visto» come il compimento della promessa divina attestata dalle Scritture. La testimonianza concorde di Mosè, dei profeti e della tradizione orante di Israele (Salmi) è la mediazione necessaria per un profondo assenso credente. Dice infatti Luca che il Risorto non si accontentò di farsi toccare o di mangiare con gli apostoli (cosa che noi riteniamo spontaneamente sia la prova più sicura della sua risurrezione), ma «allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture, e disse loro: “Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno”» (Lc 24,45-46). L’apertura della mente (ton noun) per comprendere le Scritture è un’operazione attribuita al Risorto, è un dono di rivelazione attuato mediante la parola.
È, di fatto, ciò che Gesù ha realizzato con i due discepoli di Emmaus, durante un percorso che immaginiamo sia quello di un giorno intero di cammino, un tempo lungo, necessario perché la «lentezza» del cuore (dei discepoli) nel credere alle parole dei profeti (Lc 24,25) potesse essere soccorsa dall’insegnamento paziente del Risorto, che, «cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò (diermēneusen) loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (Lc 24,27). Questa spiegazione interpretativa non è una lezione cattedratica, né un’esegesi dalla valenza dimostrativa e apologetica, ma è piuttosto un percorso meditativo che fa scoprire la coerente attestazione della promessa divina finalmente adempiuta, è un «aprire» spazi all’intelligenza, e soprattutto è conversazione calorosa che fa «ardere il cuore» e lo prepara all’assenso e conseguentemente al dovere della testimonianza (Lc 24,32-35).
Ebbene, ciò che il Risorto ha fatto con i suoi discepoli, la Chiesa lo riprende, con umile fedeltà, nel rito solenne della Veglia pasquale; in essa, a partire dalla prima pagina della Scrittura (sulla creazione del mondo) e percorrendo gli eventi fondatori della storia della salvezza, mediante l’illuminazione della parola dei profeti e la risposta credente del Salterio, il fedele viene condotto a comprendere e gustare l’annuncio mirabile della risurrezione del Signore. Non è una catechesi, è invece un percorso di ascolto nella preghiera, è una iniziazione misterica e sacramentale, nella quale chi partecipa alla liturgia fa (anzi, deve fare) esperienza di un dono di rivelazione, che tocca il cuore, che lo apre, e lo fa passare dal dubbio e dallo scoraggiamento alla consolante certezza della verità.
Il percorso che la liturgia fa compiere nella Veglia pasquale è un modello di ciò che il credente è invitato a compiere durante tutto l’anno, anzi durante tutta la vita. Simbolicamente viene additato un costante passaggio dall’antica economia di grazia al nuovo e definitivo evento della salvezza. Le letture dell’Antico Testamento sono presentate come prefigurazioni profetiche e come promesse dell’evento decisivo della storia umana, quello della risurrezione del Cristo; e le pagine del Nuovo Testamento, che attestano come la salvezza sia avvenuta nel Risorto dai morti, rinviano a loro volta, con slancio profetico, al compimento escatologico, a quell’evento di pienezza in cui la risurrezione investirà, come grazia perenne, tutta la comunità dei credenti (cfr 1 Cor 15).
Questo processo di lettura, ascolto, interpretazione, comprensione e obbedienza alla Parola è il cammino dei credenti, mai totalmente compiuto, perché il mistero della grazia del Signore è inesauribile. Ma ogni esperienza (ogni «esercizio») che rinnova, nel flusso del tempo, la consolante apertura alla verità divina, ogni momento in cui, nella preghiera, si gioisce per il dono della Rivelazione, ecco, in questo momento di grazia si vive realmente la fede e contemporaneamente la comprensione di ciò a cui si crede. E questo istante è promettente, stimola ad andare oltre, a salire verso più alte intelligenze, o meglio a scendere nelle profonde e insondabili ricchezze del mistero. Percorso che è favorito e sostenuto dall’atto dell’ascolto delle divine Scritture, che si dischiudono alla nostra coscienza, perché l’Agnello immolato, vincitore della morte, ne apre i sigilli (Ap 5,1-14), facendo così entrare i credenti nel cuore della verità, così da consentire loro il canto dell’Alleluia.
L’evento della risurrezione come incontro di salvezza
La prospettiva che finora abbiamo assunto è quella della persona che, disponibile all’ascolto, compie un percorso spirituale, culminante nell’atto della comprensione e quindi della piena accoglienza del mistero della risurrezione del Signore. Se vogliamo ricorrere a una immagine, possiamo pensare ai piedi delle donne che si recano alla tomba, o a quelli degli apostoli che corrono a verificare se davvero nel sepolcro non c’è più il corpo di Gesù, o a quelli dei discepoli di Emmaus che si allontanano, ma poi in fretta ritornano a Gerusalemme, o a quelli di Pietro che va a pescare e in seguito si tuffa nel lago per incontrare il suo Signore. Sono i piedi di donne e uomini che si muovono, forse in maniera esitante, verso il luogo di una rivelazione; e su questi passi dell’uomo vi è una lampada, quella della Parola della Scrittura, che illumina, incoraggia, guida e fa vedere intimamente ciò che il cuore non osava immaginare.
La liturgia della Veglia pasquale fa compiere alla comunità cristiana un analogo cammino; non solo esso è simboleggiato dalla processione al seguito del cero pasquale, ma è più realmente, anche se simbolicamente, attuato nel processo della lettura e ascolto dei testi dell’Antico Testamento (idealmente sette brani, per indicare un ciclo completo), che si concludono con l’annuncio che «il Signore è risorto, sì, è davvero risorto». Questo momento liturgico esprimerebbe dunque l’impegno «umano» nella celebrazione pasquale, che prepara l’accoglienza della salvezza nel rito eucaristico.
Questo modo di vedere le cose è comunque parziale, e va integrato con la contemplazione dell’iniziativa del Cristo. Sono infatti i piedi del Signore, è il suo «venire» incontro ai suoi ad essere l’essenza dell’evento pasquale (e di conseguenza della celebrazione rituale). È Gesù risorto che – come ci dice l’evangelista Matteo – «venne incontro» alle donne, le quali, lasciato il sepolcro, stavano recandosi dai discepoli (per riferire dell’apparizione dell’angelo); ed è significativo notare che esse «si avvicinarono e gli abbracciarono i piedi» (Mt 28,9), non solo come gesto di umile adorazione, ma anche come riconoscimento simbolico del suo cammino verso di loro.
Nel Vangelo di Luca, la prima manifestazione del Risorto è quella di Gesù che «si avvicinò e camminava» con i due discepoli di Emmaus (Lc 24,15); e l’ultima apparizione (quella dell’Ascensione, quale modalità espressiva del trionfo celeste del Cristo) è introdotta dall’iniziativa di Gesù, che «li condusse fuori verso Betania», precedendo e guidando i discepoli.
L’evangelista Giovanni, infine, completa questa prospettiva, e sottolinea ripetutamente che il Risorto «venne» a incontrare i suoi che stavano in casa a porte chiuse (Gv 20,19.26); è Lui, il Vivente, a cercare, è lui a rivelarsi. E nell’ultimo racconto, quello della manifestazione del Signore al lago di Tiberiade (Gv 21), è sempre il Signore ad avere l’iniziativa, per farsi riconoscere nel segno della pesca prodigiosa, ma soprattutto nella parola che esprime il perdono per Pietro, e in lui, per tutti i suoi compagni. Quando i piedi degli uomini si muovono, quelli del Signore li hanno preceduti, perché il mistero della Pasqua è l’opera del Signore Gesù, che, rivelandosi, salva i suoi fratelli.
Quest’ultimo aspetto (quello della rivelazione che salva) non interpreta l’evento della risurrezione sottolineando ciò che è avvenuto nel corpo di Gesù, nel suo passaggio dalla morte alla vita piena; viene invece esplicitato l’effetto salvifico che ne consegue, e che si realizza proprio nel far conoscere ai suoi il suo trionfo sulla morte.
Per illustrare questa tematica facciamo ricorso all’ultima parte del ciclo di Giuseppe, il figlio di Giacobbe, amato dal padre in modo privilegiato, e, proprio per questo, oggetto di gelosia da parte dei fratelli, che decidono di eliminarlo vendendolo come schiavo a degli stranieri e dichiarandolo morto (con una falsa attestazione presentata al padre Giacobbe).
È tradizionale il vedere nel personaggio di Giuseppe e in particolare nel suo destino sofferente una figura profetica del Cristo, il Figlio prediletto del Padre, consegnato alla morte per invidia dei suoi. Ma è ancora più significativo esaminare la narrazione del cap. 45 della Genesi, mettendolo in parallelo con i racconti delle apparizioni del Risorto. Fra i numerosi accostamenti, mettiamo in luce solamente tre elementi, che ci fanno comprendere meglio l’aspetto salvifico della risurrezione.
1) Un tempo di attesa. Giuseppe, mettendo a frutto le sue doti di sapienza, è diventato viceré d’Egitto, ha raggiunto la pienezza della gloria; quando vede i suoi fratelli, venuti in Egitto a cercare grano, non si fa subito riconoscere. Secondo il racconto biblico passano anzi alcuni anni, e sono necessari diversi incontri e molteplici stratagemmi prima che avvenga il riconoscimento. Questo tempo lungo è infatti indispensabile perché il cuore dei fratelli si apra gradualmente alla compassione, si senta toccato dall’amore sia per il padre Giacobbe (addolorato a morte a causa della perdita del figlio tanto amato), sia per il fratello piccolo, Beniamino (minacciato di subire la sorte dell’altro figlio di Rachele, venduto come schiavo). Giuseppe dà il tempo ai fratelli di ricordare, e in questa memoria di far emergere la consapevolezza del loro peccato e di ciò che esso ha prodotto come strascico di dolore.
Anche nei racconti delle apparizioni di Gesù notiamo che, benché più limitata nel tempo, vi è una dilazione nel manifestarsi del Risorto. Pensiamo innanzitutto ai tre giorni, dal venerdì alla domenica, in cui i discepoli si trovarono a riflettere sul senso degli eventi sconvolgenti, che non solo si erano conclusi tragicamente per il loro Maestro, ma nei quali essi erano stati protagonisti negativi, perché erano fuggiti, avevano rinnegato e abbandonato il Signore. Questi giorni sono i giorni delle lacrime, quelle di Pietro, menzionate da Luca (Lc 22,62), ma immaginiamo quelle di tutta la comunità coinvolta nella responsabilità della tragedia. Se poi ci riferiamo al racconto emblematico dei discepoli di Emmaus, vediamo chiaramente come Gesù abbia preso del tempo per portare queste persone, da un cuore chiuso nello smarrimento e nella tristezza, al momento radioso del riconoscimento.
C’è poi un altro aspetto, concordemente riportato da tutti gli evangelisti e meritevole di riflessione: Gesù non appare subito agli apostoli, ma prima alle donne. Sono queste ad avere la visione degli angeli che rivelano l’evento della risurrezione, e, almeno per Matteo e Giovanni, sono loro le prime a incontrare e riconoscere il Risorto. Questo fatto viene abitualmente interpretato affermando che le persone dal cuore amoroso sono le più pronte a ricevere la rivelazione del Cristo. Ciò è senza dubbio vero, ma vorremmo qui far notare l’effetto che si produsse nella coscienza degli apostoli; queste donne, le uniche che seguirono il Signore fino al Calvario, quando attestarono di aver visto il Risorto, non potevano non far emergere la memoria del tradimento in chi era fuggito ed era impreparato ad accogliere la medesima rivelazione. Alcuni degli apostoli, infatti, andarono al sepolcro, ma, a differenze delle donne, il Signore non lo videro (Lc 24,24). Questo tempo di dolorosa attesa è necessario per far maturare nel cuore la capacità di apprezzare quanto misericordiosa sia, alla fine, la visita del Signore risorto.
2) L’ iniziativa del Risorto. Non è infatti per una qualche attività (interiore o esteriore) dei discepoli che avviene l’incontro con il Risorto. Ritorniamo al racconto della Genesi, che ci serve come sfondo. Quando i fratelli vedono Giuseppe, non lo riconoscono, non possono immaginare che il sovrano davanti a loro sia l’uomo che essi hanno trattato da schiavo. È dunque Giuseppe, spinto dall’amore compassionevole, a farsi riconoscere, dicendo: «Io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che avete venduto sulla via verso l’Egitto» (Gen 45,4). Il fatto di dichiararsi fratello fa già comprendere che il delitto dei suoi familiari è assunto in una prospettiva di riconciliazione; Giuseppe infatti rilegge la storia come un evento provvidenziale, come una divina, misteriosa, disposizione da cui è scaturita la vita: «Ora non rattristatevi – dice loro – e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù [non pensate al vostro peccato], perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per farvi vivere. […] Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la vita nella terra, e per farvi vivere per una grande liberazione. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il territorio d’Egitto» (Gen 45,5.7-8). Il trionfo di Giuseppe è interpretato nella sua verità, come l’azione mirabile di Dio che riconduce tutto, anche l’odio criminale, a una manifestazione di bene, così che dalla colpa sgorghi, per miracolo, il frutto stupendo della vita. Giuseppe è salito trionfante sul trono per salvare i fratelli.
Ora è proprio questo che avvenne, in perfezione, quando Gesù si mostrò ai suoi con le piaghe della sua Passione e, senza alcuna parola di condanna, senza alcun accenno di rimprovero per il passato, mostrò loro i segni del suo trionfo per farne l’attestazione dell’amore che redime e salva. Gesù infatti va incontro ai suoi portando la «pace» (Gv 20,19.26), una parola di riconciliazione rivolta a coloro che l’avevano tradito, e con loro rilegge la storia, mostrando la «necessità» della sofferenza (non prodotta dal volere degli uomini, ma voluta misteriosamente dal Padre), perché in essa rifulga la vittoria della misericordia e il prodigioso avvento della divina salvezza. Facendosi riconoscere dai suoi discepoli, il Signore diceva loro quanto li amava, e quanto questo amore era capace di perdonare, guarire e rigenerare la vita.
3) L’ invio. Il segno della ritrovata comunione, il segno della salvezza accordata a coloro che potevano essere vittime del loro peccato e del rimorso che ne consegue, è costituito dall’investire i fratelli dell’incarico di comunicare ad altri il prodigioso evento da loro conosciuto. I fratelli di Giuseppe sono invitati ad andare dal padre Giacobbe a rallegrarlo per il figlio dato per morto e in realtà non solo vivo, ma diventato stupendo principio di vita per tutta la famiglia; e con il padre Giacobbe viene a partecipare della gioia tutto il clan riunificato e rinvigorito dal trionfo del figlio perduto e ora vivente e glorioso (Gen 45,9-13).
Allo stesso modo, alle donne presso il sepolcro il Signore Gesù dice: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che mi vedranno in Galilea» (Mt 28,10). E a Maria di Magdala: «Va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”» (Gv 20,17). La comunione piena con Dio (Padre) è al tempo stesso associata a quella dell’umana fraternità, e da ciò scaturisce il kerygma affidato alla missione apostolica. Il Risorto dona agli inviati il suo spirito di amore, così che i suoi fratelli diventino principio di perdono (Gv 20,22-23) e partano, fino a raggiungere gli estremi confini della terra, ad annunciare, come testimoni, il trionfo salvatore del Cristo, che, morto per amore, è stato reso Signore, principio di salvezza per tutte le genti (Mt 28,19-20).
Questa è la Pasqua del Signore, una meraviglia ai nostri occhi (Sal 118,23), quella nella quale ciò che era adombrato nell’antica storia di fratelli trova il suo luminoso compimento. Una storia che ci raggiunge, ci salva e ci invia. Un evento che è per noi passaggio e vita.
***
THE EXPERIENCE OF THE RISEN
If we question our consciousness with sincerity, we perceive, perhaps not without a shudder of disturbance, that we have no evidence that the Crucifix has returned to life. We would like, therefore, to have been present when Jesus showed himself to his disciples so as to be certain of the resurrection. But no sign, as clear, is able to automatically produce the persevering assent of the heart. Instead, we must listen to the prophetic Word to join the mystery of the Risen Christ in faith. We are introduced to this experience by the liturgical path of the Easter Vigil. In it the Lord meets the community of his brothers to give them birth in forgiveness, and to send them to be witnesses of the joy. The conclusion of the story of Joseph (Genesis 45) helps us to deepen our sense of the salvation visitation of the Risen.