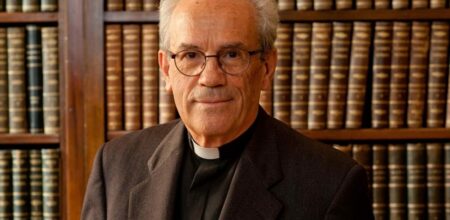|
|
Padre Timothy Radcliffe, che è stato Maestro generale dei domenicani, presentava in questi termini il possibile rapporto tra fede e cultura: «Io sono cresciuto in una subcultura cattolica [che] interpretava l’esistenza e il mondo in termini di gratitudine e benedizione. Noi credevamo in un Dio che ascoltava le nostre preghiere, che ci amava e che nell’ora della nostra morte ci avrebbe fatto andare in paradiso […]. Avevamo una schiera di amici che non erano cattolici e neanche cristiani, ma a tutti appariva evidente che la vita era orientata verso l’eternità. Ora questa subcultura sta in larga misura scomparendo […]. Ritengo che per il cristianesimo l’unica via per crescere sia quella di mantener viva una cultura cristiana vivace, sicura di se stessa e vitale, e allo stesso tempo in interazione dinamica con la cultura contemporanea»[1].
Questo è anche il nostro compito primario come comunità credente: mantenere viva la dimensione culturale della fede cristiana, in particolare il valore decisivo che l’istruzione biblica presenta nei confronti di alcuni gravi problemi del nostro tempo. Non a caso la Sacra Scrittura è stata studiata e commentata per secoli dalle generazioni che ci hanno preceduto, incidendo in maniera profonda su ogni aspetto della storia dell’Europa.
Ma è soprattutto nel nostro tempo, segnato dalla profonda instabilità istituzionale ed economica, dalla crisi di senso, dal fallimento delle grandi ideologie, che la Bibbia continua a stimolare la cultura, il modo di vedere e valutare i problemi della vita di sempre. Perché è in questo confronto «sapienziale» che l’uomo può fare esperienza di Dio.
Il divieto
Nella riflessione sul tema possono accompagnarci alcune parole chiave della Bibbia, parole paradossali, anche fortemente critiche verso certi aspetti della cultura del nostro tempo, ma che sono indispensabili per vivere.
La prima parola è divieto. È la prima grande istruzione che Dio impartisce all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire» (Gen 2,16-17).
Una parola del tutto impopolare. Eppure è una parola indispensabile per vivere. La proibizione di mangiare di quell’albero è la proibizione di voler essere Dio, criterio di ogni cosa. Dio dice all’inizio della storia di ogni uomo: se vuoi vivere, se vuoi gustare la vita, ricordati che sei creatura, che hai dei limiti. Questa è la tua verità di creatura, perché sono i limiti che ti fanno vivere; ma se non li rispetti, ti distruggerai.
È un’istruzione che ha formidabili ricadute culturali. Anzitutto a livello pedagogico e psicologico. La psicologia dello sviluppo riassume le tre tappe fondamentali della crescita mediante tre differenti rinunce all’onnipotenza, al credersi il centro di tutto: la nascita, lo svezzamento, la sconfitta edipica[2]. Sono tre «punti di non ritorno», propri della crescita (nei confronti della condizione prenatale, dell’allattamento, di un legame esclusivo con la madre), indispensabili per entrare nella vita, per diventare uomini e donne.
Alla radice di molte richieste di aiuto psicologico c’è spesso la non accettazione della propria verità di creatura, segnata dal limite e dalla fragilità. Non ci si accetta per come si è, non si accetta il proprio corpo, la propria famiglia di provenienza, la propria storia e personalità, le proprie capacità.
La psicanalista francese Catherine Ternynck, nel libro dal titolo significativo L’ uomo di sabbia, nota che quando una generazione si crede il centro di tutto e disattende il divieto, diventa incapace di vivere: «Da qualche decennio, vediamo i giovani che arrancano ai margini della vita adulta senza giungere a intraprenderla. Sembrano in preda a un’angoscia della soglia che non riescono a oltrepassare»[3].
Le culture di tutti i tempi hanno sempre introdotto il giovane alla vita mediante i riti di iniziazione. Il loro compito – come i sacramenti dell’iniziazione cristiana – era appunto quello di aiutare il nuovo venuto a superare la soglia, a entrare nell’età adulta, acquisendo consapevolezza con l’aggressività, la sofferenza e la morte – in altre parole con la propria fragilità –, espresse concretamente dalla corporeità.
Questi riti, quando vengono disattesi, non scompaiono, ma impazziscono: danno origine alle derive del «branco», ampiamente diffuse nella nostra società. Le violenze delle baby gang, il bullismo maschile e femminile, gli stupri di gruppo, lo sballo del sabato sera, i comportamenti sessuali a rischio, l’assunzione di droga in gruppo, ma anche la pratica del piercing e delle trafitture, dei tatuaggi, l’attrazione verso l’horror e il macabro sono riti di iniziazione impazziti, richieste degenerate dei giovani di prendere contatto con la dimensione della corporeità, della relazione, dell’aggressività, della sofferenza e della morte (del proprio limite di creatura), ma senza che vi sia più un adulto o una comunità capace di accompagnarli. Per questo restano richieste disattese.
Il secondo grave campanello d’allarme della dimenticanza del divieto è simboleggiato da uno strano paradosso: quanto più proclamano l’autonomia e l’indipendenza, il «farsi da sé», tanto più l’uomo e la donna si scoprono dipendenti. «Il termine autonomia furoreggia, eppure non sono mai state osservate come adesso tante personalità dipendenti in età adulta: tossicodipendenza, dipendenza sessuale, dipendenza pornografica, dipendenza da internet, dipendenza affettiva, dipendenza dal gioco, dal lavoro, dall’alcol, dagli acquisti. Oggi tutto è suscettibile di diventare dipendenza»[4].
«Sarete come Dio» (Gen 3,5), aveva suggerito il serpente, toccando evidentemente un tasto sensibile. Ma quando dimentica il divieto, l’uomo smarrisce le sue radici: non diventa Dio, ma diventa «di sabbia». Più cerca di raggiungere la perfezione, più si scopre nudo.
Pensiamo alla cosiddetta «cultura salutista e del benessere», oggi in gran voga. Più si fanno ricerche sulla salute e più ci si scopre malati, incapaci di reggere il peso della vita: «Un’inchiesta del governo inglese ha rilevato che in 10 anni il numero di inglesi che si considerava disabile è cresciuto del 40%. Nella fascia di età tra i 16 e i 19 anni l’aumento era addirittura del 155%! Gli autori dell’indagine concludono che 10 anni sono “troppo pochi per spiegare un reale aumento della disabilità”, ma non sanno dire perché sempre più persone sembrano entusiaste di adottare l’etichetta di disabile […]. Oggi la cultura, con l’esagerazione del ruolo di vittima, porta a “sminuire il sé, con la conseguenza di accentuare la fragilità e la vulnerabilità”»[5].
Nonostante la tecnica e la ricchezza di possibilità, l’uomo continua a sentirsi nudo. Significativo sotto questo punto di vista è l’andamento del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM), considerato la «Bibbia» del professionista della salute mentale. Nella sua prima edizione, del 1952, venivano classificati 106 disturbi, presentati in altrettante pagine. La quarta edizione, del 1994, riportava 300 disturbi in un volume di 900 pagine. Come interpretare questi dati? Nel corso di 40 anni i disturbi sono aumentati, oppure, più sono studiati e più si diffondono?
Ritorna il paradosso di Gen 2,17: riconoscere di essere fragili, di avere dei limiti è, oltre che la nostra verità, la nostra vera forza. Per questo la prima istruzione di Dio è un divieto. La Ternynck concludeva la sua lettura sull’attuale difficoltà a crescere con una domanda: «Chi oggi vieta?». Il divieto, il limite, se posti correttamente, cioè all’interno del dono ricevuto e della stima, consentono di fare esperienza della realtà e dell’altro che, in quanto differente da me, non può essere ridotto a mia immagine e somiglianza.
Il fallimento
Un’altra parola decisiva per la vita viene suggerita da Gen 3: il fallimento. In questo brano la caduta non viene vista come una catastrofe globale: Dio non ritira la sua fiducia, ma continua a dialogare con l’uomo. Riconoscere la fragilità significa anche accettare di fallire, cercandovi un insegnamento.
Anche questa appare come un’istruzione largamente disattesa: la possibilità di sbagliare, di fallire, viene respinta con orrore. Ma in questo modo essa diventa ancora più inquietante, sprattutto nell’età della crescita. Pensiamo alla difficoltà di dialogo tra genitori e insegnanti su questo tema: la possibile rilevazione di problemi o carenze viene rifiutata a priori[6]. Il genitore, di generazione in generazione, trova sempre più arduo riconoscere e accettare le fragilità, i limiti e i fallimenti del figlio, forse perché egli per primo non li ha riconosciuti e accettati. Ma non è coprendo la nudità che si aiuta a crescere.
E chi paga il prezzo di questa pretesa è il più debole. Pensiamo all’aumento impressionante dei suicidi nell’età adolescenziale e giovanile. I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità mostrano un notevole aumento di suicidi in genere negli ultimi 50 anni – più del 60% –, ma, per quanto riguarda gli adolescenti, esso è stato del 400% (da 2,5 a 11,2 su 100.000). Negli Stati Uniti, ogni 90 minuti un adolescente si toglie la vita[7].
Per quale motivo si registra un aumento così rilevante, in particolare in una fascia di età che dovrebbe essere la più aperta alla vita? Una ricerca, realizzata in Italia nel 2009, ipotizzava che la diffusione del suicidio tra gli adolescenti fosse soprattutto legata a un cambiamento di mentalità, che non tollera sconfitte, difetti, incapacità: bisogna essere vincenti a tutti i costi[8]. Questo stile di personalità, se prevalente nel corso dello sviluppo, riflette una preoccupante fragilità interiore: ogni insuccesso – un voto scolastico negativo, la presa in giro dei coetanei, il «no» della persona amata, il rimprovero del genitore – rischia di essere vissuto come una smentita totale del valore di sé, con conseguenze catastrofiche.
Alla base di questo vi è, di nuovo, il tema della fragilità rifiutata, che impedisce di affrontare gli ostacoli e le difficoltà della vita. Volendo risparmiare al ragazzo o alla ragazza ogni difficoltà, li si rende più deboli, incapaci, con il dubbio perenne circa la stima di sé.
Il terzo capitolo del libro della Genesi ricorda la presenza di una ferita originaria, che va riconosciuta perché l’essere umano possa crescere senza paura di fallire. Prendere dimestichezza con tale ferita, in tutte le culture è sempre stato il compito proprio del padre, che segna una tappa differente della vita del bambino, la cui figura privilegiata di riferimento è stata fino a quel momento la madre. È ciò che la psicanalisi chiama «la sconfitta edipica»: «Il padre infligge la prima ferita, affettiva e psicologica, interrompendo la simbiosi con la madre […]; lo ferisce, per renderlo più forte […]: quando verrà la perdita, esperienza non evitabile nella vita umana, essa non lo distruggerà psicologicamente, e spiritualmente. Anzi, egli saprà trarne il succo più prezioso: l’amore. Amore per sé, amore per gli altri: entrambi si temprano nell’esperienza della perdita, non nell’illusoria sicurezza del possesso»[9].
Divieto, ferita, punizione: sono tre parole «impopolari», ma indispensabili per diventare adulti. Christopher Lasch, nel suo studio sul narcisismo, inteso come l’illusione di non avere limiti, riporta un’interessante lettera di un ragazzo di 11 anni circa l’inclinazione del proprio padre a evitargli qualsiasi tipo di punizione: «Mi insegna a giocare [a baseball e] altri sport [e] mi dà tutto quello che può»; ma si rammarica: «Non mi ha mai dato una sberla quando me la meritavo». Commento di Lasch: «Quello che questo bambino sembra voler dire è che il padre non può dargli ciò di cui egli sente di aver bisogno per diventare una persona: il giusto castigo per le sue malefatte. Per delle persone che vivono in una cultura permissiva è sbalorditivo apprendere che una punizione mancata può essere vissuta come una deprivazione. Ma per alcuni bambini è più doloroso sopportare il senso di colpa impuniti che prendere un ceffone»[10].
La Bibbia precisa che la penitenza e l’espiazione sono una modalità di ritorno alla vita, una maniera di rialzarsi dalla caduta, dal male e dalla colpa: sono soprattutto un messaggio di speranza e di riconciliazione offerta. Ciò significa che dal male è possibile uscire, al contrario della colpa negata. Il filosofo Paul Ricœur riassume tutto questo con una frase provocatoria: «La vera punizione è quella che rende felici, ristabilendo l’ordine; la vera punizione ha come risultato la felicità; è il senso del vero paradosso del Gorgia […]: “sfuggire al castigo è peggio che subirlo”»[11].
Quando infatti la colpa viene negata, si tende a dubitare sempre di sé, a vivere le relazioni in modo precario e instabile, cercando in esse un riconoscimento illusorio e irrealistico; anche l’aggressività finisce per diventare qualcosa che il bambino, e più avanti il giovane e l’adulto, non è in grado di gestire.
Anni fa, in un articolo di giornale, è apparsa un’attualizzazione interessante di questo discorso. In una scuola inglese, tra le attività didattiche, veniva ricordata anche un’iniziativa paradossale, la «Settimana del fallimento»: «Il modello di riferimento è l’allenamento sportivo che procede per prove ed errori nella convinzione che anche il fallimento, se accettato ed elaborato, è parte integrante del percorso verso il miglior risultato possibile, mai definitivamente raggiunto. Spesso invece la difesa strenua della sicurezza, la paura di sbagliare, l’incapacità di accettare e valorizzare i propri errori bloccano l’esposizione al rischio, rendendo i ragazzi conformisti e passivi […]. Alla discussione partecipano i genitori e vengono proiettati video dove personaggi di successo raccontano quanto hanno imparato dai loro errori»[12].
L’autrice dell’articolo auspicava che una simile iniziativa, capace di individuare una valenza educativa anche nell’esperienza fallimentare, potesse trovare attuazione anche in altri Paesi, come l’Italia, perché la spinta alla perfezione e al successo potesse essere bilanciata da una realistica presa di contatto con le proprie fragilità: «In una scuola sempre più competitiva (basti pensare alle selezioni per l’accesso ai migliori licei, oltre che all’università) i ragazzi sono sollecitati dalle famiglie e dagli insegnanti a rendere sempre al massimo, senza ammettere alcuna possibilità d’insufficienza e di errore. Le frustrazioni, se commisurate alla maturità dei ragazzi, aiutano a sviluppare anticorpi contro la disperazione. Pensare che il percorso evolutivo possa svolgersi per intero sotto il segno della felicità è un’illusione pericolosa, perché non esistono assicurazioni in proposito. Prima o poi viene il momento di fare delle scelte che comportano dei rischi, ed evitarle può servire a sopravvivere, ma non a vivere. Invece i nostri bambini crescono al tempo stesso iperprotetti dalle frustrazioni e ipersollecitati al successo: gli si chiede di eccellere nelle materie scolastiche, nelle attività sportive, nelle espressioni artistiche, nelle relazioni sociali, confermando il figlio ideale a scapito di quello reale. Ammettere che possa sbagliare richiede, con beneficio di tutti, che l’educatore rinunci alla perfezione, riconosca i propri limiti e, superando il desiderio di onnipotenza, affidi progressivamente ai giovani la responsabilità della loro vita»[13].
Tutto ciò costituisce, nel contesto del presente discorso, un commento molto stimolante e concreto all’istruzione del libro della Genesi. Colui che pone il divieto viene a ricordare «ciò che la nostra epoca sembra aver dimenticato: la felicità del limite consentito»[14]. Compito fondamentale della madre e del padre, che costituiscono un simbolo potente del Padre celeste, è ripresentare ai propri figli questo insegnamento della Genesi: acquisire consapevolezza e riconciliarsi con il proprio limite, condizione essenziale per diventare adulti e portare frutto nella propria vita.
La dimensione religiosa riveste sotto questo aspetto un ruolo indispensabile e irrinunciabile. Purtroppo, nella maggior parte delle famiglie italiane degli ultimi trent’anni i genitori – per una serie di motivi che sarebbe interessante analizzare – si sono sempre meno preoccupati di educare alla fede i loro figli, preferendo assicurare loro un benessere materiale, ma fittizio: «Sono stati cresciuti con brioche e cartoni animati e nessuno li ha aiutati a sviluppare alcun senso per l’importanza della preghiera, della lettura della Bibbia e per una vita all’interno di una comunità confessante. I loro stessi genitori hanno preso le distanze da tutto ciò»[15]. E questo con gravi conseguenze dal punto di vista educativo, non solo sotto il profilo della pratica religiosa.
La narrazione e i sentimenti
La cultura biblica non ama i concetti, le idee, i dibattiti, ma invita ad ascoltare il cuore (che è la sede non solo delle emozioni, ma anche delle valutazioni, delle decisioni, dei desideri). La Bibbia presenta il mistero della vita non in modo astratto e teorico, ma mediante narrazioni, da cui emergono le domande fondamentali: che senso ha tutto questo? Perché c’è il male, la morte, la violenza sessuale, i disastri ambientali?
Affrontare tali questioni, inevitabili per l’essere umano, significa istituire un dialogo tra il mondo del testo e il mondo del lettore. Questo dialogo, più che offrire risposte, coinvolge, suscita sentimenti, presenta un possibile percorso. Anche a livello individuale, l’uomo si conosce, comprende chi è e che cosa sta cercando (anche in sede terapeutica), quando inizia a raccontarsi ad altri.
Come osserva Umberto Galimberti, alla base dell’attuale disagio giovanile c’è soprattutto l’assenza di narrazioni, capaci di dare senso e ordine agli avvenimenti, individuando desideri e discrepanze. Oggi molti giovani stanno male, ma non riescono neppure a dare un nome al loro malessere, perché non hanno più a loro disposizione narrazioni che possano offrire loro un’identità e una lettura della vita; si trovano in un insieme sparpagliato di esperienze, avvenimenti, senza un progetto unificatore. I sentimenti, i desideri non esistono in natura, non sono un dato biologico, ma vengono conosciuti e compresi confrontandosi con narrazioni, con le vicende e i modelli in esse presentati. I sentimenti sono un elemento di verità del nostro rapporto con noi stessi, con gli altri e con Dio. Sono anche un campanello di allarme di un disagio.
Un filosofo e uno psichiatra francesi, Miguel Benasayag e Gérard Schmit, in un libro che ha avuto grande risonanza anche in Italia, L’ epoca delle passioni tristi, riflettevano sull’aumento preoccupante di richieste di aiuto psicologico da parte di giovani e giovanissimi in Francia negli ultimi anni. Esse sono il segno di una grave sofferenza interiore, dovuta a un disagio profondo e complesso che non può essere risolto da una tecnica o da un farmaco[16]. Le «passioni tristi» esprimono un dolore esistenziale, «non sono il dolore o il pianto, ma l’impotenza, la disgregazione e la mancanza di senso, che fanno della crisi attuale qualcosa di diverso dalle altre […]; si tratta di una crisi dei fondamenti stessi della nostra civiltà»[17].
La sapienza biblica invita a tenere strettamente uniti conoscenza e affetti, cuore, intelligenza e fede: in quella sede si trova la possibile conferma delle nostre valutazioni, scelte e decisioni. Si pensi al rilievo dato dai Vangeli ai sentimenti di fronte a un avvenimento, come la gioia dei magi quando vedono la stella (cfr Mt 2,10), la tristezza del giovane ricco di fronte alla proposta di lasciare tutto e seguire il Signore (cfr Lc 18,23), la paura di Pilato nel sapere che Gesù si è proclamato Figlio di Dio (cfr Gv 19,8). I discepoli di Emmaus, ripensando all’incontro avuto con il Signore, inizialmente non riconosciuto, restano colpiti soprattutto dalle risonanze affettive delle sue parole: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi?» (Lc 24,32).
Il numero accresciuto di informazioni a disposizione, pur essendo un bene prezioso, non rende di per sé più facile e sicura la decisione: il criterio è un altro, di tipo relazionale e affettivo. Pensiamo a ciò che accade proprio ai magi. Da una parte, essi sono del tutto sprovveduti sul piano della conoscenza: non conoscono le Scritture, la lingua e le consuetudini del posto; sono ingenui, fanno errori anche gravi, come chiedere aiuto a Erode, animato da ben altre intenzioni. Ma tutto ciò non costituisce un ostacolo insormontabile per la ricerca di Dio: in essi è presente la cosa più importante, il desiderio di trovare il Signore, e la disponibilità a intraprendere un cammino. Il brano, non a caso, li raffigura come gli unici personaggi in movimento. Tutto il resto – mancanza di conoscenza, incapacità, errori di valutazione – viene in secondo piano.
Questo brano dice al lettore che è possibile trovare il Signore seguendo le tre «s» che caratterizzano la ricerca dei magi: stella / Scrittura / sentimenti; il libro della natura, la parola di Dio, la conoscenza di sé. Sono tre segni che possono essere letti e compresi all’interno di una narrazione, all’interno della storia della propria vita. Chiunque ha il coraggio di scendere con onestà nella profondità dei propri sentimenti può trovarvi sia il credente sia il non credente, da ascoltare e con cui dialogare.
Significativa in proposito è questa considerazione fatta dal card. Carlo Maria Martini quando ha inaugurato la serie di conferenze La cattedra dei non credenti: «Il non credente che è in me inquieta il credente che è in me e viceversa […]. Ritengo che, ai nostri tempi, la presenza di non credenti che con personale sincerità si dichiarano tali, e la presenza di credenti che hanno la pazienza di voler rientrare in se stessi, possa essere molto utile agli uni e agli altri, perché stimola ciascuno di noi a seguire meglio il suo cammino verso l’autenticità. Compiere insieme questo esercizio, senza difese e con radicale onestà, potrà inoltre risultare utile a una società che ha paura di guardarsi dentro e che rischia di vivere nell’insincerità e nella scontentezza»[18].
Il dialogo
Da qui l’ultima grande parola: il dialogo. La Bibbia ci presenta sempre, in tutta la sua narrazione, un Dio circondato da gente che, per lo più, sembra incapace di capirlo. Pensiamo alla vicenda di Gesù e a quella peculiare modalità culturale con cui egli parla del mistero di Dio che è la parabola. Essa, se da un lato incuriosisce, dall’altro sconcerta, perché è un modo di affrontare i problemi agli antipodi dello slogan: vi troviamo la narrazione delle vicende quotidiane, e insieme l’invito a entrare in un’altra modalità di pensiero, di vivere e vedere le cose.
Ma, soprattutto, nella parabola i personaggi dialogano tra loro, molto spesso anche litigano: possiamo notare le veementi contestazioni del figlio maggiore, degli operai della prima ora o, in modo più diplomatico, del servo fannullone. Il loro pensiero viene riportato senza caricature: le parabole mostrano il dramma di queste persone, che non capiscono l’operato del padre, del padrone, ne hanno paura e lo respingono.
Ma queste narrazioni presentano nello stesso tempo la vicenda del narratore: il dialogo tra i personaggi della parabola riflette la situazione di Gesù e dei suoi interlocutori. E insieme esse rivelano uno stile, una maniera di affrontare le incomprensioni e i conflitti. Di fronte a chi rifiuta la sua proposta, Gesù non reagisce appellandosi all’incomprensibilità della fede, e neppure tronca la discussione in nome di un’autorità suprema. Egli invita piuttosto a riflettere, perché ha fiducia nelle capacità di ogni uomo di poter trovare la risposta: «Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? […] Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda» (Mt 18,12-14); «“Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?”. E [i farisei e i dottori della Legge] non potevano rispondere nulla a queste parole» (Lc 14,5-6); «Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: “Arriva la pioggia”, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: “Farà caldo”, e così accade. Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto?» (Lc 12,54-57).
In queste domande c’è l’invito a una conversione anzitutto culturale nella relazione con Dio, superando visioni magiche, fideistiche o punitive: «Alla vecchia logica contraria a quella di Gesù non viene opposta solo una logica divina incomprensibile all’uomo, un decreto imperscrutabile e basta, ma si entra in dialogo, si cerca di far ragionare»[19].
Questo atteggiamento di dialogo è ugualmente presente nelle parabole, nel personaggio che di volta in volta interpreta il ruolo di Dio: «Il padre […] cerca di convincere il figlio maggiore a entrare anche lui alla festa. Il datore di lavoro non si trincera nella sua insindacabile autorità padronale, ma espone pacatamente le sue ragioni ai contestatori: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro?”. Nessun tuo diritto è stato violato […]. O forse vedi con dispiacere questo mio gesto di generosità, vorresti che chi è rimasto disoccupato faccia la fame, vada via a mani vuote? Il padrone del campo spiega ai lavoranti perché non va sradicata subito la zizzania, col pericolo di tagliare prematuramente anche il grano non ancora cresciuto (Mt 13,29); il re nel condannare il servo infingardo gliene espone per filo e per segno le motivazioni (Mt 25,26; cfr Lc 19,22-23); persino Abramo dall’alto della sua gloria replica cortesemente alle proteste del ricco sprofondato nell’inferno»[20].
Nelle parabole Gesù ci presenta un Dio che dialoga, che non ha timore di affrontare i nostri interrogativi e ci invita a riflettere, a non abbandonare la nostra ragione per fare esperienza di lui, perché ha fiducia nella nostra «capacità di camminare verso la verità»[21]. La tensione rimane; capire la parabola non significa credere, ma può eliminare ostacoli, pregiudizi, può toccare il cuore.
Questa tensione continua di generazione in generazione. È significativo che le parabole si concludano senza riportare la risposta del figlio maggiore, dei servi, degli operai della prima ora: non sappiamo se dopo quel confronto essi abbiano cambiato idea. La conclusione rimane sospesa, perché a questo punto la parabola si rivolge a ciascuno di noi. Il dialogo continua: «E tu, cosa ne pensi?», sembra suggerire il testo.
Il padre continua lungo i secoli a invitare i suoi figli alla festa, rispettando la libertà di ciascuno. Ma non senza farli riflettere. Il confronto con la parola ci trasforma, anche se non risponde ai nostri interrogativi.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2021
Riproduzione riservata
***
THE BIBLE AS A CULTURAL GIFT. A few words for contemporary man
The Bible can be read as a cultural text too; as an invitation to dialogue with the mystery of God that challenges intelligence and reflection. In fact, it offers precious teachings to men of all times, and is capable of shedding light on the fundamental problems of life. The article presents a number of “sapiential words” – from the immense range available – words which at first sight may be disconcerting and unpopular, but which are extremely instructive from a psychological and educational point of view.
***
[1]. T. Radcliffe, Essere cristiani nel XXI secolo. Una spiritualità per il nostro tempo, Brescia, Queriniana, 2011, 19-21.
[2]. Cfr G. Cucci, La crisi dell’adulto. La sindrome di Peter Pan, Assisi (Pg), Cittadella, 2012, 70-81.
[3]. Ch. Ternynck, L’ uomo di sabbia. Individualismo e perdita di sé, Milano, Vita e Pensiero, 2012, 127.
[4]. Ivi. Testo leggermente modificato.
[5]. F. Furedi, Il nuovo conformismo. Troppa psicologia nella vita quotidiana, Milano, Feltrinelli, 2005, 139 s. Cfr D. Wainwright – M. Calnan, «Rethinking the work stress “epidemic”», in European Journal of Public Health 10 (2000) 3.
[6]. Cfr P. Mastrocola, Togliamo il disturbo. Saggio sulla libertà di non studiare, Parma, Guanda, 2011.
[7]. Cfr G. Cucci, «Il suicidio giovanile. Una drammatica realtà del nostro tempo», in Civ. Catt. 2011 II 121-134.
[8]. Cfr G. Pietropolli Charmet – A. Piotti, Uccidersi. Il tentativo di suicidio in adolescenza, Milano, Raffaello Cortina, 2009, 43-45.
[9]. C. Risé, Il padre. L’ assente inaccettabile, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2003, 12 s.
[10]. Ch. Lasch, La cultura del narcisismo, Milano, Bompiani, 2001, 202.
[11]. P. Ricœur, Finitudine e colpa. II. La simbolica del male, Bologna, il Mulino 1970, 292.
[12]. S. Vegetti Finzi, «La scuola inglese che insegna la sconfitta alle sue studentesse», in Corriere della Sera, 7 febbraio 2012.
[13]. Ivi.
[14]. Ch. Ternynck, L’ uomo di sabbia…, cit., 129.
[15]. A. Matteo, La prima generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2010, 45.
[16]. «La medicalizzazione, che tende oggi a monopolizzare la risposta clinica, va proprio in questa direzione. State male? Soffrite? I laboratori farmaceutici propongono di occuparsi in primo luogo del disordine molecolare. Dopo tutto, che cos’è l’essere umano se non un assemblaggio più o meno riuscito di molecole?» (M. Benasayag – G. Schmit, L’ epoca delle passioni tristi, Milano, Feltrinelli, 2005, 11).
[17]. U. Galimberti, L’ ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, ivi, 2007, 28.
[18]. C. M. Martini (ed.), La cattedra dei non credenti, Milano, Rusconi, 1992, 5 s.
[19]. V. Fusco, «Parabola/Parabole», in P. Rossano – G. Ravasi – A. Girlanda (edd.), Nuovo dizionario di teologia biblica, Cinisello Balsamo (Mi), Paoline, 19914, 1092.
[20]. Ivi.
[21]. Ivi, 1094.