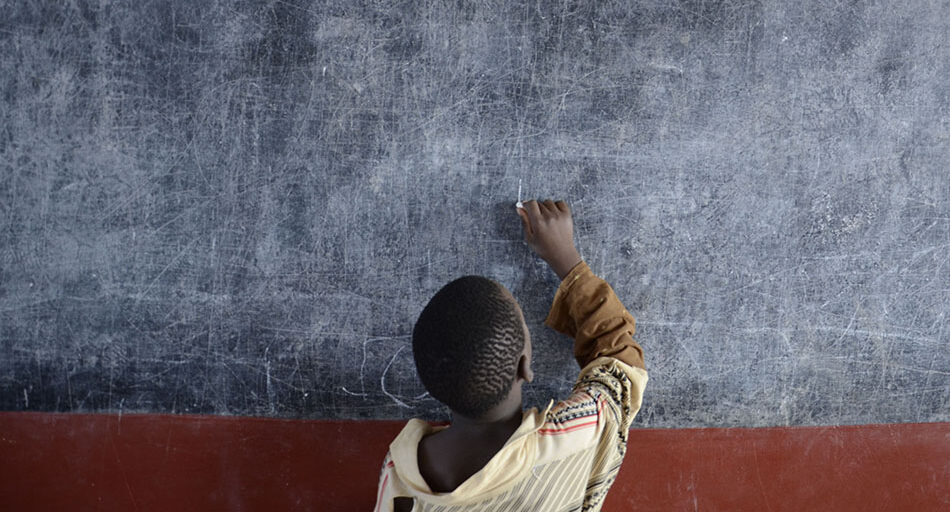
Il 9 maggio 2024 papa Francesco ha pubblicato la bolla Spes non confundit (SnC), in cui annuncia l’avvio del Giubileo 2025 e ne definisce i principali orientamenti spirituali e pastorali. Il 2025 è anche l’ottocentesimo anniversario della stesura del Cantico delle Creature da parte di san Francesco d’Assisi. Il canto del poverello, che chiama il sole «fratello» e la luna «sorella», suona come un appello a una fratellanza universale di cui la Chiesa intende tracciare il cammino con l’Anno giubilare.
Per Francesco, questa coincidenza nel calendario è il richiamo a un’urgenza: raccogliere, finalmente, le enormi sfide poste dalla necessità di ridurre drasticamente gli effetti nocivi dell’attività umana sull’ambiente. Bisogna infatti riconoscere che le forti raccomandazioni dell’enciclica del 2015 Laudato si’ (LS) sono state finora poco seguite, così come l’Accordo di Parigi, siglato lo stesso anno, o i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, pubblicati dalle Nazioni Unite sempre nel 2015. È in questo contesto che il Papa ha invitato le «Nazioni più benestanti» a «condonare i debiti di Paesi che mai potrebbero ripagarli» (SnC 16). Questo invito, sebbene echeggi certamente la più antica tradizione biblica (cfr Es 23,10-11) e le azioni di successo di san Giovanni Paolo II negli anni Novanta del secolo scorso[1], non manca di sollevare interrogativi nel mondo degli affari: è ragionevole cancellare i debiti contratti dagli Stati? Chi lavora duro per ripagare i propri debiti o prestare i propri risparmi non sarebbe vittima di un’ingiustizia intollerabile? È solo un pio desiderio che confonde la carità individuale del cuore con le sane logiche finanziarie internazionali?
Cercheremo di mostrare che, se ben concepita, si tratta al contrario di una soluzione ragionevole per rispondere alle gigantesche sfide ambientali, economiche, finanziarie e sociali che ci riguardano. Sforziamoci di capire questo paradosso, che si scontra in pieno con l’apparente buonsenso di una gestione da «padre di famiglia», a noi così consueta.
Il contesto ambientale ed ecclesiale
Le emissioni globali di carbonio provenienti da combustibili fossili hanno raggiunto livelli record nel 2024[2]. Ormai da diversi anni le proiezioni stimano che la soglia di +1,5oC di aumento della temperatura media sulla superficie terrestre sarà raggiunta, quasi di sicuro, nel decennio 2030-2040, e che sarà difficilissimo non varcare la soglia di +2oC al più tardi entro la metà del secolo. Il costo dell’inazione promette di essere devastante, come mostra il rapporto del Gruppo svizzero Swiss Re, uno dei principali fornitori mondiali di riassicurazione[3].
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento
















