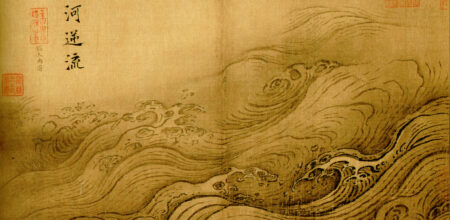Celebrato soprattutto come teorico del liberalismo economico, Adam Smith (1723-90) ha in realtà offerto contributi importanti anche in sede filosofica, soprattutto per la morale[1]. È ritenuto il padre della moderna economia politica, teorizzando la libera concorrenza come condizione necessaria per la qualità e ricchezza di una nazione. Una convinzione che trova le sue radici nella sua vicenda biografica. Frequentando l’università di Oxford, Smith rimase deluso dalla bassa qualità della proposta accademica, a differenza delle università scozzesi da lui frequentate negli anni precedenti. Per lui la ragione si trovava nel fatto che i professori delle università inglesi venivano pagati indipendentemente dalla qualità della loro offerta didattica, senza tener conto della capacità di appassionare gli studenti.
La sua biografia rivela anche un percorso formativo estremamente ricco e variegato: egli inizia la sua avventura intellettuale come professore di retorica e filosofia morale, studia l’astronomia, l’origine del linguaggio e solo in seguito si dedica all’economia. Un percorso mostrato anche dalla data di pubblicazione delle uniche due opere apparse mentre era in vita: Teoria dei sentimenti morali (1759) precedette di quasi vent’anni, ed ebbe un successo altrettanto rilevante – sei edizioni al momento della morte di Smith – dell’opera che lo ha reso famoso, La ricchezza delle nazioni (1776).
L’interesse per l’economia, già presente nei corsi all’università di Glasgow, trova un notevole incremento grazie alla nomina a precettore e successivamente commissario delle dogane per la città di Edimburgo da parte di Charles Townshend, che aveva letto con entusiasmo la Teoria dei sentimenti morali. Questo consentì a Smith una soddisfacente stabilità economica e la possibilità di intraprendere viaggi in tutta Europa, in particolare in Italia e in Francia, dove entrò in contatto con i protagonisti dell’Enciclopedia, soprattutto François-Marie Arouet Voltaire, Jean-Baptiste Le Rond d’Alambert, e i teorici della fisiocrazia François Quesnay e Jacques Turgot. Per quanto riguarda l’Italia, frequentò l’abate Antonio Genovesi, primo docente di economia politica, e l’abate Ferdinando Galiani, autore del celebre trattato Della moneta (1751).
«Teoria dei sentimenti morali»
Successore di Francis Hutcheson alla cattedra di filosofia morale di Glasgow, Smith si confronta inizialmente con la prospettiva scettica di Hume, riformulandola su basi più complesse. Da entrambi riprende l’importanza dei sentimenti come criterio di valutazione dell’agire. Ne fa fede il titolo della sua opera Teoria dei sentimenti morali, in cui sentimenti e immaginazione consentono di dare unità all’esperienza, la cui garanzia è posta in una nozione (Dio) capace di dare risposta all’insidia del dubbio e
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento