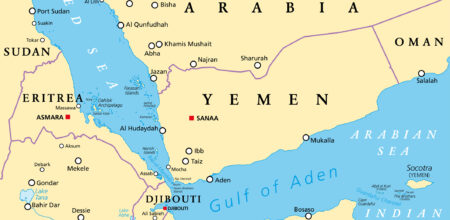|
|
«Coloro che sanno leggere leggono due volte»: questa frase lapidaria del poeta attico Menandro può rendere in maniera efficace l’intento del libro. Più che come una storia della lettura, esso si presenta infatti come un elogio della lettura, un invito a gustarne il valore e la capacità di incidere nella vita in un modo unico. L’A. lo sperimentò in prima persona quando, ancora ragazzo, ebbe la fortuna di lavorare in una libreria e incontrarvi Jorge Luis Borges, ormai cieco, che lo invitò a casa sua perché gli leggesse i libri a lui ormai preclusi e per questo ancora più bramati. Manguel accettò con gioia: «In quel salotto, sotto un’incisione di Piranesi di rovine circolari romane, lessi Kipling, Stevenson, Henry James, molte voci dell’enciclopedia tedesca Brockhaus, versi del Marino, di Enrique Banchs, di Heine (ma questi li sapeva a memoria, tanto che appena cominciavo a leggere la sua voce proseguiva recitando)» (p. 45).
I capitoli del libro entrano in merito alle varie modalità con le quali la lettura può essere vissuta; ad alta voce per altri, come per Borges, che caratterizzò molti secoli della civiltà umana, quando la cultura era orale e la maggior parte delle persone non sapeva leggere (cfr pp. 141-156), per poi assumere sempre più una modalità interiore, silenziosa (cfr pp. 71-83), e sempre più accessibile al grande pubblico, grazie alla comparsa delle edizioni economiche, come la Penguin (cfr pp. 172-175).
Non mancano anche osservazioni più teoriche riguardanti la lettura: ad esempio, se essa consenta di capire meglio la realtà che descrive. Kafka, parlando con un amico bibliofilo che ne decantava le lodi («Non credo di poter vivere senza libri. Per me sono tutto il mondo»), mostrò invece di essere di parere nettamente contrario: «Un uomo non può approfondire le proprie esperienze attraverso la personalità di un altro. È questo il rapporto tra il mondo e i libri. Si cerca di imprigionare la vita in un libro, come un canarino in una gabbia, ma non è un bene» (p. 122). Per Kafka, il rapporto tra un testo e il suo lettore non è di imitazione, ma di vicendevole integrazione, anzi è il lettore che deve portare a compimento l’opera; forse per questa ragione molti dei suoi scritti rimasero incompiuti.
Un’altra questione che pone la lettura di un testo è il possibile numero delle sue interpretazioni. In effetti la reazione dei lettori mostra le modalità più svariate: «Mia figlia lesse La metamorfosi a tredici anni e la trovò divertente; Gustav Janouch, amico di Kafka, la leggeva come una parabola morale e religiosa; Bertold Brecht come l’opera “dell’unico vero scrittore bolscevico”; il critico ungherese György Luckács come il tipico prodotto di un borghese decadente; Borges come una rielaborazione del paradosso di Zenone». Ma per quanto possa dare libero corso alla fantasia, il ruolo del lettore rimane sempre limitato: «L’autorità del lettore non è illimitata. “I limiti dell’interpretazione”, dice Umberto Eco con molto senso pratico, “coincidono con i diritti del testo”» (p. 124).
La lettura è stata considerata come evasione da una condizione di vita troppo angusta, offrendo la possibilità di visitare mondi sconosciuti e inaccessibili nella vita reale. Per questo è stata spesso giudicata una mera perdita di tempo, o una consolazione a buon mercato. Questo era il rimprovero che Colette si sentiva rivolgere continuamente dalla madre, che detestava i romanzi («Troppe complicazioni, troppe passioni. Nella vita reale la gente ha altre cose per la testa», p. 181). Eppure, proprio nel confronto con un mondo altro si annida la portata sovversiva della lettura.
Il capitolo dedicato alla proibizione della lettura mostra quanto un tale atto possa essere rivoluzionario. Quando nel 1660 il re Carlo II d’Inghilterra promulgò un decreto per incoraggiare tutti i sudditi del Regno a imparare a leggere la Bibbia, incontrò le opposizioni più forti nelle colonie americane, perché i proprietari di schiavi temevano che così gli afroamericani potessero leggere qualunque cosa e avanzare richieste di liberazione. Per questo furono emanate severe leggi, rimaste in vigore fino alla metà del XIX secolo, che proibivano loro di imparare a leggere e a scrivere, sotto pena di morte. Tutto ciò non distolse affatto gli schiavi dalla lettura, che intrapresero di nascosto per secoli, essendo disposti per essa a mettere a repentaglio la loro vita: «La novantenne Belle Myers Carothers raccontò di aver imparato a leggere facendo da bambinaia al figlio del proprietario della piantagione che giocava con i cubi recanti le lettere dell’alfabeto. Quando il padrone se ne accorse, la prese a calci. Ma lei non desistette, studiando in segreto sia con i cubi sia su un sillabario. Un giorno disse: “Mi capitò in mano una raccolta di inni religiosi […] e riuscii a leggere un titolo. Ero così felice di aver imparato che corsi a dirlo a tutti gli altri schiavi”» (p. 312).
La lettura come luogo privilegiato di riscatto sociale, e insieme espressione più alta della dignità umana.