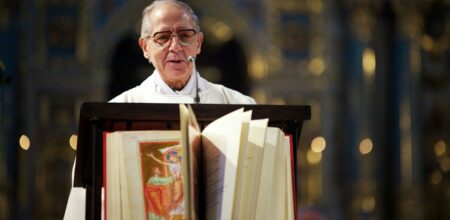|
|
Prendendo le mosse dalla convinzione che nel cristianesimo delle origini «si trovano i fondamenti dell’identità cristiana ed ecclesiale che dovrebbero costituirne il DNA perennemente valido» (p. 21), il biblista Romano Penna intraprende un’analisi sulla laicità e sul sacerdozio, ponendo particolare attenzione al dato biblico e alla storia delle prime comunità cristiane ed evidenziando molteplici punti di interesse per la riflessione contemporanea, anche grazie ad approfondimenti di tematiche specifiche, come nel caso della prospettiva teologica del «Dio debole» di Bonhoeffer.
Il percorso è suddiviso in quattro capitoli: inizia mostrando il rapporto tra cristianesimo e le altre religioni; si concentra poi sul sacerdozio nel mondo greco-romano e in quello ebraico; passa quindi al tema della laicità nelle prime comunità cristiane; e termina trattando il sacerdozio nel cristianesimo degli inizi.
Come la figura storica di Gesù è quella di un laico impegnato e la sua sacerdotalità è frutto della fede pasquale, così pure il movimento post-pasquale è caratterizzato dalla dimensione laicale. Laici erano non soltanto i Dodici, ma anche i collaboratori – con l’eccezione di Barnaba – e le varie figure femminili. Per Paolo, i battezzati non soltanto sono tutti laici, ma sono anche tutti «santi», considerando così la santità non come il frutto di un personale sforzo etico, ma come status cristiano, come dono libero e gratuito di Dio.
I ministeri nella Chiesa delle origini vengono dunque a definirsi come frutto dei carismi. Come conseguenza della molteplicità dei carismi, anche i ministeri nelle prime comunità erano vari. La distinzione tra stato laicale e sacerdotale non compare nei testi cristiani più antichi, e neppure in quelli normativi, nei quali si trova invece l’immagine di una comunità raffigurata come corpo, come un’unità nella molteplicità dei ministeri. Allo stesso modo, le prime comunità cristiane non conoscevano ministeri di tipo sacerdotale. Ciò che le caratterizzava era la centralità di una vita comunionale-agapica, e non tanto la prassi cultuale.
Il termine «laico» non compare nel canone anticotestamentario, e neppure nel Nuovo Testamento. Questa categoria ecclesiale comincia a emergere dopo il II secolo, in maniera parallela al processo di istituzionalizzazione del cristianesimo. Negli scritti neotestamentari si rivela piuttosto l’unico sacerdozio di Cristo, il quale ha una doppia ricaduta: la prima sul piano oggettivo dell’essere, per cui la comunità ecclesiale nel suo insieme acquista un’inedita dimensione sacerdotale; la seconda a livello del singolo battezzato, che viene investito di un sacerdozio individuale. «Si verifica così un vero paradosso, secondo cui nella chiesa non c’è nessun laico, poiché tutti sono sacerdoti» (p. 180). Questa affermazione è legittima sul piano dell’essere, ma non su quello delle funzioni, secondo il quale «laico» è colui o colei che non ha responsabilità pastorali.
La laicità viene a delinearsi come un elemento connaturato all’uomo, frutto di una visione secolarizzata, di un mondo che la tradizione giudeo-cristiana ha desacralizzato. La figura pagana del sacerdote come di colui che compie il sacrificio rituale è stata profondamente trasformata dal sacerdote per eccellenza, Gesù Cristo. Quindi, la laicità si combina con un tipo inedito di sacerdotalità, che consiste in un peculiare ministero svolto all’interno della comunità dei credenti con il fine di mediazione e di guida. In questo modo le due figure diventano partecipi dell’unico sacerdozio.
Il termine «sacerdote», però, ha acquisito con il tempo un significato diverso, indicando una parte precisa della comunità, ovvero quella dei pastori. La pastoralità specifica del ministero ordinato è la chiamata a realizzare l’unità sacerdotale della comunità, in particolare attraverso la Parola e l’esperienza vissuta.
ROMANO PENNA
Un solo corpo. Laicità e sacerdozio nel cristianesimo delle origini
Roma, Carocci, 2020, 248, € 23,00.