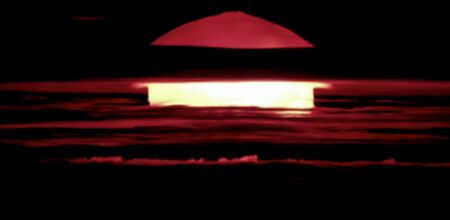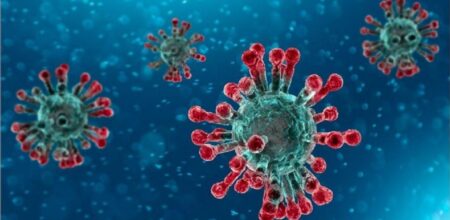|
|
«Ma il Signore Dio non è morto. E non lo è neppure Cristo. Fino a quando il muschio continuerà a crescere sui muri di cemento, Dio veglierà su di noi. Dante ha collocato Francesca nell’inferno, ma solo perché un giorno possa essere salvata dalle fiamme. Chi si pentirà anche solo una volta o chi vivrà anche un solo bell’istante potrà senza dubbio godere della vita eterna» (p. 140). Questo strano incontro tra visionarietà, lettura dantesca e teologia «personale» non è frutto della fantasia di un letterato o di un mistico dell’Occidente, magari a contatto con le visioni di William Blake o le riletture esoteriche di Yeats: è invece una delle riflessioni del grande scrittore giapponese Akutagawa Ryūnosuke (1892-1927), contenute in Lucifero e altri racconti.
Si tratta di una raccolta di storie e di pensieri che hanno come oggetto l’arrivo e il propagarsi del cristianesimo in Giappone tra il 1548 e il 1639, anno della definitiva espulsione dei missionari gesuiti. Akutagawa rappresenta al tempo stesso la reazione delle antiche religioni e il fascino che la nuova fede esercita su molti giapponesi, intellettuali e non. E qui si sente la presenza della letteratura, di tutte le latitudini, in un autore sensibile e colto come Akutagawa, che aveva ben presenti, per esserne stato fin da bambino un avido lettore, Fëdor Dostoevskij, Anatole France, Guy de Maupassant, August Strindberg e lo stesso Dante.
Già dai nomi dei suoi preferiti dell’Occidente emerge l’attenzione dell’autore verso la dimensione interiore, gli abissi dell’anima umana, con il conseguente rifiuto della stagione del naturalismo, visto come eccessivamente appiattito sulla realtà materiale. E questo gli causò, sia ai tempi dell’influsso naturalista sia a quelli dell’impegno ideologico e politico, un radicale isolamento rispetto agli altri scrittori e intellettuali della sua epoca. Il suo suicidio – sul suo petto venne trovata una traduzione in giapponese della Bibbia –, oltre che a ragioni familiari (la mamma fu vittima della follia), va ricondotto anche a questa dimensione di diversità rispetto ai movimenti culturali che provenivano dall’Occidente e che venivano adottati anche in Giappone.
La relativizzazione delle tradizioni e delle convinzioni sociali operata da Akutagawa era già evidente in un suo racconto, Nel bosco, dove è narrata la moltiplicazione e relativizzazione dei punti di vista: ogni testimone racconta in modo diverso, e talvolta opposto, il medesimo episodio. Già da qui è evidente l’influsso della letteratura occidentale, che con Pirandello, ma prima ancora con Shakespeare e Calderón de la Barca, aveva trovato essenziali punti di riferimento.
Il cristianesimo in Oriente è narrato appunto a partire dai vari punti di vista, con tutte le contraddizioni che ne conseguono. Ne Il rapporto di Ogata Ryōsai il miracolo del ritorno in vita della figlia di una povera donna convertitasi al cristianesimo, e per questo emarginata, viene visto dagli altri – con un rovesciamento radicale dei ruoli – come la prova che «il cristianesimo è una dottrina diabolica» (p. 25). In Morte di un cristiano il sacrificio di un giovane fatto segno ingiustamente al disprezzo della gente viene considerato alla fine un esempio che «rende la vita degna di essere vissuta» (p. 49). La stessa presenza del demoniaco – come nel racconto che dà il titolo all’intero libro –, viene vista come la persistenza dello spirito del luogo e delle sue antiche divinità, che profetizzano orgogliosamente la vittoria finale del pantheon giapponese, capace di rendere del tutto autoctone le divinità venute dalla Cina prima e dall’Occidente poi.
Questa sorta di gioco degli specchi però non è un divertimento fine a se stesso. Nelle due riflessioni poste alla fine del libro Akutagawa approfondisce l’interpretazione, fatta da un orientale colto, della religione portata dai padri gesuiti: Gesù è ai suoi occhi un «giornalista», che per noi può equivalere a un narratore e propugnatore di nuove verità, o un «bohémien che predicava “non affannatevi per il domani”». Il che potrebbe sembrarci un travisamento, se non fosse che anche noi dovremmo sforzarci di interpretare quelle parole alla luce di un linguaggio che tenta di tradurre, negli anni Dieci e Venti del Novecento, codici che ai nostri occhi si sono diversificati nel corso dei millenni.
Il gioco degli specchi si ferma a un certo punto, perché quel «giornalismo di Cristo è riuscito a consolare i poveri e gli schiavi» (p. 171), fino a toccare gli abissi più impraticabili del cuore umano: «Nessuno di noi, proprio come i viandanti in cammino verso Emmaus, potrà fare a meno di cercare Cristo, l’uomo che ha acceso i nostri cuori» (ivi).
AKUTAGAWA RYŪNOSUKE
Lucifero e altri racconti
Torino, Lindau, 2019, 208, € 19,50.