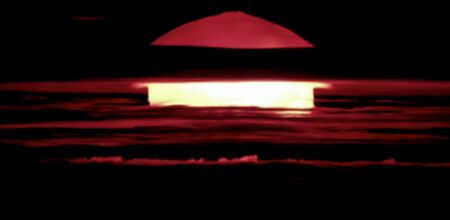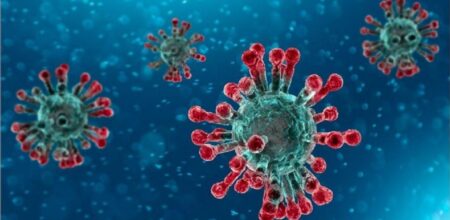|
|
In questo volume l’autore intende presentare qualcosa di originale e, al tempo stesso, attuale. Vannino Chiti, il cui curriculum non si ferma solo al ruolo di politico e amministratore a livello locale e nazionale, è uno studioso del movimento cattolico ed è attento al dialogo interreligioso. Egli offre al lettore sei capitoli di riflessioni su tematiche religiose, lasciando spazio – nell’ultima parte del libro – ai contributi di Sumaya Abdel Qader, Vittorio Robiati Bendaud, Simone Siliani e don Armando Zappolini.
Chiti parte dalla necessità di un dialogo che «richieda consapevolezza della propria identità, conoscenza e rispetto degli altri, capacità di ascolto e disponibilità, se convinti, a cambiare le proprie idee» (p. 9), Il dialogo, infatti, ultimamente sembra aver conosciuto un certo declino o, meglio, sembra essere stato archiviato. Appare allora chiaro l’obiettivo dell’autore: «dar vita, per quello che si può, a un dialogo tra religioni, culture, scienza» (p. 10). Così, nei primi due capitoli, oltre alla necessità del dialogo, l’autore ne esprime anche le modalità, insistendo sul confronto e sulla conoscenza reciproca per poter affrontare insieme le sfide del mondo attuale.
Nel terzo capitolo Chiti ricorda che la Chiesa, soprattutto negli ultimi 50 anni, ha dato all’umanità contributi decisivi, in delicate fasi di passaggio storico: ad esempio, nella difesa dei diritti umani, nelle prese di posizione contro la guerra (proclamando che non ci può mai essere una «guerra giusta») e nel dialogo con le altre religioni. Quest’ultimo dev’essere vissuto come «un confronto per conoscersi, individuare ciò che unisce, comprendere ciò che rende diversi» (p. 72). Esso risulta positivo «se sa costruire una proposta comune sui diritti, le libertà fondamentali della persona, l’ecologia e la pace; se promuove l’uguaglianza delle donne» (p. 72).
Una volta che si è compresa l’utilità e la bellezza del dialogo, l’autore passa a esaminare le varie religioni – protestantesimo, ortodossia, comunità evangeliche, ebraismo, islam, induismo e buddismo –, esponendo chiaramente sia le loro caratteristiche fondamentali e il loro sviluppo storico, sia le loro prese di posizione nel mondo attuale.
Il quinto capitolo costituisce il vertice di tutto il libro, perché in esso Chiti esprime la sua idea di «nuovo umanesimo»: «La premura per la persona e per il cosmo [che è l’aspetto fondamentale delle religioni] muove anche la scienza e può costituire […] il principio cardine che regge una collaborazione per il futuro dell’umanità e del pianeta. Conoscere e amare sono inseparabili, se l’obiettivo è quello di realizzare una civiltà più avanzata» (p. 139). Il nuovo umanesimo è uno sviluppo della scienza e dei mezzi a disposizione dell’uomo per migliorare la vita dell’umanità dei giorni nostri e, con essa, salvaguardare il creato. Esso richiede la costruzione di un’etica condivisa, che chiama in causa la nostra responsabilità. «È l’etica che muove una rivoluzione nuova, pacifica e permanente, che costruisce, non distrugge». Ed «è necessario ritrovare anche il senso del mistero, […] “smettere di parlare di Dio e iniziare a parlare con Lui”, per potere, nell’incontro con gli altri, liberare la nostra vita, darle un senso e rendere il mondo più giusto» (p. 148).
Nel sesto capitolo, infine, tre laici e un sacerdote, appartenenti alle tre grandi religioni monoteiste, espongono la propria esperienza di dialogo, di incontro, di studio e di conoscenza dell’altro. Il dialogo non cancella il substrato religioso e sociale della persona, ma, al contrario, lo arricchisce e apre la pista verso una via che, se ben percorsa, condurrà a un futuro di giustizia e di pace per l’intera umanità.
VANNINO CHITI
Le religioni e le sfide del futuro. Per un’etica condivisa fondata sul dialogo
Milano, Guerini e Associati, 2019, 192, € 18,00.