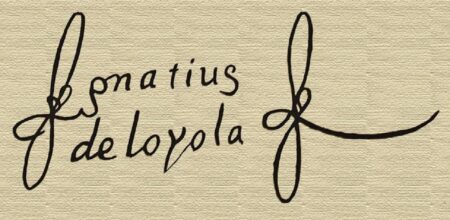|
|
Irriverente, abusata, ma veritiera definizione: «classico» è quello che non va mai fuori catalogo, né diserta la nostra memoria e i nostri affetti. È il caso della prima edizione di tutti i racconti di Flannery O’Connor (1971) – compresi quelli che saranno parte dei suoi due romanzi, con la prefazione del suo famoso editore, Robert Giroux, e la splendida copertina di June Glasson, raffigurante un pavone, animale a cui la scrittrice era molto affezionata –, da cui questa ben curata edizione italiana trae 12 tra i racconti più memorabili.
Saggiamente, la traduttrice Gaja Cenciarelli non scende a compromessi con l’intraducibile slang del Sud, la sua sintassi scorciata, i suoi colloquialismi ruvidi e foneticamente non restituibili, adottando invece lo stesso nitore della lingua impiegata da O’Connor nella narrazione in terza persona, che fa da quinta ai dialoghi delle sue narrazioni.
O’Connor morì nel 1964 a soli 39 anni, dopo pene infinite a causa del lupus. Furono anni di malattia e di resistenza, con una risoluta, fertile e spesso briosa militanza letteraria. Sono più di un migliaio le lettere da lei indirizzate ad amici e scrittori, molte allietate da umorismo e grande vivacità intellettuale, anche nei momenti di maggiore sofferenza fisica e psicologica.
Come scrisse Caroline Gordon, critica letteraria americana: «Le storie della signora O’Connor trattano dei meccanismi della grazia soprannaturale nelle esistenze di uomini e donne ordinari». O, in altri termini, la scrittrice di Savannah presta un’attenzione cognitiva assoluta, degna di Simone Weil, ai momenti tragicamente o comicamente definitori, in cui il destino erompe, cristallizzando il senso o l’assurdo di un’esistenza, il suo precipitare all’inferno o il trarsene in salvo per un movimento inspiegabile, imprevedibile della Grazia.
O’Connor, come Emily Dickinson, non moraleggia mai: getta i suoi personaggi, santi o miserabili che siano, le sue creature malandate e affamate, piene di desiderio e dannate, bigotte o illuminate, su una strada di polvere, sotto i cieli ardenti e silenti di una ruralità desolata, nelle angustie della metropoli. Con brutalità amorosa, ma senza cinismo o, peggio, sentimentalismo, e spesso con esilarante comicità. Un po’ alla Mark Twain – l’inseguimento del tacchino, nel racconto omonimo, ne è un formidabile esempio – e con un istintivo registro del grottesco che la accomuna all’altra grande narratrice del Sud, Carson McCullers. Alfred Kazin ha fatto notare che per O’Connor «le persone sono complete nella loro radicale debolezza, nella loro inevitabile, umana incompiutezza».
Il mezzogiorno americano dei racconti della scrittrice opera un piccolo miracolo, che è il marchio di fabbrica della grande letteratura: il materiale locale grezzo – la lingua, la segregazione razziale e i conflitti di classe, i personaggi, i villaggi, la vita aspra delle campagne e gli animali – si trasfigura in una più vasta condizione umana: una condizione in cui il mistero, i segni ambigui del cielo e le allucinazioni degli uomini, la fede inquieta e primitiva, la fortuna e la sventura giocano un azzardo continuo di caduta e redenzione.
Meglio di ogni citazione, si rimanda al giovanile ardimento con cui O’Connor, ventunenne, si rivolge direttamente a Dio nel suo Journal (pubblicato in Italia nel 2016): «Sei la sottile luna crescente e il mio io è l’ombra della terra che mi impedisce di vedere la luna per intero […]. Ma quello di cui ho paura, caro Dio, è che l’ombra del mio io cresca a tal punto da oscurare tutta la luna, e che io giudichi me stessa dall’ombra che è nulla. Io non Ti conosco, Dio, perché sono in mezzo. Ti prego, aiutami a farmi da parte».
Quel levarsi di torno per far posto alla luce divina è ciò che la scrittrice fa anche con i suoi personaggi, e non tanto per abnegazione quanto per dirompente liberazione creativa. Perché lei seppe, come pochi in quel secolo d’oro delle lettere americane che è stato il Novecento, «toccare l’osso della verità che giaceva affondato nella sua stessa carne» (Kazin).