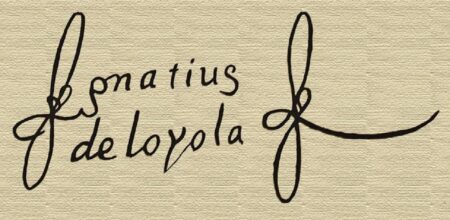|
|
Il dibattito sulla riforma della legge elettorale o costituzionale, e quindi sui metodi di rappresentanza democratica, è comune in molti Paesi, anche occidentali. Questo è un tema molto delicato, da cui dipende la tenuta e il futuro dei moderni sistemi democratici, sempre di più contestati da quelli autoritari o sovranisti.
La vicenda della Legge Acerbo del 1923, che servì a dare una legittimazione elettorale e una maggioranza parlamentare a Mussolini, costituendo un perno della legittimazione giuridica del fascismo in Italia un secolo fa, ci può aiutare a comprendere meglio qual è la posta in gioco di queste complesse questioni che dovrebbero essere fatte oggetto di un ampio dibattito politico, coinvolgendo tutte le componenti della società e della cultura.
Mussolini contro il cattolicesimo politico
Uno dei provvedimenti più importanti che doveva prendere il nuovo capo del governo, Benito Mussolini, era quello della riforma elettorale. Secondo lui, questa doveva essere fatta al più presto, per dare al Paese un nuovo Parlamento più rispondente alle mutate condizioni politiche nazionali. Esso infatti era stato eletto nel 1921 con il sistema proporzionale, già utilizzato nelle elezioni del 1919 e voluto dai socialisti e dal Partito popolare italiano (Ppi) di don Luigi Sturzo, che aveva appoggiato fin dal suo nascere, sebbene con molti distinguo, il nuovo governo Mussolini. Va ricordato che in questo Parlamento, per la prima volta nella storia italiana, i partiti di massa – a detrimento delle formazioni liberali che fino a quel momento avevano governato il Paese – ottennero la grande maggioranza dei rappresentanti. Il partito fascista aveva la rappresentanza di appena 30 deputati, mentre i popolari erano un centinaio, e così pure i socialisti.
Mussolini, ormai vero arbitro del potere, chiese ai dirigenti del Ppi di chiarire la loro linea politica, soprattutto in materia di riforma elettorale. Essi, in un incontro tenutosi il 20 aprile 1923, riconfermarono, con un comunicato firmato dall’on. Stefano Cavazzoni, la piena disponibilità del Ppi a collaborare con il governo, ma non si espressero intorno alla questione elettorale, urgentemente sollecitata da Mussolini. Il 24 aprile Il Popolo d’Italia pubblicava una lettera del capo del governo indirizzata ai dirigenti del Ppi, con la quale egli si dichiarava insoddisfatto dell’ordine del giorno e chiedeva le dimissioni dei ministri popolari. Così finiva la collaborazione del Ppi con Mussolini, mentre questi, da parte sua, ottenne quello che desiderava: avere mano libera nella riscrittura della nuova legge elettorale, che avrebbe dovuto garantire una schiacciante maggioranza di deputati fascisti al Parlamento nazionale, e nello stesso tempo eliminare il Ppi dal governo. Questo avrebbe dovuto assumere la nuova veste di partito di opposizione, compagno di lotta dei socialisti e di tutti gli avversari del regime fascista, ossia di un regime che professava apertamente di voler proteggere gli interessi cattolici nazionali[1], di voler trattare direttamente con la Santa Sede le questioni riguardanti la materia ecclesiastica e di voler dare una definitiva sistemazione al problema della Questione romana. Temi ai quali le gerarchie vaticane erano molto sensibili, sebbene non si fidassero completamente di Mussolini, che fino a quel momento era stato ostile alla Chiesa.
Insomma, l’intransigenza usata da Mussolini nei confronti del Ppi – nel quale militava la maggioranza dei cattolici – sulla questione della riforma elettorale aveva come obiettivo ultimo l’isolamento politico del partito dei cattolici, nel tentativo di sganciarlo dalle potenti protezioni vaticane e alienargli le simpatie dell’elettorato moderato[2]. In effetti, da un colloquio privato tra Mussolini e De Gasperi, alla fine del dicembre 1922, risulta non solo che il nuovo capo del governo era disposto a scendere a compromessi con il Ppi su questa materia, ma anche che la proposta di riforma elettorale da lui avanzata in quell’occasione avrebbe certamente trovato accoglienza tra i popolari[3]. Le cose alla fine andarono diversamente da come prospettato, e non per colpa dell’intransigenza dei popolari. Intanto, in alcune parti del Paese i fascisti, sicuri dell’impunità, si lasciavano andare ad atti di saccheggio delle sedi o sezioni popolari, e, a volte, anche ad atti di anticlericalismo spicciolo, mentre nel Ppi cresceva la distanza tra la destra e il centro.
Inizio della discussione della legge elettorale
Il 25 aprile 1923 il Gran Consiglio del Fascismo stabiliva l’«inderogabile necessità» di modificare la legge elettorale e di adottare il «sistema maggioritario a più vaste circoscrizioni elettorali, secondo cui la lista che otterrà il maggior numero di voti rispetto alle altre sia dichiarata eletta per intero, ed i posti residuati ripartiti proporzionalmente fra le rimanenti liste»[4]. In realtà, furono due le proposte discusse in quella sede. La prima, presentata dall’«intransigente» Farinacci, riproponeva sostanzialmente il vecchio sistema liberale del collegio uninominale, il quale, funzionando poi a livello locale, avrebbe restituito ai ras provinciali quel potere che il «centro» aveva loro tolto. La seconda proposta, presentata dal «moderato» Michele Bianchi, era basata sul sistema maggioritario, e fu quella poi approvata dalla maggioranza del Consiglio. Secondo tale proposta, la lista che avesse raccolto la maggioranza relativa dei suffragi nell’ambito del Collegio unico nazionale avrebbe ottenuto i due terzi dei seggi (356 su 535), mentre i restanti seggi sarebbero stati assegnati proporzionalmente alle altre liste concorrenti. La soglia minima per lo scatto del «premio di maggioranza» era fissata al 25 per cento dei voti validi. I fascisti, dal canto loro, erano sicuri di arrivare a tale soglia anche qualora fossero rimasti soli nella competizione elettorale[5].
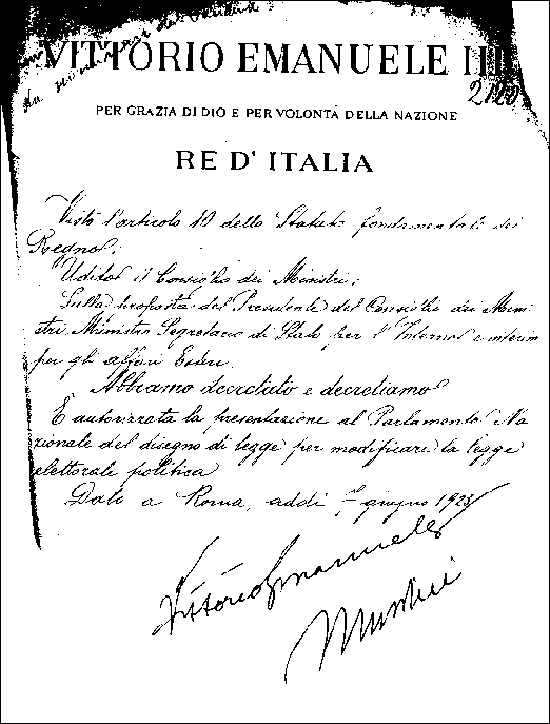
Quindi si procedette secondo la prassi abituale: per la preparazione e presentazione in aula del nuovo progetto di legge elettorale – che poi fu chiamata «Legge Acerbo» dal nome del sottosegretario alla presidenza del Consiglio che aveva tradotto la proposta Bianchi in un progetto legislativo più articolato – fu incaricata una Commissione parlamentare, composta da 18 membri, alla quale parteciparono personalità di grande rilievo politico, fra cui quattro ex presidenti del Consiglio: Giolitti (che ne fu anche il presidente), Orlando, Salandra e Bonomi. A questa Commissione parteciparono rappresentanti di tutti i partiti politici, tra cui due popolari: l’on. Micheli, «il padre della proporzionale», e l’on. De Gasperi. L’approvazione della legge, però, non avendo il governo una maggioranza precostituita alla Camera – perché gli mancava l’appoggio dei popolari, che erano contrari all’adozione del sistema maggioritario –, era affidata semplicemente ai risultati della sua discussione in aula e alla capacità che avrebbe avuto Mussolini di portare dalla sua parte la maggioranza dei deputati: cosa che avvenne, ma non senza difficoltà.
Le vicende che portarono all’approvazione della Legge Acerbo ebbero un effetto devastante per la vita del Ppi e, in particolare, per la sua coesione interna. Da questo scontro politico, che durò alcuni mesi e nel quale il fascismo mise a nudo il suo vero volto violento, rozzo e autoritario, il partito di don Sturzo – a motivo delle continue pressioni esercitate su di esso sia dalla sua componente clerico-fascista, che spingeva per la collaborazione, sia dalle autorità vaticane, che non desideravano uno scontro aperto con il regime – ne uscì indebolito, scompaginato, e per di più intimorito, a motivo delle violenze e intimidazioni subite. Inoltre, questo scontro politico trasformò il Ppi in un vero e proprio partito di opposizione, con tutto ciò che questo significava a quel tempo. Infatti, fu proprio contro di esso, e non più contro la sinistra moderata o massimalista, che si indirizzò la macchina propagandistica del regime, portando lo scontro politico a un livello parossistico e intollerabile per un sistema di convivenza democratica. Per di più, come risulta da una breve nota dell’Osservatore Romano del 2 luglio 1923, i fascisti non esitarono a minacciare, anche attraverso manifesti, una ripresa della campagna anticlericale nel caso in cui la nuova legge elettorale non fosse stata approvata in Parlamento. «Furono prospettati – scrive Gabriele De Rosa – progetti di legge contro le congregazioni religiose e contro le scuole cattoliche. Mussolini avrebbe fatto sapere in Vaticano che se i popolari non avessero approvato la legge, avrebbe fatto occupare dalle squadre fasciste tutte le parrocchie di Roma»[6].
Una violenta campagna denigratoria fu organizzata dalla stampa del regime non soltanto contro il Ppi, ma anche contro il suo segretario politico, don Sturzo, accusato dal Giornale d’Italia del 18 giugno 1923 di essere il promotore di «avventure oscurissime per la nazione» e di voler trascinare il Paese nel caos con «conseguenze imprevedibili». «Ci hanno pensato a questo di là dal Tevere?», si chiedeva il giornale romano, chiamando così in causa il Vaticano. Una settimana dopo, un articolo firmato da mons. Enrico Pucci e pubblicato dal quotidiano cattolico Corriere d’Italia sembrava volesse rispondere a questa domanda del giornale romano. Specificando di non parlare né per conto né per ispirazione della Santa Sede, mons. Pucci invitava don Sturzo a non creare fastidi all’autorità ecclesiastica con la sua opposizione al governo Mussolini.
Violenze fasciste contro don Sturzo e il Ppi
Da parte dei fascisti, la campagna denigratoria contro don Sturzo e il Ppi andò avanti con inaudita violenza e determinazione con il passare dei mesi. Mussolini era certo che le gerarchie vaticane avessero ormai preso le distanze dal partito che fin dall’origine papa Benedetto XV aveva protetto. Questi attacchi sulla stampa nazionale si tradussero immediatamente in violente azioni squadristiche, sia contro le sezioni politiche del Ppi, sia contro i circoli di Azione Cattolica, legati a doppio filo ai popolari, ai quali in realtà fornivano il personale politico più qualificato. Anche molti preti, impegnati in ambito sociale, furono minacciati o selvaggiamente picchiati. Il 23 agosto 1923 l’arciprete di Argenta (Fe), don Giovanni Minzoni, fu assalito da due fascisti e barbaramente ucciso a bastonate. «Niuno – commentò La Civiltà Cattolica – dubitò che il motivo del delitto fosse di carattere politico». Alle proteste dell’arcivescovo di Ravenna Mussolini rispose «manifestando il proprio rincrescimento e assicurando che il Governo agirà con tutta l’energia perché l’autorità possa scoprire e punire esemplarmente gli assassini»[7].
In un memoriale dell’11 aprile 1924, inviato dal cardinale Gasparri al nunzio a Berlino, mons. Eugenio Pacelli, nel quale si chiedeva che venisse denunciato anche all’estero, attraverso la stampa, quanto avveniva in Italia contro i cattolici, si dà un’indicazione precisa delle associazioni cattoliche assalite dai fascisti fino a quella data. Circa le violenze perpetrate nell’anno precedente, si legge: «Aprile: L’Assistente ecclesiastico del circolo di Rocchetta Tanaro viene insultato in pubblica piazza. I soci del circolo cattolico di Pratovecchio sono costretti a togliersi il distintivo. Giugno: Proibizione al parroco di Vicovaro di occuparsi di Azione Cattolica. Violenze contro i soci del circolo giovanile di Pieve di Teco. Agosto: Per vari giorni in Firenze i soci della Gioventù Cattolica e gli esploratori vengono malmenati e schiaffeggiati. Perquisizione e minacce ai soci di Lugo del Mugello. Continue aggressioni e minacce al circolo “S. Colombano” di Lodi. Invasione e devastazione del circolo “C. Ferrini” di Jesi. Invasione e aggressione della federazione pisana. Autunno: Continue devastazioni ai circoli di Udine. Divieto di portare nelle processioni e manifestazioni i vessilli»[8].
A causa del loro carattere ecclesiale, soltanto le opere che rientravano «sotto l’ombrello protettivo dell’Azione Cattolica» – e nel quale sempre più rientreranno opere che precedentemente ne erano escluse – ricevevano le attenzioni della gerarchia, e soltanto le violenze compiute contro di esse venivano ripetutamente denunciate dalla stampa cattolica. Solo per esse la Santa Sede chiedeva insistentemente al governo di intervenire per farle cessare o per far ricercare e punire gli aggressori.
Podcast | SUD SUDAN. «UN CONFLITTO CHE NON È MAI FINITO»
Quattro milioni di sfollati, oltre 350mila morti, fame e povertà. Il Sud Sudan è il paese più giovane del mondo, con una storia già segnata dalle violenze. Oggi lo spettro della guerra torna a far paura, come racconta mons. Christian Carlassare, vescovo della diocesi di Bentiu. Ascolta il podcast
Quale fu l’atteggiamento che il mondo cattolico assunse davanti a questi fatti, al di là della pur necessaria deplorazione morale o denuncia pubblica? In particolare, come interpretò, dal punto di vista politico, queste azioni di violenza fascista, che peraltro, con il passare del tempo, diventavano sempre più frequenti?
Per capire bene come i cattolici interpretarono quanto era accaduto in quei mesi, ci pare illuminante leggere una circolare emanata il 26 luglio 1923 dalla Giunta centrale di Azione Cattolica, nella quale, oltre a denunciare i fatti di violenza, se ne dava una valutazione «politica»: «Se la Giunta avesse la convinzione che essi sono il risultato d’un programma concreto di lotta anticlericale sostenuta dalle Autorità, e senza speranza di ritorno alla vita normale, ai cattolici non rimarrebbe che protestare fieramente contro le autorità protettrici, per poi rinchiudersi nel silenzio e nel dolore. Ma fortunatamente non è così: fino a quando non saremo costretti a questa constatazione dolorosa, e voglia il cielo che non avvenga mai, è dovere della Giunta centrale, delle Giunte diocesane, dei dirigenti di varie organizzazioni cattoliche, di non isterilirsi in facili quanto inutili gesti di protesta, ma di approfittare di ogni mezzo e di ogni occasione per salvaguardare le nostre istituzioni. Il primo mezzo efficace consiste certo nel muovere l’opera delle pubbliche autorità, per averle collaboratrici in quest’azione di difesa»[9]. A questo riguardo, ebbe luogo anche un colloquio tra Mussolini e il presidente nazionale dell’Azione Cattolica, alla quale il capo del governo assicurava protezione.
Questo principio che tende a scindere la responsabilità morale e politica del «centro», cioè del governo e di Mussolini, dagli atti di violenza compiuti nel Paese a opera di «idioti» o di «camerati indisciplinati» finirà per imporsi e guidare l’azione di resistenza della gerarchia cattolica nei confronti delle aggressioni compiute da fascisti anticlericali contro le associazioni cattoliche. Secondo la mentalità dell’epoca, va poi notato che in tali interventi la tutela del libero esercizio dei diritti pubblici da parte delle associazioni cattoliche veniva richiesta all’autorità civile non in base al diritto comune, cioè ai diritti costituzionalmente garantiti e quindi di pertinenza di ogni associazione o gruppo, ma in base a un «privilegio» che si chiedeva venisse concesso all’autorità ecclesiastica in quanto tale.
Questa richiesta era fondata sul presupposto che la Chiesa – essendo, come lo Stato, una «società primaria», e quindi in sé sovrana e autonoma – avesse un diritto originario a godere di alcuni diritti che l’autorità pubblica, se veramente cristiana, le avrebbe dovuto riconoscere, nel senso cioè di rendere operativi diritti che già le appartenevano. Di fatto a quel tempo il Papa e le altre autorità ecclesiastiche levarono la loro voce soltanto per difendere quei diritti della Chiesa che ritenevano violati e di cui si ritenevano i custodi. Secondo la dottrina del tempo, elaborata in un ambiente culturale di «separazione ostile» tra Stato e Chiesa, non era permesso all’autorità ecclesiastica intervenire se non nei casi connessi con la fede o con la morale – anche soltanto per denunciarli – in ambiti diversi dal proprio. Questa teoria fu definitivamente superata soltanto dopo i drammatici fatti della Seconda guerra mondiale, e successivamente trattata e approfondita nel magistero dei Papi più recenti.
La discussione sulla riforma elettorale nel 1923
La discussione sulla riforma elettorale iniziò alla Camera il 10 luglio 1923 e continuò ininterrottamente fino al giorno 15, quando, dopo un memorabile discorso di Mussolini, fu approvato il passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge Acerbo. Per intimorire le opposizioni, Mussolini aveva posto sul disegno di legge la questione di fiducia. In quei giorni di dibattito parlarono tutti i maggiori esponenti dei vari gruppi parlamentari. Contrari alla riforma si mostrarono soprattutto i popolari, i socialisti, sia quelli moderati sia quelli massimalisti, e i democratici liberali. Mussolini, per di guadagnare il voto degli indecisi, disse strategicamente che lasciava alla Camera libertà di dibattito e ampia facoltà di emendare il disegno di legge: «Io – disse in tono persuasivo – voglio ancora collaborare con questa Camera. Io non sono contro la libertà. Io non sono contro gli operai, tanto che desidererei avere dei ministri in rappresentanza degli operai». Il discorso di Mussolini fu molto applaudito anche dai non fascisti e, per l’inatteso tono conciliativo e misurato che egli sapientemente seppe utilizzare, ottenne l’effetto desiderato: portare dalla sua parte gli oppositori politici moderati, ma non fare sostanzialmente nessuna concessione.
Nella mattinata il gruppo popolare aveva deciso di votare la fiducia al governo, per evitare che il Paese precipitasse nel caos e per impedire, o almeno contenere, lo scatenarsi della violenza fascista, ma di respingere il passaggio alla discussione degli articoli. Quando però nel pomeriggio, dopo il discorso del capo del governo, alcuni uomini politici di primo piano, come Amendola e Bonomi, spinsero il loro gruppo parlamentare ad attenuare la loro opposizione, optando per l’astensione, il direttorio popolare, un poco spiazzato dagli ultimi avvenimenti, convocò gli 80 deputati presenti alla Camera e deliberò a maggioranza di voti (41 contro 39) di votare la fiducia al governo e di astenersi nella votazione sul passaggio alla discussione degli articoli.
Riapertasi la seduta alle 20,10, il presidente del gruppo parlamentare popolare, De Gasperi, a nome del suo gruppo, chiese la votazione per divisione dell’ordine del giorno Larussa, su cui il governo aveva posto la questione di fiducia. Sulla prima parte – «La Camera riconfermando la sua fiducia al Governo» – i popolari avrebbero votato a favore; sulla seconda parte – «approva i principii della riforma elettorale e passa alla discussione degli articoli» – si sarebbero invece astenuti. Dopo le dichiarazioni di De Gasperi, chiese la parola l’on. Cavazzoni, il quale affermò, anche «a nome di un gruppo di amici», che era «giusto, equo, dignitoso votare con la fiducia anche il passaggio agli articoli del disegno di legge». Così il gruppo popolare andò al voto profondamente diviso: la maggioranza votò secondo le deliberazioni prese; Cavazzoni e altri votarono secondo le indicazioni governative. Altri sette deputati popolari – tra i quali Cappa, Miglioli, Mauri – si astennero anche sul voto di fiducia al governo. «Sicché la giornata del 15 luglio – commentò La Civiltà Cattolica – potrebbe definirsi, almeno per il gruppo parlamentare del Ppi, una specie di Caporetto, senza che ancor bene si veda se il gruppo smarrito abbia potuto trovare anche lui il suo Piave»[10].
Interessante è la cronaca che il Giorno del 16 luglio 1923 fece di quella memorabile seduta parlamentare: «La discussione alla Camera sulla riforma elettorale si svolge in un ambiente arroventato. L’assemblea è diffidata, sorvegliata, disprezzata. Le “camicie nere” – armate di tutto punto – la circondano, pronte ad agire – cioè ad invaderla dove occorra – ad un cenno del Duce. La stessa Milizia presta servizio al Quirinale, anche se non ha giurato fedeltà al sovrano. La Camera brontola contro la riforma elettorale, mentre il Gran Consiglio fascista, a poca distanza, siede in permanenza».
Dopo queste vicende che spezzarono l’unità del Ppi, il suo gruppo parlamentare riprese in aula a lavorare per migliorare il testo legislativo, ma con scarso risultato. Così si propose di portare da 25 a 35 per cento il quorum minimo richiesto per accedere al «premio di maggioranza», ma la proposta fu respinta. La nuova legge elettorale fu alla fine approvata dalla Camera e dal Senato regio il 18 novembre 1923 nel testo proposto dal governo.
La vicenda ricordata segna uno dei momenti più importanti della vita politica nazionale: quella riforma non solo incoraggiò la tracotanza dei fascisti e dei ras locali, ma diede al nuovo regime illiberale e violento una vernice di apparente legalità.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2024
Riproduzione riservata
***
[1]. Cfr E. Gentile, Storia del fascismo,Roma – Bari, Laterza, 2022, 451.
[2]. Cfr P. Scoppola, La Chiesa e il fascismo. Documenti e interpretazioni,Roma – Bari, Laterza, 1971, 66 s.
[3]. «Infatti, a De Gasperi, che gli chiedeva quale fosse il suo pensiero in materia di riforma elettorale, Mussolini rispose: “Intendo trovare un accordo con i popolari. Infine io sono per il mantenimento del sistema proporzionale, come criterio di massima, e quando dico di volere una maggioranza compatta alla Camera, non è che io a tutti i costi voglia garantire tale maggioranza ad un solo partito. La maggioranza potrà essere formata anche di due o tre gruppi. Quello che voglio evitare è lo spezzettamento e la dosatura di gruppi numerosi che tolgono al Governo ogni forza e ogni omogeneità”. De Gasperi: Con tali criteri credo che l’accordo non sarà difficile. Quando vuoi che se ne discorra più espressamente? Mussolini: Dopo il 15 di gennaio io prenderò le iniziative di tale colloquio e, se fra tanti affari me ne scordassi, tu me lo ricorderai» (G. Sale, Fascismo e Vaticano prima della Conciliazione, Milano, Jaca Book, 2007, 65).
[4]. Cfr M. di Napoli, «La legge Acerbo», in V. De Grazia – S. Luzzatto (edd.), Dizionario del fascismo,Torino, Einaudi, 2002, 6.
[5]. Cfr ivi, 7.
[6]. G. De Rosa, Il Partito popolare italiano, Roma – Bari, Laterza, 1974, 41.
[7]. «Cose italiane», in Civ. Catt. 1923 III 556.
[8]. G. Sale, Fascismo e Vaticano prima della Conciliazione, cit., 70.
[9]. AV 607 bis, 35, 4.
[10]. «Cose italiane», in Civ. Catt. 1923 III 283.