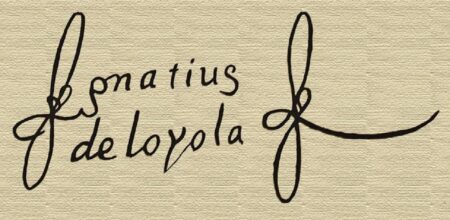|
|
Si dice frequentemente che l’Italia è un Paese di anziani, ed è certamente vero; ma possiamo noi, questa stragrande maggioranza senescente, comprendere l’universo mentale, le attese, i problemi di questa minoranza sofferente, che vive sulla propria pelle le contraddizioni e le incertezze di un sistema che, considerato nel suo complesso, non esisteva nemmeno quando noi anziani avevamo la loro età? Sembra strano, ma la nostra giovinezza è stata tanto diversa dalla loro. Le loro fragilità non sono solamente le nostre: sono di più, e diverse; le loro prospettive sono più tristi delle nostre, essendo noi cresciuti nella nostra maturità durante gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, nell’edonismo del quale si parlava e in un mondo più facilmente intellegibile, meno complicato; il loro mondo interiore ed esteriore solo in parte è comprensibile a partire dalla nostra stessa esperienza.
E questo rende estremamente difficile provare a riflettere sul fatto che i giovani, questi ultimi arrivati sul palcoscenico della vita, fanno fatica a trovare un posto nel mondo, a orientarsi in esso. Privati della fede dallo stesso mondo che li circonda, sembrano smarrirsi: portano il peso, in fondo, della nostra eredità. Noi siamo indotti a riproporre loro le nostre esperienze, i modelli che avevamo noi, giusti o sbagliati che fossero; ma questi erano modelli per quel mondo, il nostro, e non più per il loro, proprio perché tutto è cambiato, molto in fretta, e ci ha condotto in vie che pochissimi potevano prevedere. E ora, sia noi che loro ci troviamo in una impasse: nessuno sa esattamente da che parte andare, e questo getta un cono d’ombra, una sorta di ipoteca su ogni indagine, previsione e programma.
La fine delle grandi narrazioni
La caduta del Muro di Berlino nel 1989 rimane uno spartiacque da cui difficilmente possiamo prescindere. Da esso hanno preso avvio molti processi. Con esso è avvenuto il crollo delle ideologie: gli stessi partiti politici hanno mutato denominazione, per lo meno in Italia, e così istituzioni per loro natura aggreganti hanno finito col perdere il collante che non soltanto li teneva uniti, conferendo un senso più o meno certo alla loro azione, ma anche attirava nuove leve e le spingeva a continuare il lavoro dei loro predecessori. I padri avevano dei figli, e i figli continuavano la loro opera; questa continuità della vita è sommamente importante per creare identità, coesione, fiducia, che invece si sono, generalmente parlando, opacizzate nella nostra contemporaneità, perlomeno in Occidente.
A ciò si aggiungano il crollo della pratica religiosa e il vero e proprio vuoto o salto nella trasmissione della fede, peraltro ben anteriore al 1989. Non è un mistero che per la stragrande maggioranza dei giovani le chiese siano dei non luoghi, nei quali entrano come entrerebbero in un pub, avendo perso ogni cognizione del senso stesso della sacralità. Esse sono luoghi strani, nei quali si fa non si sa bene che cosa. È vero, ed è molto significativo, che in generale non c’è neppure ostilità: lo stesso ateismo «scientifico» e l’anticlericalismo di bandiera sono narrazioni forti, che potevano appartenere alle generazioni precedenti, ma pochi oggi ne sarebbero capaci. Abbiamo creato un mondo non ateo, ma, descrittivamente parlando, «senza Dio» (gottlos), come di fatto egli non abita, in genere, nella letteratura, nel cinema, nei giornali, nella televisione, nelle canzoni o nei social, rappresentazioni del mondo che riflettono appunto la vita di ognuno, cioè come noi ci percepiamo e orientiamo la nostra esistenza. Con tutto questo, non possiamo dimenticare che esistono, anche tra i giovani, numerose storie di autentico recupero della fede: ogni sacerdote che sappia ascoltarli potrebbe raccontare episodi molto confortanti.
Se le associazioni giovanili dei partiti politici, o comunque riferibili a essi, hanno conosciuto una certa contrazione, lo stesso si può dire, mutatis mutandis, del mondo ecclesiale: se già a partire dagli anni Sessanta l’associazionismo cattolico classico ha iniziato a conoscere una forte decrescita, oggi gli stessi movimenti che fino a tempi recenti sembravano costituire una risorsa insperata e, almeno per alcuni, il futuro della Chiesa sembrano essersi riassorbiti secondo modalità più soft del loro pensarsi e proporsi. In fondo, erano tutte espressioni – del mondo laico o cattolico – di un pensiero forte o comunque ben strutturato, che si declinava in riflessioni nutrite di un solido contenuto culturale, sostenute da una scuola robusta e da riferimenti significativi, ormai ampiamente sostituiti dal pensiero debole, non soltanto in senso filosofico, ma anche mediatico: il like nella sua evanescenza ha sostituito l’appartenenza; la piazza e il dibattito sono divenuti virtuali, brevi e per slogan, e si consumano nello spazio di pochi secondi, mentre il tweet sostituisce l’argomentazione. Il prezzo di tutto questo è il moltiplicarsi di infiniti piccoli io narcisistici, gonfiati solo da un’apparenza che copre il nulla.
È vero che «la cultura post-moderna […] esalta l’emozione, lo slogan gridato, stuzzica la suscettibilità e deprime il pensiero riflessivo»[1]. È necessario recuperare il gusto di un’autentica cultura, del pensiero articolato, specchio di una realtà complessa. Questo invito si potrebbe estendere a dimensioni ben più vaste. Lo svolgimento della propria personalità, la crescita, e quindi la gioia, passano anche per questa strada, e gli stessi giovani lo sanno, e lo vogliono: ciò che li attira è il di più, non il di meno, e pensare di più è anticipazione del vivere di più. Abbassare l’asticella, nella scuola come nelle proposte – laiche o ecclesiali – di noi adulti, sembra più comodo, ma è un tradirli, e in fondo un fallire noi stessi come adulti; e dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che è quello che abbiamo fatto. Al contrario, è proprio dell’età giovanile una disposizione all’eroismo, a compiere cose grandi, più grandi delle proposte degli adulti e del loro mondo; Jean Piaget parla addirittura di una «mistica» adolescenziale[2]. Lo slancio vitale che attraversa e trabocca dai loro corpi e dalle loro menti chiede di non essere negato o appiattito: sarebbe invecchiarli precocemente, ovvero ucciderli spiritualmente.
Un mondo sfarinato
Lo stare insieme, proprio dell’uomo e particolarmente dei giovani, pare in buona parte ridimensionato: all’«essere insieme», nel senso forte del termine, si sostituisce semmai lo «stare con», che è qualcosa di meno, perché non supera la prospettiva individualistica, del resto propria del mondo degli adulti. Stiamo vicini, ma non insieme; possiamo fare delle cose, ballare come andare allo stadio, perfino dedicarci al volontariato, o addirittura pregare, ma in fondo, per lo più, rimanendo ognuno per conto proprio, monadi isolate che faticano a uscire dal proprio io. In ogni classe c’è una mailing list, ogni professore ha una sua pagina web nella quale inserisce le sue slides, ma i ragazzi fanno fatica a studiare insieme, e il senso del corpo di una comunità scolastica o accademica è ancora più difficile da percepire. I «bravi ragazzi» sono moltissimi, più di quanto ci si aspetterebbe, ma è estremamente difficile proporre loro esperienze continuative, politiche, culturali o ecclesiali, che siano basate su un impegno comune, e non individuale.
Rifletteremo sul ruolo dei social in questa realtà, ma non possiamo non ricordare il trauma – del quale non è stato ancora possibile misurare l’ampiezza – della pandemia e del lockdown. Le lezioni da remoto sono state indispensabili per garantire la tutela sanitaria, e di fatto sono state un minimum necessario, ma l’isolamento degli uni dagli altri, prolungato per molto tempo e determinato dalla paura, si è sedimentato nelle menti dei ragazzi come la memoria di una guerra, e la ripresa della normalità non ha significato necessariamente per tutti l’uscire da tale prospettiva. Non erano delle classi, se non virtualmente, ma il virtuale non è reale. Erano dei visi, dei volti sullo schermo, e lì apparivano insieme, ma in realtà ognuno era da solo, e l’unificazione sul video era fallace; se poi seguissero o meno le lezioni, se agli esami rispondessero imbeccati o meno, è difficile a dirsi, e ognuno ha semplicemente pensato che non si poteva fare diversamente, chiudendo un occhio, o tutti e due, sulla base di considerazioni più politiche – pur nel senso nobile del termine – che realmente pedagogiche.
Può darsi che questo stato di cose si stia riassorbendo, ma intanto le ferite sono ancora visibili e si aggiungono alla fragilità tipica della loro età e alle ostilità e asprezze della vita che gli adulti hanno loro lasciato. Esiste certamente un problema diffuso di fragilità psicologica, che la pandemia ha inasprito soprattutto nei giovani e nei giovanissimi. In un mondo di isolati, i più deboli sono schiacciati: il bullismo c’è sempre stato, ma oggi assume connotazioni drammatiche. Il naturale desiderio di espansione della propria personalità spinge a crescere, a sviluppare le proprie potenzialità; la scuola in generale, e l’università in particolare, giustamente lo promuovono per mezzo del merito. Tuttavia, una competitività aggressiva e insana non aiuta, ma uccide[3]. In questo senso, non possiamo tacere una realtà drammatica, cioè l’aumento vertiginoso dei suicidi tra gli studenti, perfino nei licei, cosa della quale si è trattato anche nell’incontro dei rettori delle università italiane tenutosi l’anno scorso a Padova. Il modello del successo facile degli influencer impedisce di abitare gli inevitabili insuccessi che la vita riserva a ognuno e, in un contesto, quale il nostro, di esasperato individualismo, blocca la capacità di resilienza.
L’incapacità ad accettare il limite, reggere una bocciatura, un confronto qualche volta a noi sfavorevole, nella scuola come nel lavoro, nel proprio aspetto fisico come nel libretto degli esami, non è un problema dei giovani, ma dei loro genitori, o, per meglio dire, di un mondo che fa dell’essere smart un obbligo, dimenticando ancora la realtà, della quale fa parte anche la debolezza che abitiamo. Abbiamo tolto ai giovani la fede, un senso della vita che va oltre la vita stessa, ma abbiamo anche tolto ad essi il senso della vita in sé stessa, della realtà e delle proporzioni, confondendola con i nostri sogni o deliri. In essi si manifesta il conflitto con il proprio corpo, che parla anche senza dire, nell’anoressia o bulimia, nella geografia disegnata dai tatuaggi e dal piercing: sono tutti messaggi che vengono urlati, e che troppo spesso trovano come risposta il nostro silenzio. Non possiamo affidare la vita dei nostri figli agli psicofarmaci, agli antidepressivi e agli ansiolitici, ormai assunti abbondantemente anche da minorenni, e molto spesso per imitazione: la chimica non risolve i problemi dell’intimo, e crea nuove dipendenze. Di questo non si parla molto, ma è una realtà che ognuno può vedere quotidianamente, anche in quelle che un tempo erano chiamate le «migliori famiglie». Questo non riguarda certamente tutti, ma un numero sempre crescente di giovani, e anche di giovanissimi.
Il mondo degli affetti
Lo sfarinamento del mondo, lo sgretolarsi dei gruppi nell’isolamento dei singoli, la fatica a uscire dal proprio guscio si riverberano e si prolungano nell’esperienza stessa dell’amore. Se i siti di incontri si moltiplicano, è chiaro indice che non ci si incontra davvero: si spera di farlo, ma non ci si riesce, perché, di nuovo, un incontro virtuale non esce dalla falsità di un’identità non reale, ma costruita, di un’immagine del sé che non è la propria verità. Del resto, se i genitori, che sono la nostra prima immagine del mondo e delle sue possibilità, non hanno mantenuto un rapporto costante, ossia non hanno abitato un amore forte e stabile, non è pensabile psicologicamente che i figli lo possano fare.
Podcast | SUD SUDAN. «UN CONFLITTO CHE NON È MAI FINITO»
Quattro milioni di sfollati, oltre 350mila morti, fame e povertà. Il Sud Sudan è il paese più giovane del mondo, con una storia già segnata dalle violenze. Oggi lo spettro della guerra torna a far paura, come racconta mons. Christian Carlassare, vescovo della diocesi di Bentiu. Ascolta il podcast
«Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19): questa affermazione giovannea non è solo teologica, ma anche antropologica. L’amore non si impara da un libro, e non è nemmeno un dovere da adempiere a una certa età, ma lo si apprende solamente avendolo sperimentato sulla propria pelle, e sempre a partire da un altro che lo inizia per primo. Senza questa esperienza, è umanamente impossibile entrare a nostra volta in un rapporto stabile e profondo che duri nelle difficoltà, cioè nell’amore stesso. Questo diventa per troppi un desiderio invincibile, continuamente frustrato dalla presunta impossibilità di realizzarlo davvero: del resto, non è possibile iniziare a pensare in due, quando tutto il nostro mondo ci ha insegnato a pensare solo contando fino a uno, il sé. Dobbiamo ammettere che abbiamo insegnato ai nostri figli di anteporre l’io al noi; ma l’amore è frutto del dimenticarsi, ritrovando nel «due» quello che ognuno ha dovuto perdere per incontrare l’altro. È un mondo intero che mi ha insegnato che il mio tempo, i miei spazi, i miei desideri, le mie ambizioni vengono prima di te, e che quindi tu sei sacrificabile. Vengono in mente queste parole della Scrittura: «Immolarono i loro figli e le loro figlie ai falsi dèi» (Sal 106,37).
Possiamo anche osservare che in tutti i tempi e in tutte le culture è sempre esistito un tempo di frequentazione amorosa, il fidanzamento, distinto dal tempo del matrimonio. Di fatto, questa parola è in gran parte scomparsa, perché la sua stessa realtà quasi non esiste più. Il che è una novità importante, ed è la più profonda ragione per la quale il matrimonio come tale è spostato senza scadenza, oppure non è comunemente desiderato: si fa vita di coppia, pur se la coppia stessa non è ancora verificata e matura. Non va dimenticato, poi, il ruolo che la precarietà lavorativa e l’assenza di sbocchi professionali debitamente remunerati hanno nel favorire tali situazioni.
La rivoluzione sessuale ha insegnato a separare la sessualità dalla fecondità, e questo ha portato inevitabilmente a separarla anche dall’amore: una schizofrenia posta alla base nel nostro io. Più di cinquant’anni dopo – ossia, in prospettiva, nel corso di due generazioni – possiamo davvero capire il senso profondo dell’Humanae vitae, cheallora non era stata compresa e accolta da molti. Ovviamente, è per tutti molto difficile riconoscere di aver sbagliato e ripensare i termini della nostra cultura in senso più personalistico. E così abbiamo consumato il presente e ci troviamo con un futuro a rischio.
La teatralizzazione del mondo: i «social»
I nostri occhi non vedono più la realtà, ma una sua immagine: l’incantesimo già del cinema prima, e della televisione poi – lì ancora più facilmente circoscritto –, si è replicato, ed è questa la differenza epocale che si è prodotta, sdoppiando il mondo in una realtà, da un lato, e in un’immagine, una fantasia, dall’altro. Così la nostra vita è stata proiettata all’interno di quella fantasia stessa, facendoci vivere un’esistenza non reale, ma incantata, a tinte luminose, una favola alla quale tutti siamo ben disposti a credere. Attraverso lo schermo del cellulare siamo continuamente connessi a una galleria di immagini del mondo che non sono il mondo, ma fantasmi, suadenti e appetibili, una sorte di pubblicità non di prodotti, ma della vita come prodotto o bene di consumo, che ci fanno entrare in questo mondo doppio; e così postiamo, e dunque siamo[4].
L’essere si è sdoppiato: esiste un’esistenza opaca, con la realtà a volte a noi sfavorevole, con i nostri corpi non sempre belli come vorremmo, con la nostra vita non sempre vincente; ma esiste un altro mondo, un paradiso, quello che il photoshop e il nickname ci permettono: una ricostruzione, a uso pubblico, della nostra immagine, a questo punto confusa con noi stessi. Ed è interessante che tutti sappiamo che quella non è un’identità, ma ci comportiamo come se lo fosse: si potrebbe dire che viviamo in un mondo als ob, «come se», pur sapendo che non è così. Attraverso lo schermo vediamo il mondo in una luce diversa[5], più appetibile, più dorata, più rosea: il mio panico, la mia solitudine, il mio lavoro da due soldi non esistono più. Esiste oramai soltanto l’«io», divenuto icona di sé stesso, fissato in un’immagine che lo consacra, lo dipinge e (raf)figura in una spiaggia, in una giornata di sole, con un drink[6]: ognuno può diventare un attore, e in un certo senso lo è. Ci si può raffigurare, cioè rappresentarsi a sé stessi, dipingendosi così agli altri, sapendo al tempo stesso di fingere, di diventare una stardi un sistema inventato da noi stessi, dal nostro proprio cinema. È l’equivoco, già denunciato dai pittori del Rinascimento nei loro trattati[7], pingo-fingo:la pittura è una finzione,e non la realtà; assurge a dimensione inusitate, assolutamente nuove nell’Occidente[8].
In questo mondo di monadi isolate è necessario spegnere il pensiero per sopravvivere; accendere il cellulare e connettersi per non sentire il vuoto, perché dietro questo schermo ognuno è al riparo da un mondo indifferente o ostile: i like ci confortano, non c’è nessun nemico, e ognuno può dire quel che vuole, al riparo da ogni conseguenza[9]. Fortunatamente, le stesse icone del mondo giovanile, come Jannik Sinner, spesso mettono in guardia da tale comportamento, anche se i loro appelli sono immediatamente riassorbiti dall’effimero, che strutturalmente costituisce questo mondo. È necessario apprendere l’uso di queste modalità di comunicazione, s’impone un’autentica educazione: il lassez faire lassez passer è distruttivo anche in questo campo e crea molte vittime. A questo riguardo, sembrano molto pertinenti le parole di Luigi Zoja: «Dopo la morte di Dio, la morte del prossimo è la scomparsa della seconda relazione fondamentale dell’uomo. L’uomo cade in una fondamentale solitudine. È un orfano senza precedenti nella storia»[10].
Verso una ricostruzione
Dobbiamo ammettere che il mondo è stato decostruito dall’individualismo, proprio dell’intera cultura occidentale e ora portato a conseguenze davvero radicali nel mondo virtuale in cui viviamo: dalle strutture storiche della nostra società, con istituzioni politiche e sociali sempre meno credute, fino alla messa in questione stessa della famiglia e dei rapporti stabili. Per la prima volta i giovani degli anni Sessanta hanno goduto di una singolare circostanza storica: la delegittimazione dei loro padri e di quanto avevano costruito in nome di un rinnovamento o aggiornamento per il quale tutto era sacrificabile, come se essi fossero i primi ad abitare il mondo e a conferirgli un senso. Molti esperimenti si sono rivelati fallimentari, nel mondo laico come in quello ecclesiale; pochi sembrano aver avuto il coraggio di ammetterlo, e gli errori purtroppo sono stati fatti pagare agli altri. Avendo smarrito così il senso della continuità storica e il tesoro dell’esperienza pregressa, queste persone hanno potuto beneficiare di un prolungamento della stessa vita fisica, che ha loro consentito di bruciare le generazioni successive, rimaste al palo, per così dire, sacrificate a logiche di gelosia e di invidia: i mediocri ne hanno potuto approfittare, ma questo ha impoverito non di poco le nostre comunità. La precarietà del lavoro, che costringe molti a non poter pensare il loro futuro; la «fuga dei cervelli», che dissipa le nostre forze migliori; le stesse prospettive di una Terza guerra mondiale a pezzi, che minacciano di diventare sempre più grandi, inquadrano un paesaggio che sembra davvero desolante.
Solamente uscendo dalle dinamiche regressive del proprio narcisismo, imparando a fare posto e a confrontarci con la realtà nel senso stretto del termine, e agli altri con le loro attese, bisogni, difficoltà, possiamo sperare di cominciare a uscire da quest’impasse o cono d’ombra al quale accennavamo. Ciò implica necessariamente il recuperare il senso della parola, come rappresentativa della res a me esterna, e non delle proiezioni del mio io, delle mie immagini del mondo e dei miei deliri. La parola, che non a caso nelle narrazioni bibliche è posta all’inizio come principio di ordine nel caos del mondo, è strutturante in una decostruzione sempre aperta e possibile qual è quella che stiamo vivendo. Questo costituisce anche il senso dell’esperienza degli adulti, in quanto autorevoli e non autoritari, deputati a consegnare ai loro successori nella catena della vita un itinerario di autentica e piena realizzazione. All’inizio, c’è sempre l’ascolto: delle parole degli altri, della Parola, che è il Cristo, via, verità e vita, proclamato dalla Chiesa e celebrato nei sacramenti, alleanza vera ed eterna per ogni generazione, anche per la nostra.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2024
Riproduzione riservata
***
[1]. M. Delpini, Autorizzati a pensare. Visione e ragione per il bene comune, Milano, Centro Ambrosiano, 2018, 9.
[2]. Lo studioso osserva che «i sistemi o piani di vita degli adolescenti sono colmi di sentimenti generosi, altruistici o fervore mistico, e tempestosi di una megalomania ed egocentrismo cosciente» (J. Piaget, Lo sviluppo mentale del bambino, Torino, Einaudi, 1967, 75).
[3]. Cfr M. J. Sandel, La tirannia del merito. Perché viviamo in una società di vincitori e di perdenti, Milano, Feltrinelli, 2020. L’autore osserva che l’ideologia del merito, e non il merito in quanto tale, finisce per colpevolizzare chi non ce la fa, senza sapersi far carico delle disuguaglianze di partenza. Del resto, è significativo che lo stesso linguaggio scolastico sia ormai clonato da quello economico, mostrando così un evidente appiattimento dello studente alla dimensione quantificante e valutativa, quindi economica, della sua performance: profitto, rendimento, crediti, debiti.
[4]. Una band tedesca, il gruppo ok.danke.tschüss, esprime questo sentimento, soprattutto giovanile, in un testo piuttosto significativo il cui titolo è appunto Ich poste, also bin ich («Posto, dunque sono»).
[5]. Il gruppo sopra ricordato afferma infatti: Durch den Bildschirm sieht man die Welt in einem anderen Licht.
[6]. Schau mal: ich bin am Strand («Guardami, sono sulla spiaggia»). Schreib mal in die Kommentare, aber bitte ruf nicht an («Scrivi nei commenti, ma per favore non chiamare»). L’isolamento, la solitudine sono coestesi a questo mondo, gli appartengono strutturalmente. Il testo continua così: Doch von über 1000 facebook Freunden hab ich keinen ja gesehen («Ma degli oltre mille amici di facebook non ne ho mai visto uno»).
[7]. Cfr P. Legendre, Della società come testo. Lineamenti di un’antropologia dogmatica, Torino, Giappichelli, 2005, 150.
[8]. Del resto, il diritto, con la creazione della persona giuridica, aveva già posto le basi di questo sdoppiamento del mondo, essendo la persona giuridica un ente che non esiste in natura: invenzione appartenente al mondo cristiano, che ha il suo princeps analogatum nella Chiesa come corpo mistico di Cristo, tanto reale quanto il singolo fedele. Così Sinibaldo Fieschi, divenuto papa con il nome di Innocenzo IV, giungerà alla creazione di un soggetto artificiale, una persona ficta, che esiste soltanto nel mondo del diritto, ma che qui ha un’esistenza perfetta e indipendente: cfr P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma – Bari, Laterza, 1996, 221.
[9]. Il testo della band tedesca continua: Ich will nicht hören was mein Kopf denkt. Er denkt mich ins Grab («Non voglio ascoltare quel che pensa la mia testa. Mi porta alla tomba»); Er ist nur still, wenn ich ihn ablenk. Darum lenk ich ihn ab («Lei, la mia testa, è silenziosa solo quando la distacco. Per questo la distraggo»); Es ist 4 Uhr in der Nacht, und ich bin noch wach. Ich schalt dich ein und ich schalte ab («Sono le quattro di notte, e sono ancora sveglio. Ti accendo [il cellulare] e stacco la spina [della testa])»; Hinter diesem Bildschirm kommt keiner an mich ran. Endlich mal ein Ort, an dem ich alles sagen kann («Dietro questo schermo nessuno può raggiungermi: finalmente un posto dove posso dire tutto»).
[10]. L. Zoja, La morte del prossimo, Torino, Einaudi, 2009, 13. L’autore vede la morte dell’altro proprio nel mondo virtuale, nelle immagini che sostituiscono la realtà.