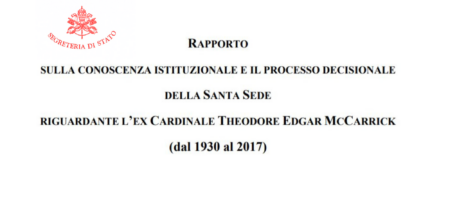|
|
Che cos’è la follia? La risposta a questa domanda può anche essere legata a un determinato contesto storico. «A volte, quando diventa difficile esprimere la doverosa indignazione dinanzi a soprusi e a ingiustizia, si ricorre a linguaggi estremi. Uno di questi linguaggi è quello della follia» (p. 7).
Questa antologia, curata da Lisa Cremaschi, monaca di Bose, raccoglie testi che raccontano la particolare esperienza dei «folli in Cristo», che assumono atteggiamenti da stolti non solo per ricordare il folle amore di Dio per l’uomo e «imitare il Cristo sofferente, umiliato, considerato folle, ma anche per smascherare la pazzia del mondo con il parlare e l’agire all’inverso del mondo» (p. 29) e per svelare l’ipocrisia degli uomini.
La follia per Cristo si diffonde in Oriente a partire dal IV secolo. Ogni «folle» la vive in modo particolare. Saba il Giovane la lega al silenzio. Il più famoso dell’antichità fu Simeone di Edessa, soprannominato «il Folle», che «per amore di Dio aveva finto di essere folle» (p. 67) e, dopo quasi quarant’anni trascorsi nel deserto, dice: «Vado a prendermi gioco del mondo» (p. 65). Lo svelamento della sua santità, come per gli altri folli in Cristo, avviene solo alla fine.
Questi asceti compiono gesti bizzarri di giorno, per richiamare l’attenzione del popolo sull’esempio degli antichi profeti, e si dedicano alla preghiera di notte, in estrema povertà e in solidarietà con gli ultimi. La follia diventa una maschera: Vitale di Gaza finge di essere traviato e dissoluto e porta il Vangelo nei postriboli.
I «folli in Cristo» vivono nel nascondimento. Giovanni il Calibita, come il romano Alessio, è mendicante nella sua casa, per combattere apertamente la tentazione della nostalgia degli affetti. Egli afferma: «Lo straniero è mio figlio!» (p. 53). Niceforo, prete di Santa Sofia a Costantinopoli, scrive una Vita di Andrea, ma «probabilmente crea dal nulla il protagonista della sua narrazione» (p. 96). Il fatto è che «sempre si tratta di racconti in cui la leggenda si mescola alla verità storica, la fiaba al grottesco e al ridicolo» (pp. 18 s). Il fine manifesto di tali scritti è infatti l’edificazione del lettore.
Nel mondo occidentale, la follia per Cristo si manifesta piuttosto in gesti episodici. Francesco d’Assisi, molto amato anche nelle Chiese d’Oriente, si definisce «novello pazzo in questo mondo» (p. 169). Giovanni di Dio, ascoltando le parole infuocate di Giovanni d’Ávila, ha una reazione spropositata e sembra fuori di sé: «Rinchiuso come pazzo, si comportò in modo tale da confermare la diagnosi» (p. 211). La compassione per i poveri sofferenti lo induce poi a dar prova di aver recuperato l’equilibrio mentale e a dedicarsi alla cura dei malati di mente. Invece Jean-Joseph Surin «fu veramente malato di mente, ma riuscì a vivere il suo viaggio attraverso la malattia mentale in comunione con Cristo» (p. 223).
Al di là dei limiti di storicità di alcuni dei fatti descritti, i profili di questi e di altri «folli in Cristo» tratteggiati nel volume portano il lettore a riflettere: ogni cristiano non deve forse essere un po’ folle agli occhi del mondo? Olivier Clément si domanda: «Il semplice fatto di tentare di essere veramente cristiano non è forse da sempre una follia?» (p. 32).
Follia d’amore. I folli in Cristo d’Oriente e d’Occidente
a cura di LISA CREMASCHI
Magnano (Bi), Qiqajon, 2020, 266, € 26,00.