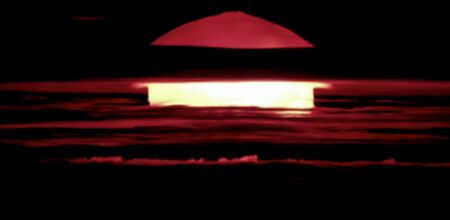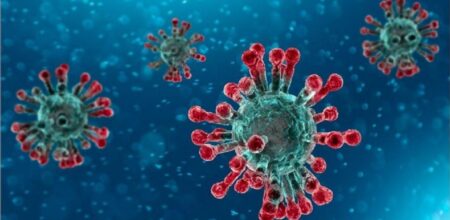|
|
Il titolo di questa raccolta di saggi non può che richiamare alla mente l’importanza che la luce, come concetto filosofico, ebbe nella vita religiosa e culturale del periodo medievale. Tra gli innumerevoli personaggi – Padri della Chiesa, teologi, filosofi, scienziati e, non ultimi, artisti – che si occuparono della luce in quel millennio, vogliamo qui ricordare solo Suger, il grande abate di Saint-Denis, che della luce – diretta o trasfigurata – fece uno strumento della gloria di Dio. Luce trasfigurata dalla policromia delle vetrate dipinte del nuovo coro dell’abbazia alle porte di Parigi, suntuoso mausoleo dei re di Francia, che egli fece costruire e che oggi rimane come straordinaria testimonianza del protogotico transalpino.
In effetti, l’architettura gotica è trionfo della luce, sulla cui presenza e manipolazione si fonda la sensazione di trascendenza e smaterializzazione che si prova entrando in una cattedrale, soprattutto del periodo rayonnant. Questo periodo viene chiamato rayonnant, «raggiante», per la luce che attraversa, trasfigurandosi, le grandi superfici di vetro che vanno sostituendosi alla muratura, come per smaterializzare la natura stessa dell’architettura, di cui rimangono soltanto gli elementi portanti essenziali (cfr la Sainte-Chapelle di Parigi, fatta costruire da Luigi IX).
Già da questi accenni si può intuire il collegamento concettuale tra arte, architettura e teologia, che nell’età medievale nasce e si sviluppa, fino a diventare uno dei temi centrali del pensiero cristiano.
Il libro si apre con un saggio di p. Dall’Asta sulla luce «naturalistica» – prendendo in prestito il termine dalla letteratura – dei grandi maestri del Seicento, in primis Caravaggio, che della luce diretta fa un elemento narrativo e, quando occorre, di intensità drammatica, come nel caso della Vocazione di san Matteo.
Gli aspetti fisici e la definizione che la scienza moderna dà della luce sono trattati da p. Gabriele Gionti, il quale in particolare esamina il passo di Gen 1,3, il fiat lux, la luce da cui prende le mosse la storia del mondo e dell’umanità.
Dopo la fisica, la metafisica della luce è affrontata da Roberto Diodato, soprattutto in relazione a Tommaso d’Aquino e all’interpretazione che ne diede James Joyce.
Jean-Pierre Sonnet ci propone una raffinata raccolta di testi biblici sulla luce, sempre intesa come manifestazione del divino e fonte di beatitudine e di salvezza.
Ma la luce è anche elemento portante della liturgia: di quella contemporanea e di quella delle origini, come mostrano i contributi di Giuseppe Midili e Maria Giovanna Muzj. Quest’ultima si sofferma sulle iconografie paleocristiane di Roma – dagli affreschi della catacomba di Priscilla fino al VI secolo –, mostrando l’importanza del testo dell’Apocalisse nella formazione della nuova arte cristiana.
Anche l’islam, nonostante il divieto di usare raffigurazioni antropomorfe – o forse proprio grazie ad esso –, considera la luce elemento essenziale nella progettazione delle moschee, dove sono documentate vetrate colorate, anche se non così ampie e complesse come quelle delle cattedrali cristiane, come mostra la relazione di Beatriz Laguillo Gutiérrez.
Il tema delle vetrate dipinte è trattato da César A. Suárez Cajamarca con uno studio su quelle di Antoni Gaudí nella cattedrale di Palma di Maiorca.
Lydia Salviucci esamina alcune opere di committenza gesuitica che sottolineano l’idea che sant’Ignazio di Loyola aveva della luce come esperienza mistica e come espressione del Corpus Domini. La centralità di questa idea è ben testimoniata dall’adozione del monogramma cristologico inscritto in un sole raggiante (ideato da san Bernardino da Siena e divenuto un vero e proprio «geroglifico cristiano»).
Marcello Fagiolo analizza le ricerche luministiche di Gian Lorenzo Bernini, basate sulla luce radente, la cui origine è nascosta all’osservatore, provenendo da finestre laterali, ed è volta a ottenere effetti magistrali di scenografia. L’intera opera dell’artista è attraversata dall’idea della luce: a partire dalla Cappella Cornaro con la Transverberazione di Santa Teresa d’Ávila, passando per la statua di Costantino, per giungere alla trionfale esplosione fiammeggiante della Cattedra di San Pietro, nella Basilica Vaticana. Dio è luce, e Bernini lo dimostra con tutta la potenza della retorica barocca.
Completano il volume un testo dell’architetto Franco Purini, che prende in esame alcuni aspetti dello spazio liturgico nelle chiese di età contemporanea; un contributo di Giuseppe Lanci sulla luce quale elemento emozionale nell’arte cinematografica; e uno scritto di Agostino De Rosa sul Roden Crater Project, land-formed work dell’artista contemporaneo James Turrell.
Dolce è la luce. Arte, architettura, teologia
a cura di LYDIA SALVIUCCI INSOLERA – ANDREA DALL’ ASTA
Roma, Artemide, 2019, 144, € 17,00.