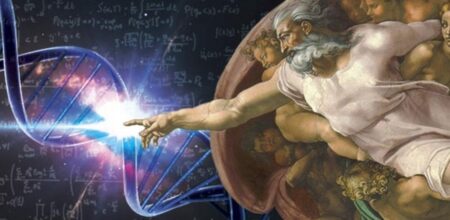|
|
Il cardinale Agostino Marchetto e il professore Angelo Federico Arcelli scelgono, ancora una volta, di vestire i panni di due abili pianisti intenzionati a eseguire un brano «a quattro mani». La melodia che si diffonde risponde alle categorie del «dialogo», ovvero un contrappunto tematico su teologia, economia, diritto canonico, geopolitica e scienze sociali.
Il primo capitolo – «Camminando insieme sulle orme del Vaticano II» – si presenta come un autentico esercizio ermeneutico delle acquisizioni dell’ultimo Concilio ecumenico autorevolmente condotto dal cardinale. La sua competenza si manifesta negli abbondanti richiami bibliografici inseriti nella trattazione. I contributi evocati e riconsiderati preparano così il fulcro della riflessione: il rapporto tra «sinodalità e primato», che viene presentato nel secondo capitolo. L’A. intende mettere in luce il valore di questo binomio mediante l’enunciazione dei prodromi di un’analisi comparata a livello interconfessionale, un approccio storico alle origini del rinnovamento postconciliare del concetto di «sinodalità» e non poche sottolineature di alcune prese di posizione sul processo di sinodalità, che oggi sta conoscendo una nuova primavera. Tuttavia il cardinale invita a interpretare questo nuovo processo, sia nel Vecchio sia nel Nuovo Continente, nell’ottica della continuità e della fedeltà rispetto alla lezione conciliare: non si dà sinodalità autentica senza riferimento alla comunione gerarchica e senza radicamento nel magistero delle costituzioni Lumen gentium e Gaudium et spes.
Nella seconda parte del libro, il professore Arcelli rilegge questo processo ecclesiale alla luce dell’incertezza che lo scenario internazionale lascia registrare. «Questo – scrive l’A. – si unisce anche a una crisi di valori – non solo e non tanto quelli ispirati a ragioni di fede – che, tuttavia, sembra, forse, più grave e complessa in Occidente, dove a un crescente distacco dai valori religiosi si unisce la percezione di una fase di crisi dello stesso modello laico di democrazia liberale» (p. 38). Il contributo etico che dal cristianesimo promana viene giustapposto all’apparentemente asettico dibattito sulla temperie economica globale.
Nel capitolo successivo – «La grande illusione» – Arcelli fa un’analisi dei princìpi che la Dottrina sociale della Chiesa tematizza in riferimento alla Comunità internazionale, in particolare sugli investimenti finanziari e il valore del denaro. «In anni non lontani è stato sostenuto che lo sviluppo dipendesse dall’isolamento dei Paesi più poveri dal mercato mondiale e dalla loro fiducia nelle sole proprie forze», affermò san Giovanni Paolo II nell’enciclica Centesimus Annus (n. 33) e, proprio insistendo sul binomio fiducia e leadership, l’A. mette in guardia dalle degenerazioni del decoupling economico e del liberalismo senza etica.
Nell’ultimo capitolo – «Come trovare una via di uscita all’incertezza?» –, l’incertezza prospettica che si manifesta nel sistema monetario internazionale assurge a tema principale. Afferma l’A.: «Per ritornare a un clima positivo e di fiducia, per poter guardare di nuovo al mondo in uno spirito di dialogo e pace, è essenziale tornare a una situazione in cui con credibilità vi sia una diffusa percezione di una stabile prospettiva per l’economia e per le relazioni tra Stati» (p. 64). Dopo aver rievocato la lezione di Gaudium et spes, n. 4, l’A., prendendo in esame alcune delle più significative azioni economiche varate dalla Bce, accosta la desiderata stabilità economica alle categorie sociali che rendono fluidi i nostri contesti, perfino morali, rischiando di soggiogare l’umanità a un’etica dell’utile, sia pure non utilitaristica. L’alternativa, d’altra parte, è vista nella prospettiva della Gaudium et spes, quale correttivo per le criticità ravvisate dall’A.
In conclusione, mentre scorrono le battute finali di questa ispirata «sonata a quattro mani», nelle orecchie dell’ascoltatore non inesperto echeggia il monito formulato nel Compendio di Dottrina sociale della Chiesa: «L’amore cristiano spinge alla denuncia, alla proposta e all’impegno di progettazione culturale e sociale, ad una fattiva operosità, che sprona tutti coloro che hanno sinceramente a cuore la sorte dell’uomo ad offrire il proprio contributo» (n. 6).