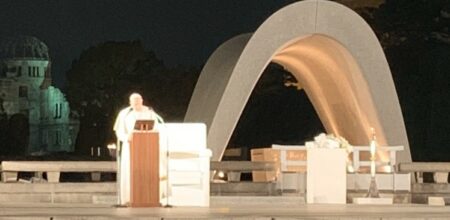|
|
Il secolo XIV in cui visse santa Caterina è conosciuto come il secolo della crisi dal punto di vista sociale ed ecclesiale. Nondimeno la peste e la carestia colpirono in maniera tremenda l’Europa. È in questo contesto che Caterina nacque a Siena nel 1347, insieme con una sorella gemella, che morì poche settimane dopo la nascita.
Caterina è nota soprattutto per il suo influsso nel ristabilire gli equilibri ecclesiali e per la sua dedizione verso gli infermi. Con il tempo, i suoi scritti sono stati riconosciuti e apprezzati per il loro valore teologico e mistico. Accostarsi a questo patrimonio di scritti cateriniani, così ricchi da una parte, e così lontani nel tempo dall’altra, richiede un certo salto qualitativo a livello umano e spirituale.
Il libro è diviso in 10 parti: «Proemio», «La dottrina della perfezione», «Inno della misericordia di Dio», «La dottrina del ponte», «La dottrina delle lacrime», «La dottrina della luce», «Il corpo mistico della santa Chiesa», «La Provvidenza divina», «L’obbedienza», «Conclusione».
Nella seconda parte del libro, il precetto «Ama il prossimo come te stesso» viene interpretato come il «donare la vita per la salvezza dei fratelli» (p. 39). È una visione della sofferenza molto concreta, e si traduce in un servizio offerto ai fratelli bisognosi. Nel rapporto con gli altri, continua Caterina, si migliorano le virtù e si riconoscono i vizi. «Tutti gli scandali, gli odi, le crudeltà e tutti i comportamenti cattivi hanno alla radice l’amor proprio» (p. 42). Questa affermazione di Caterina anticipa la visione del rapporto «io-tu» che verrà evidenziato da Martin Buber: rapporto nel quale l’altro funziona come uno specchio fedele dell’anima. Inoltre, esige un progresso continuo al livello umano e spirituale: è una chiamata universale alla santità e al compimento della missione personale nel concreto quotidiano.
Entrare nell’universo di Caterina significa riscoprire temi fondamentali della vita spirituale e dell’ecclesiologia odierna. Nella terza parte del libro, il concetto della misericordia del Creatore verso la sua creatura viene collegato, tramite «l’inno della misericordia di Dio», alle lacrime versate dall’anima che desidera la santità. Il Signore dice: «Figlia, le lacrime mi convincono perché sono unite alla mia carità, sono versate per amor mio e mi legano ai vostri sofferti desideri» (p. 59).
Nella quarta parte Caterina riprende l’opera di Giovanni Climaco La scala del Paradiso in forma cristologica. Viene presentata «la dottrina del ponte», in cui si considerano i tre stati o facoltà dell’anima: «Questo ponte, mio Figlio unigenito, ha in sé tre scalinate, due delle quali furono edificate sul legno della santissima croce e la terza pure quando egli sperimentò la grande amarezza nel bere fiele e aceto» (p. 76).
La realtà della sofferenza dell’uomo viene collegata al ponte della sofferenza di Cristo, in cui si comunicano all’uomo in maniera totale la misericordia e la carità di Dio e, nello stesso tempo, la capacità della sofferenza di Cristo di redimere e risollevare l’uomo dalla caduta originaria.
Le parti V, VI e VIII del libro di Caterina – «La dottrina delle lacrime», «La dottrina della luce» e «Il corpo mistico della santa Chiesa» – si connettono tra loro nel cammino della perfezione, caratterizzato dalla purificazione, dalla relazione con l’altro e dal gustare il mistero di Dio tramite l’Eucaristia.
Nella parte VIII si parla della Provvidenza divina, e nella parte IX l’obbedienza – soprattutto quella di Gesù, che ha unito il cielo con la terra – viene vista come la via privilegiata della perfezione spirituale.
La virtù della carità diventa la chiave centrale della lettura cateriniana, assieme a quella dell’obbedienza: due temi fondamentali che traggono la loro ispirazione e la loro origine dalla croce di Cristo.
CATERINA DA SIENA
Dialogo della divina Provvidenza
a cura di ANGELO BELLONI
Roma, Città Nuova, 2018, 470, € 17,00.