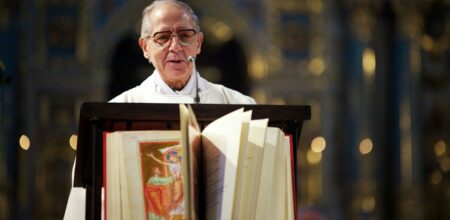|
|
Continua, con questo terzo volume della VIII sezione, l’edizione bilingue dello opere di san Girolamo, il più grande biblista dell’antichità cristiana, colui che ha rimesso in vigore il testo ebraico dell’Antico Testamento, traducendolo per la prima volta in latino. Prima di lui esistevano solo traduzioni latine fatte sulla Bibbia greca, detta «dei Settanta». Oltre ad aver commentato i grandi profeti (Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele), Girolamo ha voluto studiare anche i cosiddetti «profeti minori», che sono 12: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria e Malachia.
Il metodo esegetico di Girolamo è abbastanza facile da descrivere. Egli procede per versetti, raggruppati secondo un senso compiuto (a quel tempo non esisteva l’attuale divisione in capitoli e versetti). Anzitutto presenta la propria versione latina del testo ebraico, seguita dalla propria versione latina del testo greco dei Settanta. Segue il commento, che si divide quasi sempre in due parti.
La prima parte riguarda il senso «storico e letterale», con riferimenti alla storia d’Israele e con rilievi di carattere lessicale. Si fanno infatti confronti tra l’ebraico e il greco, con richiami alle altre versioni greche (Aquila, Simmaco, Teodozione e la Quinta). Questa è la parte più originale dell’opera di Girolamo, dovuta alla sua personale conoscenza dell’ebraico, e al contatto avuto con l’esegesi antiochena.
Nella seconda parte l’autore passa all’esegesi «tropologica o allegorica», detta anche «spirituale o mistica», più tipica dell’esegesi alessandrina. Essa è centrata sul mistero di Cristo e attualizza il testo al vissuto della Chiesa o dell’anima. In questo, bisogna dire che Girolamo ha poco di originale, perché non fa che seguire i precedenti commentatori, alcuni dei quali sono da lui citati (Ippolito, Origene, Didimo il Cieco, Apollinare di Laodicea). Questa interpretazione di fatto riproduce quella che era la lettura cristiana dell’Antico Testamento, e quindi rientra in gran parte nella comune catechesi. Tuttavia, l’accostamento tra i due tipi di esegesi sembra fatto da Girolamo in modo un po’ meccanico, e per la nostra sensibilità moderna appare quasi sempre una forzatura, anche se qualche volta giustificata da alcuni richiami presenti nel Nuovo Testamento stesso.
Le dense Introduzioni di Marco Tullio Messina, nel I e III volume, offrono tutta una serie di informazioni indispensabili sull’opera di Girolamo, come la data di composizione dei commenti, i dedicatari e la loro struttura. Inoltre troviamo importanti notizie sull’esegesi patristica dei profeti minori, sia di autori anteriori a Girolamo, sia posteriori (cfr vol. I, pp. 20-23; vol. III, pp. 24-28). Molto interessante è anche l’aver riportato l’interpretazione ebraica di quei profeti (cfr vol. I, pp. 26-30; vol. III, pp. 33-35), dato che Girolamo si riferisce spesso all’esegesi fatta dagli ebrei.
Meritano attenzione anche i prologhi e le conclusioni poste da Girolamo ai suoi commenti (cfr vol. I, pp. 30-33; vol. III, pp. 35-39). Nell’attualizzare il testo dei profeti alla vita della Chiesa, l’autore non può non menzionare gli eretici, che sono quelli tradizionalmente riconosciuti tali da tutti, e cioè, tra i più antichi, Marcione, Taziano, Montano, gli gnostici Valentino e Basilide; tra i più recenti, Ario, Aezio ed Eunomio (cfr vol. I, pp. 33-37; vol. III, pp. 40-44). È curioso che non ci sia traccia di polemica contro Apollinare di Laodicea, alla cui scuola Girolamo era stato e che aveva espresso idee cristologiche irricevibili. Noi avanziamo l’ipotesi che sia proprio Apollinare la persona presa di mira in Commento a Sofonia 3,14-18, dove l’autore critica «qualcuno dei cristiani, e soprattutto dei nuovi saggi (novorum prudentium), di cui taccio i nomi, per non sembrare offendere alcuno, che ritiene che la profezia non sia ancora adempiuta» (vol. II, p. 103). Apollinare infatti distingueva bene le due venute di Cristo: quella nell’umiltà e nel disonore e quella nella gloria.
GIROLAMO
Commenti ai profeti minori. Commenti ai profeti Abdia e Zaccaria
a cura di MARCO TULLIO MESSINA
Roma, Città Nuova, 416, € 70,00.