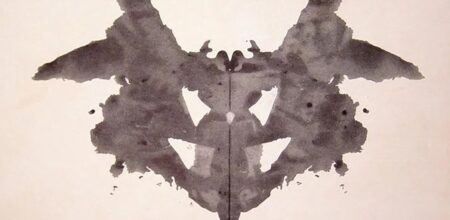|
|
Il premio Nobel 2021 per la letteratura è stato assegnato allo scrittore di origini tanzaniane Abdulrazak Gurnah, il quale, attraverso la sua prosa narrativa e storie che fanno eco alla sua esperienza esistenziale, si confronta con le dinamiche tensioni dei processi migratori derivati dalle politiche coloniali. La motivazione dell’Accademia di Svezia, infatti, sottolinea proprio questo aspetto: «per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato tra culture e continenti».
Abdulrazak Gurnah, che ora vive a Canterbury ed è stato professore di letteratura inglese e postcoloniale presso l’Università del Kent, all’età di 18 anni si vide costretto a fuggire in Inghilterra, come narra egli stesso in un articolo apparso in The Guardian: «Sono arrivato in Gran Bretagna all’incirca nello stesso periodo, sebbene non fossi asiatico. Venivo da Zanzibar, una piccola isola al largo dell’Africa, che nel 1964 era stata spettatrice di una violenta rivolta che portò a sconvolgimenti catastrofici. Migliaia di persone vennero massacrate, intere comunità espulse e molte centinaia imprigionate. Nel caos e nelle persecuzioni che seguirono, un terrore vendicativo governava le nostre vite. A 18 anni, l’anno dopo aver finito la scuola, fuggii. Molti altri fecero lo stesso; alcuni furono catturati e scomparvero, la maggior parte riuscì a mettersi in salvo»[1].
Sono gli anni degli aspri e violenti scontri dopo l’indipendenza di Zanzibar dal Regno Unito, sotto la presidenza di Abeid Karume, e per lo scrittore la città diventerà sempre luogo di memoria, di desiderio di ritorno, ma anche una ferita aperta difficilmente sanabile. Così nei romanzi di Gurnah si sente costantemente viva la tensione irriducibile causata dal colonialismo e dalle successive persecuzioni. Queste avvennero in nome di una libertà e un’autonomia che provocarono ingiustizie e violenze, con lo scopo di acquisire sempre più un potere politico ed economico. L’eco di tali dinamiche è spesso presente mediante i personaggi dei suoi romanzi: in Yusuf, il giovane protagonista del romanzo di formazione Paradiso, venduto come schiavo, che conoscerà le criticità di un continente – quello africano – soffocato dal colonialismo, o in Rashid ne Il disertore, che diventerà rifugiato in Inghilterra dopo la Rivoluzione di Zanzibar.
«Sulla riva del mare»
Sulla riva del mare (By the Sea), edito nel 2001, selezionato per il Booker Prize e finalista al Los Angeles Times Book Award, è stato pubblicato in italiano dalla casa editrice «La nave di Teseo»[2]. Già nelle prime pagine il protagonista mostra la profonda ferita esistenziale di chi è costretto a fuggire: «Voglio dire che non sono a conoscenza di una grande verità che muoio dalla voglia di insegnare, né ho vissuto un’esperienza esemplare che illuminerà le nostre condizioni o i nostri tempi. Ma ho vissuto, ho vissuto. È così diverso qui che sembra che una vita sia finita e adesso ne stia vivendo un’altra. Forse per questo dovrei dire di me che una volta ho vissuto un’altra vita da una parte, ma adesso è finita» (14 s).
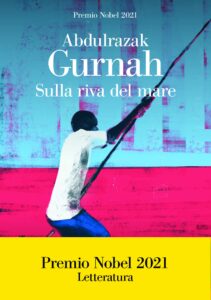
La ripetizione nel testo del verbo «ho vissuto, ho vissuto» è introdotta dalla congiunzione avversativa «ma», che indica proprio uno scarto rispetto alle vicende avverse che il protagonista ha dovuto affrontare e che solo apparentemente possono essere considerate totali naufragi esistenziali. Infatti, la ripetizione dell’esclamazione sottolinea la forza con cui il protagonista, nonostante i viaggi verso una personale «terra promessa» in cui affermare il proprio diritto di vita, nonostante gli ostacoli, i dinieghi, rimane legato alle proprie decisioni, che si concretizzano in un cammino estremo: egli parte da Zanzibar e raggiunge l’Inghilterra con un visto non valido. Questo aspetto della non validità del documento mostra anche il senso della forte cesura all’interno della sua esistenza: il visto pone il sigillo sulla prima parte della sua vita e ne condizionerà fortemente quella successiva.
Il diniego, come spesso accade, ha una forza tragica. Così, infatti, l’addetto alla sicurezza Kevin Edelman si esprime nel comunicare al protagonista l’impossibilità di continuare il viaggio: «Lei non è in possesso di un visto valido, non ha i soldi e non ha nessuno che possa garantire per lei» (25). L’avverbio di negazione «non» possiede l’asperità della roccia e costringe il protagonista a chiedere asilo, a dichiararsi rifugiato. L’espressione è seguita da una lapidaria descrizione dell’azione dei due personaggi: «Lui alzò gli occhi e io abbassai i miei» (25), immagine che esprime simbolicamente la condizione sottomessa di chi chiede asilo – come una colpa –, rinnegando la propria patria di origine e accogliendo uno stigma che si porterà impresso per sempre. L’inizio del romanzo così è già in medias res, con Rajab Shaaban, mercante di mobili, il cui nome si rivelerà preso a prestito da un altro personaggio entrato nella vita del protagonista: «Sono un rifugiato, uno che cerca asilo. Queste non sono parole facili, anche se l’abitudine di sentirle le fa sembrare tali» (18).
L’atteggiamento di Shaaban si fa sempre più guardingo e silenzioso, avendo appreso come durante l’interrogatorio sia meglio il silenzio – fingendo di non parlare inglese –, per evitare «il pericolo delle parole» (31). Infatti, all’interno dell’aeroporto, luogo di partenze e di arrivi ma non di soste, come sta accadendo al protagonista, tutto può divenire oggetto di sospetto. Anche i suoi pochi bagagli vengono sottoposti ad attenta indagine, e viene sequestrata una scatoletta con un incenso di oud-al-qamari, il profumo che arrivava da lontano, acquistato da un mercante persiano di nome Hussein, giunto con i venti monsonici. È un profumo ottenuto da una resina «che producevano solo le piante di aloe infettate dai funghi» (33): un profumo che nasce da un’infezione, immagine simbolicamente molto evocativa, che si addice a chi viaggia, si contamina, porta con sé differenti culture in cui si perdono cammini di popoli antichi.
Il romanzo è costruito attraverso una molteplicità di storie, che hanno relazione con il protagonista e che a volte vengono introdotte proprio dalla presenza di un oggetto significativo: una mappa, un tavolino d’ebano o, come si è detto, una scatola d’incenso. Attraverso questi oggetti si dipanano numerose storie, che comprendono non solo la narrazione delle esistenze dei personaggi interessati, ma anche le dinamiche coloniali dei Paesi europei che invasero le terre africane: rotte antiche di sangue e commercio, senza scrupoli, che depredarono non soltanto il suolo, ma anche l’umanità degli abitanti autoctoni, costringendoli spesse volte a fuggire e a emigrare.
Latif Mahmud e Saleh Omar
L’intreccio narrativo ha il suo inizio nel momento in cui il protagonista si incontra con l’interprete Latif Mahmud, originario anch’egli di Zanzibar, il cui padre si chiamava proprio Rajab Shaaban. Tra l’interprete Latif Mahmud e Saleh Omar – il vero nome del protagonista Rajab Shaaban – esiste una questione antica importante, che è causa ancora di profonda sofferenza: «Fu allora che vidi Saleh Omar camminare in mezzo ai frammenti e alle rovine della nostra vita» (163). Si scopre, infatti, che a causa di un affare non andato a buon fine la casa ipotecata della famiglia di Latif Mahmud era stata rilevata proprio da Saleh Omar.
Il confronto dialettico dei due protagonisti diventa un viaggio nel passato, durante il quale vengono raccontate e svelate le tante vite dei personaggi, le situazioni familiari, i viaggi, le relazioni complesse e le speranze di capovolgere il destino. E tra lo svolgersi di queste esistenze, la narrazione dà spazio agli avvenimenti politici, come l’interesse del presidente degli Stati Uniti John Kennedy, sottolineato dalla creazione, presso l’ambasciata, di una copiosa biblioteca di volumi di autori – tra cui Melville e Poe –, che si potevano leggere accompagnati dall’innovativa musica jazz. Ma presto gli Stati Uniti si ritirano, lasciando il posto alle mire politiche della Repubblica popolare cinese, in unione con la Repubblica sovietica e con quella democratica tedesca. Di conseguenza, anche le letture cambiano: Michail Šolochov, Anton Čechov ecc. Così Latif Mahmud stesso parte per andare a formarsi professionalmente nella Germania dell’Est.
Gurnah, con la sua prosa precisa, che alterna momenti di pacatezza e di delicatezza narrativa a momenti di durezza e drammaticità, è capace di raccontare le storie dei suoi protagonisti e dei personaggi legati a essi. Tutti sono accomunati da eventi dolorosi: alcuni causati dalle situazioni naturali, come malattie, morti; altri, invece, connessi con le situazioni di oppressione politica ed economica. Il potere economico, la spietatezza delle banche e delle strutture politiche governative, che non hanno alcun rispetto per la dignità e i diritti umani, opprimono con le loro regole il ceto più povero, causando violenze, fughe e prigionie, faide, che vengono sempre portate alle estreme conseguenze.
Saleh Omar e Latif Mahmud sono i superstiti di una lunga faida che ha segnato con il sangue le storie delle rispettive famiglie. La fuga per entrambi è stata la salvezza, e ora i rispettivi racconti, le confessioni particolareggiate delle loro esistenze diventano un luogo di incontro, anziché di scontro.
Conclusione
Per Gurnah il dialogo è l’unica alternativa all’odio che si tramanda di generazione in generazione. Gli infiniti dolori che si perpetrano nelle tante esistenze dei protagonisti, che sono umili eroi in quanto sopravvissuti alle ferite di un male che sembra non dare tregua, non sono sufficienti a sommergere quel «ma ho vissuto», espresso all’inizio del romanzo. E tutto questo peregrinare e cadere mette in moto anche quella pietas che è epica e decisamente umana: «A volte vedo foto di persone in difficoltà e l’immagine della loro infelicità e del loro dolore riecheggia nel mio corpo e mi fa soffrire con loro. E la stessa immagine mi spinge a reprimere il ricordo della mia oppressione, perché dopotutto io sono qui e sto bene mentre Dio solo sa dove sono alcuni di loro» (359).
Copyright © La Civiltà Cattolica 2022
Riproduzione riservata
***
[1] A. Gurnah, «Fear and loathing», in The Guardian (https://www.theguardian.com/uk/2001/may/22/immigration.immigrationandpublicservices5), 22 maggio 2001: «I arrived in Britain at around the same time, although I wasn’t Asian. I came from Zanzibar, a small island off Africa which in 1964 had seen a violent uprising that led to catastrophic upheaval. Thousands were slaughtered, whole communities were expelled and many hundreds imprisoned. In the shambles and persecutions that followed, a vindictive terror ruled our lives. At 18, the year after I finished school, I escaped. Many others did the same; some were captured and disappeared, most got safely away.»
[2] Cfr A. Gurnah, Sulla riva del mare, Milano, La nave di Teseo, 2021. Le citazioni riportate nell’articolo sono tratte da questo testo; viene indicato tra parentesi il numero delle pagine.
***
“ON THE SHORE OF THE SEA”, BY ABDULRAZAK GURNAH. Nobel Prize for Literature 2021
Abdulrazak Gurnah was awarded the 2021 Nobel Prize for Literature “for his uncompromising and profound analysis of the effects of colonialism and the fate of the refugee across cultures and continents.” In his novel On the Seashore, through the interweaving of stories from Zanzibar to the United Kingdom, he shows the complexity of human affairs, which are affected by wars, revolutions, flight and new hopes for rebirth.