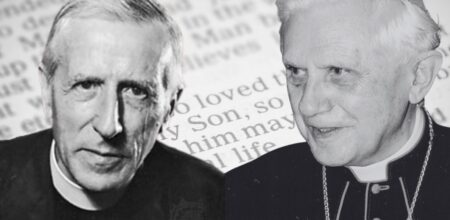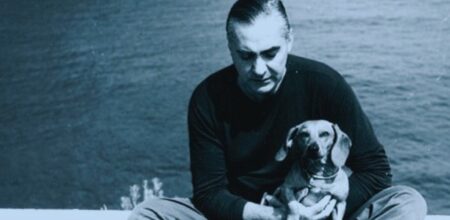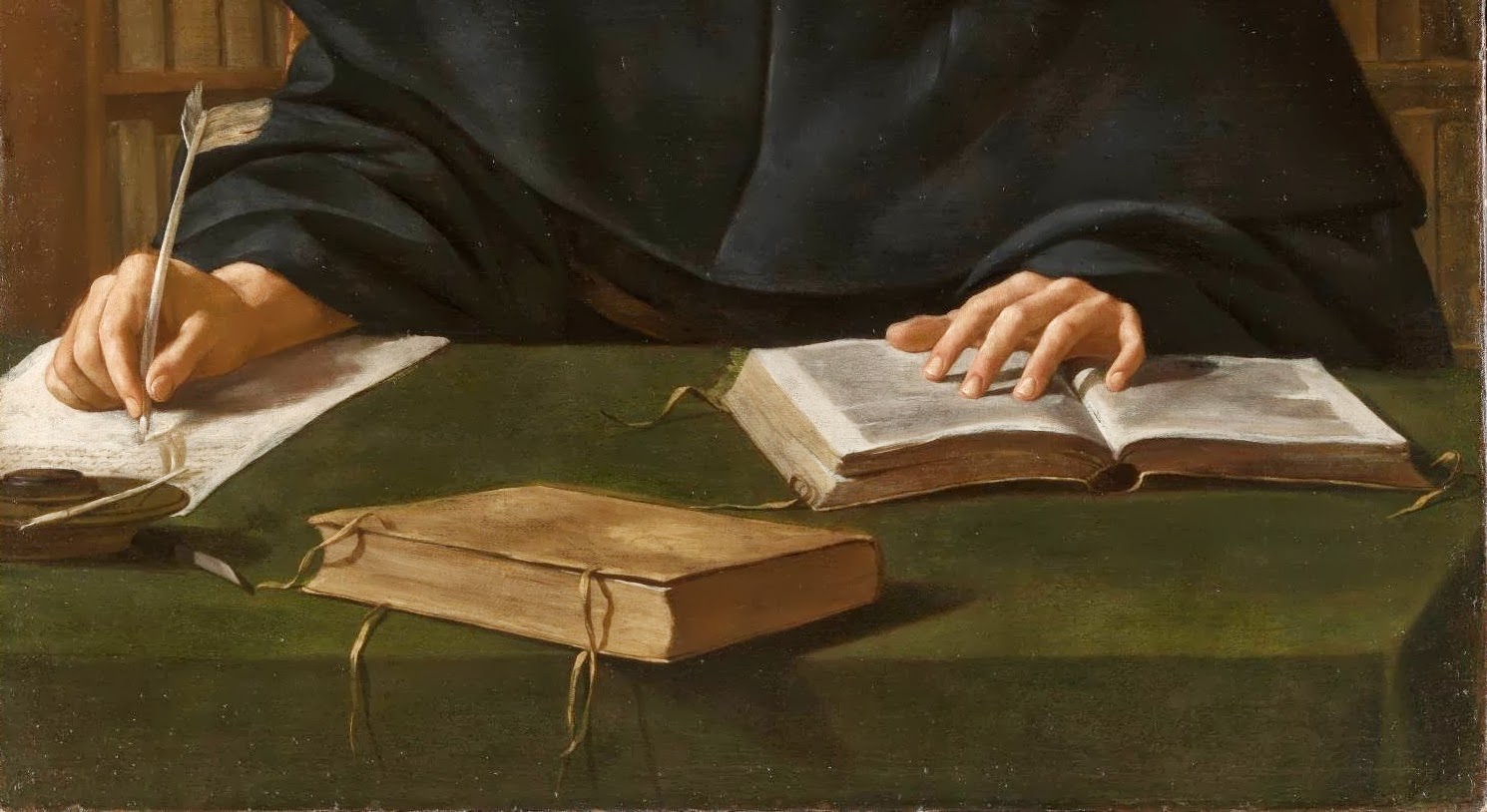
«Penso che lo studio della teologia assuma grandissima importanza. Un servizio insostituibile nella vita ecclesiale»1.
Lo scorso decennio di pontificato di papa Francesco ha significato un momento di straordinaria attività e di sfida per la Chiesa. Sia con il rinnovamento interno e con la sinodalità, sia con la spinta all’apertura apostolica verso altre fedi, sia contrastando i conflitti e le sempre più vaste conseguenze della crisi ecologica, il Papa si è preso cura della missione della Chiesa. Il suo stile pastorale e colloquiale semplice ha portato molti – tanto i sostenitori quanto i critici – a considerarlo un «pastore» piuttosto che un filosofo come san Giovanni Paolo II o un teologo come Benedetto XVI. Sebbene sia senz’altro vero che il suo stile è unico, sarebbe un errore sminuirlo e sottovalutare la profondità intellettuale e le intuizioni teologiche che formano il suo insegnamento e le sue azioni. Papa Francesco è il primo Papa non europeo dell’epoca contemporanea e, sotto molti aspetti, ci stiamo ancora adattando alle prospettive e alle esperienze che ne derivano.
Un aspetto poco riconosciuto del suo pontificato riguarda la sua visione della teologia, e il bisogno di rinnovamento che egli avverte affinché essa possa servire efficacemente la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Quanto giovano al servizio della Chiesa l’attuale stato della teologia e le varie scuole e metodologie teologiche che operano al suo interno? Ma non è questione di pluralità: c’è mai stata un’epoca in cui nella Chiesa non ci sia stato pluralismo teologico? Il pluralismo e la diversità non danneggiano la teologia cristiana, ma ne costituiscono un arricchimento. Sebbene sia necessario un attento discernimento, è evidente che una fede viva cresce e si approfondisce a contatto con le culture. Come stiamo imparando dal processo sinodale, la missione è una relazione reciproca: tutte le parti della Chiesa sono missionarie le une verso le altre.
Il problema riguarda piuttosto il luogo in cui la teologia formale oggi si svolge effettivamente, e al servizio di chi. A tal proposito, due ambiti culturali sono l’università e il seminario. Non c’è dubbio che molte facoltà di teologia lavorino a pieno ritmo, tanto nell’università quanto nei seminari, ma al centro della teologia formale sussiste un dilemma. Per metterlo in risalto, a rischio di qualche esagerazione, ci accingiamo a evidenziare che in entrambe le sedi operano due dinamiche piuttosto diverse, eppure ugualmente problematiche.
Nell’università, la teologia rischia di rimanere confinata all’interno delle proprie argomentazioni e
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento