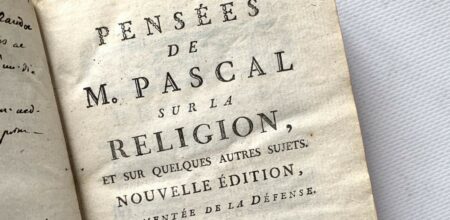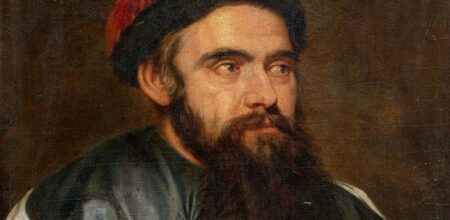I tempi di cambiamento accelerato, come il nostro, sono tempi di instabilità, accompagnati da crisi in molti ambiti della vita. Di fronte a questa esperienza, spesso drammatica, è difficile anche per noi formulare una parola significativa sulla nostra umanità condivisa. Allo stesso tempo, è anche nel cuore delle crisi che i nostri orizzonti si ampliano, permettendo l’emergere di una comprensione dell’umano, di nuove sintesi e riconciliazioni, di accostamenti inaspettati.
Più che di una sintesi teorica, abbiamo bisogno di una saggezza integrale e di «guide» che permettano a ciascuno di accedere alla propria umanità. È quanto ci propone il cardinale portoghese José Tolentino Mendonça, biblista e poeta: «Sentiamo il bisogno di una saggezza più globale, che non sia basata solo sulla facoltà mentale, ma sulla realtà totale del corpo e del mondo che siamo; una saggezza secondo cui le riflessioni sulle abitudini quotidiane o su un senso come il gusto non siano percepite come una deriva, ma come capaci di darci una più grande consapevolezza di noi stessi»[1].
Fondato su questa convinzione, un nuovo approccio teologico aspira a porre il patrimonio di umanizzazione scaturito dalla fede cristiana al servizio della costruzione di questa saggezza comune, in dialogo con i saperi legati al mondo del cibo: si tratta della «teogastronomia»[2].
Secondo questo genere di teologia sapienziale, l’approccio «gastronomico» alla nostra realtà umana può aprirci delle porte per comprendere il presente in modo nuovo. Infatti, in senso immediato, la gastronomia corrisponde al piacere della tavola: appartiene all’ambito della gioia e della gratuità.
A un secondo livello, già riflessivo, corrisponde «all’insieme dei saperi sulla costruzione del piacere nell’atto di mangiare»[3]; si tratta di una conoscenza culinaria ordinata: i racconti, la storia, i gusti, i valori di una persona e di un popolo.
Ma questi due livelli ci conducono a un terzo – quello che qui ci interessa –, rivelato dai frammenti di questa parola, quando prestiamo attenzione al suo significato etimologico: un’interrogazione gastronomica (da γαστήρ, gastér, «stomaco, ventre» + νόμος, nómos, «legge, norma») potrebbe manifestare una normatività propria delle viscere, facendo emergere testimoni discreti di ciò che è inscritto nella nostra carne e che spesso sfugge alla nostra parola[4]. Per la teogastronomia, questa realtà umana intima e profonda manifesta qualcosa del Mistero, assumendo così un valore teofanico[5].
Questo articolo vi propone di «assaporare» una riflessione di tipo teogastronomico, per confermare la sua fecondità umana e spirituale. A tal fine, vi
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento